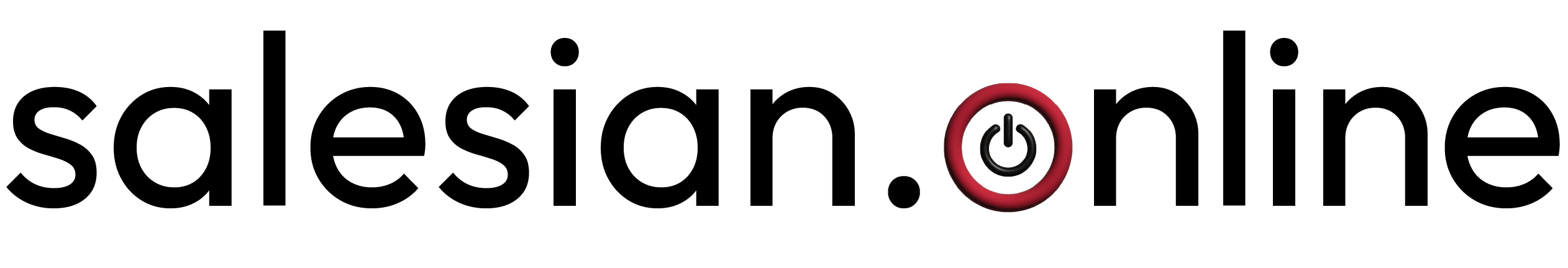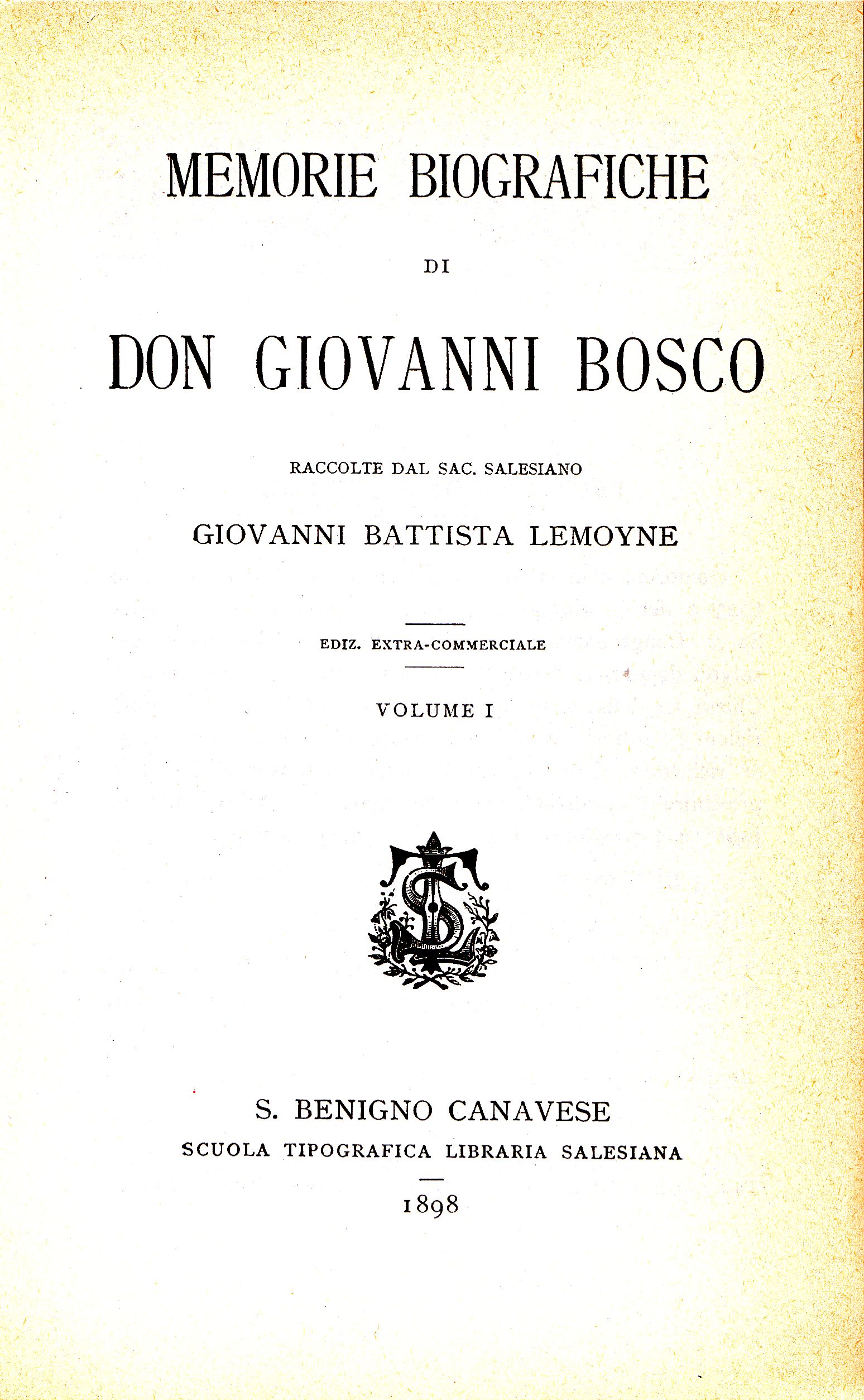Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco
raccolte dal sacerdote salesiano Giovanni Battista Lemoyne
(Giovanni Battista LEMOYNE voll. I-IX, Angelo AMADEI vol. X, Eugenio CERIA voll. XI-XIX, Indice anonimo dei voll. I-VIII e Indice dei voll. I-XIX a cura di Ernesto FOGLIO) Vol. I, Ed. 1898, 523 p.
PROTESTA DELL’AUTORE.. 4
PREFAZIONE.. 4
LETTERE D’INCORAGGIAMENTO.. 5
CAPO I. La guerra delle sêtte contro il Papato. 8
CAPO II. Margherita Occhiena, madre di D. Giovanni Bosco – Sua giovinezza – Suo carattere – Tempi burrascosi – Virtù esimie di questa donna. 12
CAPO III. Francesco Bosco modello dei padri di famiglia – Stato lagrimevole della Chiesa Cattolica e dei Parroci in Piemonte – Matrimonio di Francesco con Margherita Occhiena – Nascita di Giovanni Bosco – Morte del padre di Giovanni. 15
CAPO IV. Grande carestia in Piemonte – Strettezze di famiglia – La vedova cristiana – Sapienza di Margherita nell’educazione dei figli. 19
CAPO V. Il catechismo – Il pensiero di Dio – L orazione – La Prima Confessione – Il lavoro – Primi indizii della vocazione di Giovanni 21
CAPO VI. La saggia madre – I figli obbedienti – Il ritorno dal mercato – Il rendiconto. 23
CAPO VII. Correzioni – La prudente pazienza di una madre – I trionfi dell’amore materno. 25
CAPO VIII. La nonna – Rispetto ed affezione figliale di Margherita verso la suocera – Unità di governo nella famiglia – Giovanni intercede per il fratello presso la nonna. 28
CAPO IX. Margherita avvezza i figli alla nettezza, alla riflessione e ad una vita dura e mortificata. 30
CAPO X. Un cattivo negozio – I polli d’India rubati e lezione di prudenza – La guardia alla vigna – Il folletto e il fanciullo coraggioso 32
CAPO XI. Il pastorello diligente – Umiltà di Giovanni e sua mortificazione nel cibo – Suo esercizio di preghiera. 35
CAPO XII. I fratelli – Ritratto di Giovanni – Giovanni impara a leggere – La prima scuola a Capriglio – Il maestro D. Lacqua e progressi di Giovanni nella virtù – Giovanni perdona a chi lo insulta – Le prime sue prove in mezzo ai giovanetti. 37
CAPO XIII. I saltimbanchi – Giovanni si esercita nei giuochi di ginnastica e di prestigio – Un cavadenti. 40
CAPO XIV. Giovanni in cerca di nidiate – Avventure graziose e lezioni morali della madre – Giovanni cade da un albero con pericolo della vita – Suo dolore per la morte di un merlo e generosa risoluzione di staccare il cuore dalle creature. 43
CAPO XV. Fonti di questa storia – Un prezioso manoscritto – Il primo sogno – La missione di Giovanni. 46
CAPO XVI. Effetti del primo sogno – Sviluppo dell’ingegno e della memoria di Giovanni – Sua robustezza e forza prodigiosa – Alcuni aneddoti. 49
CAPO XVII. Trattenimenti di Giovanni coi fanciulli – I racconti – Le serate d’inverno Il piccolo saltimbanco e il suo primo Oratorio festivo – Col canto, coi giuochi e colle prove acrobatiche impedisce l’offesa di Dio. 51
CAPO XVIII. Mamma Margherita scuola di carità per Giovanni verso i poveri, i banditi, i pellegrini, gli infermi – La Provvidenza divina soccorre Margherita nella sua povertà – Santo fine col quale ospita i bisognosi. 55
CAPO XIX. Dalla mamma Giovanni apprende l’amore alla virtù e lo zelo per impedire l’offesa di Dio e procurare la salute delle anime. 58
CAPO XX. La morte della nonna – Giovanni è ammesso alla prima Comunione – Suoi propositi – Le prediche della missione – Incontro con D. Calosso – Memoria portentosa di Giovanni – Sue liete speranze per gli studi. 61
CAPO XXI. La scuola di Morialdo – Il chierico Giuseppe Cafasso – Suo abboccamento con Giovanni – Il fratello Antonio proibisce a Giovanni di continuare negli studi. 64
CAPO XXII. La virtù messa alla prova – Giovanni è mandato dalla madre a Moncucco – Per due anni è servitore di campagna – Ubbidienza ai padroni, diligenza nel lavoro, frequenza ai Sacramenti, perseveranza nella preghiera, buon esempio a tutti – Giovanni istruisce i fanciulli nelle verità della fede e nelle pratiche di pietà – Asserisce che un giorno sarà sacerdote – Oratorio festivo a Moncucco. 67
CAPO XXIII. Giovanni ritorna ai Becchi – Care memorie che lascia di sè alla Moglia Nuovi tentativi infruttuosi per ripigliare gli studi – Vita edificante in mezzo ai compagni – Le madri lo propongono come modello di virtù ai loro figliuoli. 72
CAPO XXIV. D.Calosso accoglie Giovanni in sua casa – Divisione dei beni di famiglia tra i fratelli Bosco – Morte di D. Calosso – Eroico disinteresse di Giovanni – Suo dolore per la morte del maestro e benefattore. 75
CAPO XXV. Margherita manda Giovanni alla scuola di Castelnuovo – Lo mette in pensione presso il sarto Giovanni Roberto – Giovanni si guadagna la simpatia dei compagni – Suoi progressi negli studi – Consolazione di sua madre – Come evita i compagni pericolosi – Continua la sua missione in mezzo ai giovanetti – Come vorrebbe il prete coi fanciulli. 77
CAPO XXVI. D. Virano si ritira dalla scuola di Castelnuovo – Gli succede D. Moglia – Scolaresca indisciplinata e tempo perduto – Pazienza di Giovanni – Impara la musica e il mestiere del sarto e del fabbroferraio – Sue industrie per le necessità della vita – L’albero della cuccagna. 80
CAPO XXVII. Giovanni alle vacanze – Singolare ricreazione nell’ora del riposo meridiano – Prima lettera pastorale di Mons. Luigi Fransoni, Vescovo di Fossano ed amministratore della Diocesi Torinese – Un secondo sogno – Giovanni è inscritto come studente nel Collegio di Chieri – Il parroco e i suoi compaesani lo provvedono per le spese della pensione. 83
CAPO XXVIII. Partenza di Giovanni per Chieri – Bontà dei professori – Le prime tre classi di grammatica – Aneddoti di non facile spiegazione. 86
CAPO XXIX. Prudenza di Giovanni nella scelta degli amici – Aiuta i compagni negli studi – Società dell’Allegria Pratiche di pietà – Fortuna di un buon confessore. 89
CAPO XXX. Giovanni conduce i compagni alla chiesa ed ai Sacramenti – Le passeggiate nei giorni di vacanza – Sua particolar divozione alla Madonna – Affetto per la famiglia – Morte di Paolo Braja – Giovanni ritorna a Castelnuovo. 92
CAPO XXXI. Giovanni ritorna a Chieri ed entra nella classe di Grammatica latina – Stima che ne hanno il professore ed i compagni – Sua umiltà – Ripetizione ai giovani chieresi – Riceve il Sacramento della Confermazione – Il Magistrato della Riforma e gli esami finali – Scuola domenicale a Morialdo – La prima Messa di D. Giuseppe Cafasso. 95
CAPO XXXII. Il pensiero della vocazione – Giovanni delibera di entrare tra i Francescani – A Chieri alloggia presso un caffettiere – Come impedisce i cattivi discorsi – Splendidi elogi della sua condotta – La scuola gratuita di latinità al sagrestano del duomo. 98
CAPO XXXIII. Il prevosto D. Dassano palesa a Margherita la decisione di Giovanni di farsi Francescano – Generosità della madre cristiana – Privazioni sofferte da Giovanni nell’anno di umanità – Sua riconoscenza verso chi aveagli dato soccorso. 101
CAPO XXXIV. Giovanni si presenta all’esame per essere accettato tra i Francescani – Sogno ed incertezze – Interesse che di lui si prendono alcuni Castelnovesi – Consiglio di D. Cafasso – Continua gli studi a Chieri. 103
CAPO XXXV. La carità di Giovanni verso i condiscepoli non ammette eccezione – Egli è l’anima dei divertimenti – Sfida col ciarlatano alla corsa, al salto, alla bacchetta magica e sulla punta dell’albero – Coi giuochi impedisce i discorsi pericolosi. 105
CAPO XXXVI. Lettura e studio dei classici italiani e latini – Amicizia di Giovanni coll’ebreo Giona – Lo converte al Cristianesimo 108
CAPO XXXVII. L’onomastico del professor Banaudi ed una disgrazia – Con uno splendido esame Giovanni finisce il corso di umanità – Suo incontro col Teol. Antonio Cinzano – Paterna affezione del nuovo prevosto di Castelnuovo per Giovanni. 111
CAPO XXXVIII. La classe di retorica – Luigi Comollo e sua relazione con Giovanni – Questi lo difende contro alcuni insolenti – Umile confessione – Begli esempi dell’amico. 113
CAPO XXXIX. Giuochi di prestigio – Giovanni è accusato di magia – Come si discolpa. 116
CAPO XL. Le vacanze pasquali – Giovanni va a Pinerolo e di qui a Barge dal Prof. Banaudi – Viaggio verso Fenestrelle – Un temporale e ritorno a Pinerolo, poi a Chieri – Lettera al Sig. Strambio – Giovanni è invitato a dar consiglio sulla vocazione. 118
CAPO XLI. L’affetto dei professori – Maravigliosa mutazione nei giovani, ai quali Giovanni fa ripetizione – Testimonianze di sua virtù- Sobrietà nel vitto Festa della riconoscenza- Ancora dubbio sulla vocazione – L’esame d’ammissione come chierico nel seminario – Le vacane – Caritatevole gara tra D. Cafasso, D. Cinzano ed altri Castelnovesi nel provvedere a Giovanni il necessario per entrare in seminario. 120
CAPO XLII. Vestizione cbiericale – Una festa poco gradita – Regolamento di vita – Entrata nel seminario di Chieri. 124
CAPO XLIII. La vita del seminario – I compagni – La frequenza dei SS. Sacramenti Tempo bene impiegato – Un altro sogno – Ricreazioni. 126
CAPO XLIV. Prontezza di Giovanni nel rendere servigio ai compagni – Sua piacevole compagnia – Gli antichi amici del ginnasio – Vigoria di Giovanni Gravissimo pericolo corso. 129
CAPO XLV. Giovanni riporta il premio – Visita i suoi antichi padroni alla Moglia – È proposto come assistente e ripetitore di lingua greca ai giovani del Collegio Reale ritirati a Montaldo – Si perfeziona nel greco – Ritorna in seminario Sua povertà. 132
CAPO XLVI. Luigi Comollo entra in seminario – Preziosi frutti di una santa amicizia Bontà, umiltà e pazienza di Giovanni coi compagni – Le visite degli studenti di Chieri – Il circolo scolastico e una santa lega per l’osservanza delle regole del seminario – Studii ne’ quali si occupa Giovanni – Stima ed affezione dei Chieresi – Due consolanti avvenimenti. 134
CAPO XLVII. Le vacanze del chierico Giovanni Bosco – Festino di campagna – Il suono del violino – La caccia – Modello di chierico in vacanza – Ripetizioni ad alcuni studenti – Lo studio della storia sacra, della geografia, dell’ebraico e del francese – Si ripete il sogno fatto a Morialdo – Predizione avverata. 139
CAPO XLVIII. Prima predica di Giovanni ad Alfiano – Sua passeggiata a Cinzano per visitare Comollo – Sua politica per far apparecchiare un pranzo – Novelle prove di sua memoria. 142
CAPO XLIX. Giovialità perenne di Giovanni Bosco – Cose da nulla – Una disciplina ridicola – Un cantore che perde gli occhiali – L’imbroglio di un sindaco – Adempimento di promessa. 145
CAPO L. Il primo corso di teologia – Altro attestato in lode di Giovanni – Suo amore per la storia ecclesiastica e per il Papa – Accademia letteraria fra i seminaristi – Giovanni Bosco infermiere – Le vacanze – Visite degli amici – Giovanni predica ancora ad Alfiano – Sostituisce il predicatore mancato improvvisamente a Cinzano ed a Pecetto – Altro discorso a Capriglio – Umile giudizio sulle sue prediche – Si reca nuovamente a Cinzano – Dialogo con Luigi Comollo – Presagi di morte – Vocazioni ecclesiastiche. 148
CAPO LI. Lo studio della teologia – Giovanni è fatto sagrestano della cappella – Preziose confidenze di Comollo con Giovani – Gli esercizii spirituali e il teologo Giovanni Borel – Comollo cade infermo – Sogno prima spaventoso e poi consolante – Sua santa morte – Sua prima apparizione. 152
CAPO LII. Solenne sepoltura di Comollo – Apparisce ad un’intiera camerata di seminaristi – Giovanni in vacanza – Giorgio Moglia – Presso il Teol. Comollo – Da D. Giuseppe. Cafasso – Dite fausti avvenimenti. 156
CAPO LIII. Infermità mortale e guarigione di Giovanni in seminario – È insignito degli Ordini Minori – Lettera del suo antico maestro D. Lacqua Predizione avverata – Una poesia per l’onomastico del prevosto – È colpito dal fulmine – Mons. Fransoni gli concede d’abbreviare di un anno il corso teologico – Giovanni predica in varie chiese – Sua lettera ad uno studente rimandato agli esami – Riceve il Suddiaconato. 159
CAPO LIV. Giovanni va ad Avigliana e predica sul S. Rosario – Visita la Sagra di S. Michele – Romantica passeggiata a Coazze – Festa a Bardella ed una sepolta viva – Riconoscenza di Giovanni verso la famiglia Moglia. 164
CAPO LV. Giovanni Bosco prefetto di seminario. – Splendido elogio del chierico Giuseppe Burzio. – Relazione fra questi due amici. – Avvicinamento di Giovanni all’Istituto degli Oblati di Maria Vergine. 167
CAPO LVI. Giovanni subisce gli ultimi esami di teologia – Magnifiche lodi a lui tributate dai condiscepoli – Gli esercizi spirituali in preparazione all’ordinazione sacerdotale – La prima Messa di D. Bosco – L’efficacia della parola – Sublimi ammonimenti di mamma Margherita. 170
PROTESTA DELL’AUTORE
Conformandomi ai decreti di Urbano VIII, del 13 marzo 1625 e del 5 giugno 1631, come ancora ai decreti della Sacra Congregazione dei Riti, dichiaro solennemente che, salvo i domini, le dottrine e tutto ciò che la Santa Romana Chiesa ha definito, in tutt’altro che riguardi miracoli, apparizioni e Santi non ancora canonizzati, non intendo di prestare, nè richiedere altra fede che l’umana. In nessun modo voglio, prevenire il giudizio della Sede Apostolica, della quale mi professo e mi glorio di essere figlio obbedientissimo. [VII]
PREFAZIONE
COLL’AFFETTO di fratello amatissimo presento ai cari Salesiani la biografia del nostro venerato Padre in Gesù Cristo, Don Giovanni Bosco. Viva era in tutti l’aspettazione di questo lavoro, che i Superiori mi avevano affidato, e godo nell’appagare in parte con questo primo volume il vostro giustissimo desiderio. Gli altri volumi verranno alla luce un dopo l’altro con breve interruzione di tempo.
Nulla omisi di quanto venne a mia cognizione. È un complesso meraviglioso di cose, nelle quali evidentemente si manifesta il dito [VIII] di Dio a nostro ineffabile conforto ne’ giorni presenti e a ravvivevamento di ferma fiducia nel tempo avvenire.
La narrazione è secondo verità. Siccome nel mondo ben pochi, io credo, siano stati riamati, come lo fu D. Bosco da’ suoi figliuoli adottivi, così questi lasciarono copiose memorie di quanto essi videro co’ propri occhi ed udirono colle proprie orecchie. Io stesso, dal 1864 al 1888, misi in carta quanto accadde di più memorabile. Molte cose le seppi dai lunghi, frequenti, confidenziali colloqui che ebbi col servo di Dio per ben ventiquattro anni e de’ quali non lasciai cadere parola. Tuttavia è da notarsi che non mai gli sfuggi un motto che alludesse alle splendide virtù dell’ingenuo suo cuore, mai un’espressione che affermasse essere egli da Dio favorito di doni soprannaturali. Però a queste sue reticenza frutto di profonda umiltà, supplirono ampiamente non solo quei che vissero al suo fianco, ma eziando le persone amiche, benchè estranee, e i cooperatori che in numero di centinaia e centinaia vennero a riferirci quanto sapevano, protestando molti di essere pronti a confermare con giuramento le loro testimonianze. [IX] Se non che, per quanto abbondante sia la materia da me’ raccolta, i fatti, i detti, le prove di virtù esimie, che vado tuttora mietendo in larga messe, mi fan rimpiangere la brevità della vita e mi persuadono ogni giorno più che inesauribile è l’argomento che io tratto. Perchè il mio lavoro possa dirsi intieramente compiuto, bisognerebbe che fosse terminato il processo canonico, istituito sulla vita di D. Bosco, e si potessero leggere e citare le deposizioni de’ testimoni giurati, cosa solamente possibile a causa finita. Ciò non ostante io spero che i salesiani da queste mie pagine potranno appieno riconoscere il loro buon Padre e rimanere soddisfatti dalle testimonianze quivi arrecate.
Non la fantasia, ma il cuore, guidato dalla fredda ragione, dopo lunghe disquisizioni, corrispondenze, confronti dettò queste pagine. Le narrazioni, i dialoghi, ogni cosa che ho creduto degna di memoria, non sono che la fedele esposizione letterale di quanto i testi ci esposero. Più di un capitolo potrà essere giudicato troppo prolisso, molti aneddoti soverchiamente particolareggiati, varii atti di virtù più volte ripetuti, ma distinti per circostanze di tempo e di luogo: ho pensato che facendo altrimenti, molte [X] notizie andrebbero irremissibilmente perdute, del che i miei confratelli si potrebbero giustamente lamentare. D’altra parte, io aveva ordine dal nostro venerando Rettor Maggiore D. Michele Rua di non ommettere nulla di quanto fosse venuto a mia conoscenza, per quanto si potesse giudicare in questo momento di lieve importanza. Vi è sempre tempo a togliere ciò che è superfluo, e la sintesi non riesce difficile, quando il soggetto è svolto razionalmente in tutta la sua ampiezza.
Mi sono intrattenuto eziando sui fatti che riguardano Margherita Bosco, la madre del venerato fondatore della Pia Società di S. Francesco di Sales riputando ciò indispensabile per ben tratteggiare la vita del figlio, specialmente nella sua infanzia. Le virtù infatti della madre rifiorirono splendidamente in D. Giovanni.
Il mio racconto è come di colui che parla in famiglia: il solo mio anelito è quello di poter rappresentare D.Bosco quale fu e riprodurne al vivo il ritratto, per quanto è possibile.
E’ per voi soli, o miei dilettissimi confratelli, che ora io scrivo: ma intendo che a questo libro non si dia pubblicità; che non se ne facciano traduzioni, ristampe, contraffazioni, [XI] compendii estratti per qualsivoglia fine; che non si consegni a persone che non siano membri della nostra Pia Società, perchè come a fonte attingano argomenti per stampare lodi a Don Bosco; e ciò finchè la S. Sede non abbia data la sua autorevole sentenza e il nostro Rettor Maggiore non abbia concesso licenza in iscritto. Lo pongo perciò sotto la protezione delle vigenti leggi. Per contentare poi le insistenti richieste de’ nostri alunni e di innumerevoli benefattori ed amici, verrà preparata un’altra edizione.
Miei carissimi confratelli! In queste pagine che parlano di D. Bosco fanciullo, studente, chierico, sacerdote, fondatore di oratori festivi, di ospizii di laboratorii, di collegi, di congregazioni religiose, di missioni apostoliche, sentiremo stimolo potente alla nostra santificazione e a quella de’ giovanetti alle nostre cure affidati, avremo la regola in ogni circostanza della vita nostra, un modello di tutte le virtù cristiane, sacerdotali e religiose. Troveremo il suo spirito, il suo cuore, il suo sistema educativo, la sua brama insaziabile, efficace di salvare le anime, e in ogni sua azione, in ogni suo pensiero l’attaccamento indissolubile alla Santa Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana ed al [XII] Vicario di Gesù Cristo in terra. Ci sentiremo sempre più accendere di affetto per l’incremento e la gloria della nostra Pia Società; di devozione e confidenza verso il nostro Rettor Maggiore Don Michele Rua al quale dedico questi volumi, che da lui ebbero ispirazione ed approvazione; di obbedienza generosa e facile allo stesso D. Bosco che continua a ripeterci colla sua lettera di estremo addio: Il vostro Rettore è morto, ma ne sarà eletto un altro, che avrà cura di voi e della vostra eterna salvezza. Ascoltatelo, amatelo, obbeditelo, pregate per lui, come avete fatto per me. Finalmente sentiremo farsi sempre più vivo nel nostro cuore l’affetto, la tenerezza, la riconoscenza per la Gran Vergine Ausiliatrice de’ Cristiani, la quale in modo meraviglioso si degnò guidare D. Bosco in ogni passo della sua vita, per darci prove inesauribili della sua bontà materna verso di noi.
Torino, 15 Agosto 1898
Festa di Maria SS. Assunta in Cielo.
Sac. Gio. BATTISTA LEMOYNE
della Pia Società
di S. Francesco di Sales.
LETTERE D’INCORAGGIAMENTO
A
DON MICHELE RUA
Padre Reverendissimo
Quanto più si diffondono le opere dell’Istituto di D. Bosco e tanto più si sente il bisogno di conoscere anche nei suoi particolari la vita del Sacerdote ammirabile fonda della Congregazione, che pare destinata a sopperire alle molteplici necessità del nostro tempo.
Io credo quindi che la P. V. Rev.ma farebbe opera assai fruttuosa col far pubblicare al più presto la vita di questo pacifico apostolo dei nostri dì, perchè rendendo manifeste le vie per le quali lo ha condotto il Signore, molti sarebbero indotti ad apprezzar maggiormente i doni del Cielo e ad accrescere la loro fiducia in quella Provvidenza, che sola può oberare tanti frutti di benedizione.
E nella speranza che questo mio desiderio per la maggior gloria di Dio sia presto soddisfatto, con profonda osservanza e riverente affezione mi confermo
Venezia, li 12 Agosto 1896.
Suo Obbl.mo Aff.mo come Fratello
D GIUSEPPE Card SARTO Patriarca. [XV]
Dilettissimo D. Rua,
Da Persona amica ho avuto l’assicurazione che è stata già condotta a termine la vita completa dell’immortale D. Bosco. Io ne godo grandemente Per l’onore che ne verrà a quell’anima virtuosissima e per la santa edificazione che ne deriverà a vantaggio dei fedeli e specialmente de’ sacerdoti. Pel vivo desiderio che ho di veder presto alla luce tale pubblicazione, mi rivolgo a Lei e grandemente la prego di rompere ogni indugio e di regalarci per le stampe l’opera anzidetta, dalla quale riporterà sommo giovamento la Congregazione Salesiana, alla quale degnamente ella Presiede. Con Particolare benevolenza e con Profondo ossequio mi dico
Bologna, 13 Agosto 1896.
Suo Dev.mo Servitore
DOMENICO Card. SVAMPA.
[XVI]
Ill.mo e Rev.mo Signore
Con grande consolazione ho saputo che si è dato termine al processo diocesano sulla fama di santità e sulle virtù di D. Bosco e che siasi scritta la vita completa di tanto uomo. Io ne sono contentissimo e desidero al più presto pubblicata la storia del medesimo, per essere meglio conosciuto. Ne interesso quindi lo zelo di V. P. Rev.mo e coi sensi della più distinta stima ho il bene di dirmi
Messina, 15 Agosto 1896.
Dev.mo Servitore
- Card. GUARINO Arciv.
[XVII]
Rev.mo Padre D.Rua,
Conoscendo Ella con quanto interesse io abbia seguito tutto ciò, che finora si è fatto per onorare degnamente la cara e venerata memoria di D. Bosco, potrà giudicare con quanta consolazione io abbia ricevuta la notizia, di essersi recato felicemente a termine presso cotesta Curia Diocesana il processo sulla fama di santità e sulle virtù di Lui. Ne ho goduto in me stesso, per la conoscenza personale che ebbi del pio D. Bosco; e me ne congratulo di gran cuore con la S. V. e con tutto l’onorevole suo Istituto.
Ora è a desiderarsi che presto siano rese di pubblica ragione le grandi virtù e le grandi opere di Lui; ed io sono sicuro che non tarderà molto a venire in luce una vita completa di questo servo di Dio. Ciò sarebbe di grande interesse per la continuazione della causa, dappoichè si moltiplicherebbero i voti e le preghiere di tutti i buoni fedeli per la gloria di Dio e per la venerazione del santo uomo sopra gli altari.
Accolga, Rev.mo Padre, questo mio suggerimento come prova del mio rispetto alla R. V. e del mio attaccamento alla onorevole Società Salesiana, mentre ho il bene di raffermarmi
Palermo, 15 Agosto 1896.
Dev.mo Servo e Osser.mo
MICHELANGELO Card. CELESIA.
[XVIII]
Riverit.mo Sig. D. Rua,
E’ gran tempo, da che molti desideriamo una Vita piena e completa, del gran servo di Dio Don Giovanni Bosco. Mi dicono che i Salesiani la stiano scrivendo, e certo lo faranno con diligenza ed amore. Ma perchè Ella non fa di affrettarne il compimento e la pubblicazione? L’apostolato di Don Bosco, che per molti rispetti rassomiglia a quello del mio amatissimo S. Filippo, si estende ora mirabilmente in tutta la Chiesa del Signore. E’ un apostolato popolare e assai confacente ai nostri tempi, del quale vediamo già frutti ubertosi.
Oggidì, se non m’inganno, questa fiamma nuova di carità cristiana dalle provincie settentrionali d’Italia comincia a diffondersi più largamente anche nelle meridionali. Se Ella potesse far presto conoscere, insieme con la Vita ammirabile del servo di Dio, che fondò i Salesiani, lo spirito di lui e il modo umile e facile con cui fondò le sue Opere, credo che ne verrebbe tra noi gran bene.
Oh quanto sarei lieto che questa mia lettera potesse in qualche modo giovare all’incremento delle Opere Salesiane, e però al bene delle anime ed alla cristiana prosperità del popolo minuto!
Preghi per me e la benedico.
Capua, 16 Agosto 1896.
Obbl.mo e Dev.mo
ALFONSO Card. CAPECELATRO
Arciv. di Capita e Bibl. di S. R. C.
[XIX]
Rev.mo Sig. D. Rua,
Che buon Pensiero quello di pubblicare una vita completa di D. Bosco! La intesi con vero piacere questa notizia da poco tempo e ci tengo a rallegrarmene con lei e farle conoscere il desiderio che si possa leggere presto una vita cosi edificante. L’opera di D. Bosco è veramente provvidenziale, massime tra i figli del popolo, ma credo che sarà più provvidenziale il far conoscere ampiamente la vita ai questo servo di Dio, perchè l’Opera Salesiana, che la Dio mercè va diffondendosi nel popolo cristiano, raccoglierà sempre più copiosi frutti, nutrita e confortata dagli esempi, dalle virtù e dallo spirito del suo fondatore.
Il Signore Iddio sia largo del suo aiuto a chi con intelletto d’amore si accingerà all’importante lavoro e ricolmi di sue grazie V. S. Rev.mo e tutta quanta la Salesiana Famiglia.
Aggradisca i miei ossequi e mi raccomandi a Maria Ausiliatrice.
Dal Sacro Monte sopra Varese, li 26 Agosto 1896.
Umil.mo Servo in Cristo
A.C. Card. FERRARI
Arciv, di Milano
CAPO I.
La guerra delle sêtte contro il Papato.
PRIMA di incominciare la narrazione delle preclare geste di D. Giovanni Bosco, mi sembra opportuno dare uno sguardo agli avvenimenti che funestarono l’Europa in sul fine del secolo XVIII e nella prima metà del secolo XIX. Questi si compendiano in un sol motto: Guerra al Papato. Principi protestanti, arricchiti delle spoglie della Chiesa, dominanti su nazioni che avevano apostatato dalla vera Religione, usurpatori della supremazia spirituale, si ostinavano nella superba ribellione contro il Vicario di Gesù Cristo. I Principi Cattolici, insofferenti di un’autorità che spiritualmente aveva su di essi giurisdizione, ad ogni istante pretendevano che il Papa tradisse i suoi doveri per obbedire alle loro prepotenze. La massoneria intanto, animata dallo spirito di Satana, co’ suoi adepti ebrei, protestanti e cattolici rinnegati, aveva giurato di cancellare dalla terra il regno e il nome di Gesù Cristo. E per giungere a questo scopo, mezzo più sicuro [2] giudicava togliere al Pontefice di Roma il potere temporale per vincolarne così la libertà e diminuirne, per quanto si poteva, l’azione sociale. Pronta a tradire e Principi e nazioni, riuscì a trarre a’ suoi disegni, o ad introdurre nei gabinetti dei Sovrani, perfidi consiglieri, i quali risvegliassero contro Roma le gelosie assopite e le facessero più vive se già accese. E la storia ci narra come fatalmente vi riuscisse, non ostante che il Padre dei fedeli, coll’affabilità del buon pastore e con amorevoli consigli, cercasse di trarre i Re da quella via che conducevali alla perdizione.
Ma venne il momento che una parte del popolo, corrotta e senza religione, si sentì più forte dei Re, i quali le aveano dato lo scandalo di ribellarsi a Dio. Primo crollò il trono di Francia nel 1793. E di ogni empietà e di tante infamie operatesi nella Repubblica francese furono i framassoni convinti complici dai tribunali della stessa Inghilterra protestante.
La tempesta, che minacciava l’Europa, non tardava a rovesciarsi sopra l’Italia, perchè qui era Roma. Per quattro anni i battaglioni austro-sardi impedivano all’esercito francese i valichi delle Alpi. In questo tempo Carlo IV Re di Spagna, che voleva Roma col paese all’intorno, per darla al suo genero il Duca di Parma; e Ferdinando IV Re di Napoli, che pretendeva per sè il Principato di Benevento e di Pontecorvo, non prevedendo le terribili conseguenze del loro stolto disegno, aprivano trattative col regicida ed ateo Governo di Francia per averne il consenso. In quel mentre Francesco II, Imperatore d’Austria, meditava d’impossessarsi delle tre Legazioni. Bologna, Ferrara e Ravenna.
Senonchè nel 1796 il generale Bonaparte, sconfitti gli alleati austro – sardi, penetrava in Piemonte, conquistava la Lombardia, Venezia e poi Genova; toglieva al Papa le tre Legazioni e la Marca d’Ancona, e mandati i suoi eserciti ad [3] invadere gli altri Stati italiani, partiva per l’Egitto. E il Direttorio fa occupare Roma nel 1798, la spoglia di tutti i tesori e delle opere d’arte, come aveva fatto in tutte le altre città; e Pio VI, condotto prigioniero a Valenza, vi muore il 29 agosto in età di 82 anni. “È l’ultimo dei Papi! gridano trionfanti i settarii; “Roma è nostra!”
Ma i popoli italiani, coll’aiuto della flotta inglese e degli eserciti russo ed austriaco, sollevansi contro gli oppressori che, scacciati da ogni luogo, solo in Genova trovano rifugio. E il Re di Napoli col suo esercito entra in Roma e occupa il Patrimonio dì S. Pietro, prendendone possesso in nome del futuro Pontefice appena fosse eletto, ma colla risoluzione di non restituire Terracina e Benevento; e gli austriaci, senza riconoscere i diritti del Papa, acquartierano le loro truppe nelle Legazioni, nelle Marche e nell’Umbria, ordinandovi un Governo proprio.
È breve però quest’occupazione. Il generale Bonaparte, ritornato all’improvviso dall’Egitto e fattosi proclamare primo Console, con poderoso esercito per la valle d’Aosta scende in Piemonte nel 1800, e sconfitta l’Austria a Marengo, la costringe a cedere al nuovo Papa Pio VII le provincie usurpate e nello stesso tempo impone ai napoletani di sgombrare da Terracina e da Benevento; ma ciò non per essere venuto a migliori consigli, sibbene per opportuna mutazione di politica. Per la pubblicazione del concordato avendo la Chiesa di Francia riacquistata la libertà di culto ed essendosi rialzata dalle sue immense rovine bagnate da tanto sangue generoso, Pio VII si reca a Parigi nel 1804 e incorona Imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte.
Vincitore di quasi tutta l’Europa nelle guerre continue dal 1805 al 1810, levatosi Napoleone sempre più in superbia, intima al Papa di rinunziare al potere temporale ed al [4] diritto inalienabile della istituzione dei Vescovi. Resistendo il Pontefice alle minacce e agli insulti dell’Imperatore e dei suoi ministri framassoni, Roma è invasa dai francesi, gli Stati papali sono dichiarati provincia dell’Impero; e Pio VII, nel 1809 condotto prigioniero prima a Savona e poi a Fontainebleau, per cinque anni soffre ogni sorta di angoscie morali, di infermità e di privazioni.
Senonchè la giustizia di Dio interviene a fiaccare i suoi nemici. Napoleone, perduta metà del suo esercito fra le nevi della Russia, assalito in Francia dagli eserciti di tutte le Potenze del nord, è costretto a scendere dal trono e ad accettare per sua residenza la piccola isola d’Elba, lasciando in libertà Pio VII, che rientra trionfante nella sua Roma il 15 maggio 1814.
E in che modo le Potenze europee, radunate a Vienna, cercano di riordinare gli Stati sconvolti? Secondo lo spirito, settario che le animava. Si dicevano campioni dell’ordine, ma erano colpevoli più o meno degli stessi errori, nei quali era caduto Napoleone, che in alcune circostanze potè dirsi migliore di esse. Infatti il ministro inglese Pitt, l’Imperatore di Russia, il Re di Prussia lo avevano replicatamente consigliato a far suo il progetto di Giuseppe II d’Austria e imporsi alla Francia e a tutti gli Stati annessi come unico Capo Supremo della Religione. Napoleone però aveva nobilmente respinta la perfida proposta.
La Chiesa pertanto in nome dell’ordine ebbe a soffrire ingiustizie senza numero. Infatti l’Austria voleva per sè le tre Legazioni; la Prussia insisteva perchè queste si dessero al Re sassone, in compenso della Sassonia che voleva per sè; l’ambasciatore di Toscana proponeva che Bologna, Ferrara e Ravenna si dessero alla Duchessa Maria Luigia, già Regina di Etruria. Il Congresso finiva con decidere che l’Austria tenesse per sue le terre ferraresi d’oltre Po, con diritto di [5] stabilire presidii a Ferrara ed a Comacchio. Oltre a ciò la Chiesa perdeva eziandio il Polesine ed Avignone. Tutti i vescovadi germanici, che prima erano principati indipendenti ecclesiastici, venivano assoggettati a Sovrani protestanti; il territorio del vescovato di Basilea unito alla Svizzera; e l’Inghilterra toglieva all’Ordine religioso di Malta la sua isola. Fu una esosa divisione di prede; il Papa protestò, ma invano.
In questo mentre in Italia le loggie massoniche divise in due partiti, le une istigavano Napoleone a fondare un regno italico con Roma capitale, le altre spingevano Gioachino Murat, Re di Napoli, promettendogli la conquista della penisola, purchè togliesse Roma al Papa: tutte pronte però a tradire l’uno e l’altro, se loro tornasse conto. Vani disegni. Napoleone, sbarcato in Francia, vi regnò soli 100 giorni; chè 800.000 guerrieri degli alleati, dopo varie battaglie, lo sconfissero pienamente a Waterloo, e dagli inglesi fatto prigioniero e mandato nell’isola di S. Elena, vi moriva nel 1823, dopo una dolorosa prigionia, durata quanto il tempo della cattività di Pio VII. E Gioachino Murat, invasi gli Stati Pontificii col proposito di far carcerare il Papa nella fortezza di Gaeta, veniva vinto dagli austriaci, scacciato dal suo regno, e finalmente fucilato il 13 ottobre 1815, per aver tentato di ricuperare il trono, sbarcando nelle Calabrie con pochi seguaci.
L’Europa sembrava che finalmente riposasse in pace; ma il dominio papale era sempre insidiato. Nel 1816 il ministro austriaco Metternich, favorendo ed aiutando certi amici dei suo governo nelle Legazioni, tentava preparare sommosse, per le quali alla morte di Pio VII gli fosse possibile d’impadronirsi di quelle provincie, unendole prima alla Toscana e poi al regno Lombardo Veneto. Fu il Cardinale Consalvi, che scoperse queste trame e le sventò, avvisandone l’ambasciatore francese. [6]
Nel 1817 assassini misteriosi pugnalavano qua e là negli Stati Pontificii persone fedeli al Governo. Le società segrete delle Marche avevano ordito congiura, risolute di sottomettersi a qualunque principe straniero, piuttosto che rimanere sotto al Papa. Si succedevano gli avvelenamenti e gli incendii. Con feroci propositi era stato fissato il momento della sollevazione, quando il moto intempestivo di quei di Macerata scoprì i congiurati, che in gran numero caddero in mano alla gendarmeria, ed ogni cosa pel momento ritornò in quiete[1].
Nel 1820 tutti i settarii d’Europa, aizzati dall’esempio di quelli di Spagna, che avevano ristabilita la Costituzione del 1812, costringendo Ferdinando VII a far la loro volontà, deliberarono di tentare una simile impresa nelle loro rispettive patrie, per aver agio di pescare nel torbido e di far guerra a Roma. E primo tumultuò l’esercito napoletano, nel quale molti ufficiali e soldati erano massoni. Il Re fu debole; concesse la Costituzione spagnuola, e poi spaventato fuggì da Napoli; mentre il Parlamento ordinava l’esercito per sostenere la ribellione. Ma fu sconfitto da 50.000 austriaci il 7 marzo 1821, e l’ordine venne ristabilito in tutto il regno.
In Piemonte il popolo non pensava a rivolgimenti, amando il suo Sovrano Vittorio Emanuele I, principe giusto, pio e di cuor; ma, per gli ordini dell’Alta Vendita di Parigi, alcuni nobili settarii e ambiziosi si radunarono segretamente in Torino nei palazzi degli ambasciatori di Francia e di Spagna e dell’Inviato di Baviera, per deliberare il modo di costringere il Re a concedere una Costituzione come la spagnuola. Essi erano in istretta relazione coi congiurati di Milano e coi settarii di Roma e di Napoli. Le decisioni prese furono [7] che, sgombrate le città lombarde dalle guarnigioni tedesche andate nel napoletano, l’esercito piemontese discenderebbe in Lombardia per soccorrere i rivoltosi, i quali si sarebbero affrettati a prendere le armi, e che in Roma si proclamerebbe la Repubblica. Ma la polizia austriaca, scoperte le trame sul fine del 1820, imprigionò i congiurati, che ebbero la sentenza di morte mutata in quella del carcere duro. Tuttavia gli studenti dell’Università di Torino, nei primi giorni del 1821, presero a tumultuare e le truppe adoperarono le armi con effusione di sangue. Vana repressione. Qualche milione veniva spedito da Ginevra per corrompere i soldati, e i presidii di Torino e di Alessandria si ribellavano. Carlo Emanuele nel marzo rinuncia alla corona in favore di suo fratello Carlo Felice, e 13.000 austriaci con 6.000 soldati piemontesi rimasti fedeli, posero termine ad una sedizione che era durata trenta giorni.
I settarii degli Stati Pontificii, per compiere la parte del programma loro affidata, ribellate Benevento e Pontecorvo, vi si erano insediati da padroni, dichiarando caduto il Governo papale. Formate bande, avevano corse le terre di Ascoli, gridando libera l’Italia e, al solito, rubando il danaro pubblico privato e aprendo le carceri ai malfattori; ma dovettero fuggire e nascondersi, poichè da nessuna parte potevano sperare aiuto. Continuavano però a maneggiare a tradimento il pugnale, facendo giungere minacce di morte ai Legati, ai Giudici e ai testimoni, perchè gli assassini non fossero castigati. I carbonari nell’articolo 33 del loro patto sociale avevano stabilito che, proclamata la Repubblica, la Religione della penisola unita sarebbe la Religione cristiana; la quale un concilio generale di tutti i Vescovi rieletti o confermati ristabilirebbe nella sua purezza primitiva. E nell’articolo 37 ordinavano: “Il Papa attuale sarà pregato di accettare la dignità [8] di Patriarca dell’Ausonia e riceverà, in compenso delle sue rendite, temporali unite al tesoro della Repubblica, una indennità personale, pagata annualmente sua vita durante.., che non potrà passare ai successori. Se dopo la sua morte il sacro Collegio dei Cardinali eleggerà un nuovo Papa, questi dovrà trasferire la sua sede fuori del territorio della Repubblica[2]„.
Pio VII, con Bolla del 13 settembre 1821, scomunicava la moltitudine di uomini scellerati, riuniti insieme contro Gesù Cristo, affigliata alla carboneria e alle altre società segrete.
I Sovrani d’Europa intanto, vedendo non solo in Italia, ma anche fuori, sorgere da ogni parte timori di ribellione, si radunarono a Verona nell’ottobre del 1822 per rimediare a loro senno a tanti pericoli. Il Duca di Modena Francesco IV consigliava ai Governi di proteggere la Religione; rialzare il prestigio della nobiltà; infrenare la stampa; diminuire il numero degli studenti nelle Università; allargare e rendere più rispettata l’autorità paterna; abbreviare i processi politici. Ma non fu ascoltato; quindi la rivoluzione e le sêtte crebbero appunto per la irreligione, per l’invilimento della nobiltà, per la licenza della stampa, per la negletta autorità paterna, e trovarono largo alimento negli innumerevoli avvocati senza clienti, bisognosi di torbidi per primeggiare colle chiacchere e coi brogli; nei medici, negli ingegneri, nei dottori di ogni fatta, senza censo, incapaci di lavoro materiale, inetti al lavoro intellettuale, i quali gettavansi alle sêtte, corrompevano innumerevoli giovani di eletto ingegno e commovevano i popoli per tentar fortuna. E le Potenze d’Europa credevano che a vincere le sêtte bastassero i patiboli e il terrore. [9]
Dal 1821 al 1830 le sêtte, che come una fitta rete aveano strette le Romagne, continuarono le loro geste, assassinando magistrati e cittadini; e quando il prelato Invernizzi le ebbe scoperte e disperse, ecco nel dicembre 1830 Luigi Bonaparte, che fu poi Napoleone III, figlio di Luigi ex Re d’Olanda, la cui famiglia respinta da tutti i regni d’Europa, era stata amorevolmente accolta da Pio VII, congiurava coi carbonari e liberi muratori per ristabilire il regno italico. Era suo disegno radunare i complici sulla piazza del Vaticano, assalire un luogo vicino ove erano molte armi, mettere a ruba il danaro del banco Santo Spirito, liberare i carcerati, prendere statichi alcuni maggiorenti della città, quindi ascendere il Campidoglio, formare una reggenza e annunciare il fatto alle provincie, perchè si unissero alla capitale. Ma il Governo, subodorati questi disegni, cambiava le guardie ai luoghi insidiati, imprigionava alcuni e cacciava da Roma Luigi Napoleone ed altri.
I settarii però riprendevano fiducia, quando Luigi Filippo, d’Orléans, animati i vecchi settarii colla sua protezione, nel luglio del 1830 aveva rovesciato il trono di Carlo X e le barricate in Parigi erano finite colla sua elezione a Re dei francesi. Perciò il 4 febbraio 1831 ritentarono la prova; e a Bologna, alzato il grido di viva la libertà, formarono un nuovo governo, mentre i capi delle società segrete percorrevano le Romagne per commuovere i popoli. Le Legazioni, le Marche e l’Umbria fecero causa comune con Bologna. Roma però si dichiarava contraria a questa fellonia. Luigi Bonaparte corse ad attrupparsi coi rivoluzionarii. Il Papa Gregorio XIV, sprovvisto d’armi, ne chiese al Re di Napoli, pronto a pagarle, ma Ferdinando II le rifiutò. L’esercito austriaco entrava allora negli Stati Pontificii, ed essendosi i massoni ed i ribelli affrettati a fuggire, i popoli stessi liberati rialzarono le insegne papali. Monsignor [10] Giovanni Maria Mastai, Arcivescovo di Spoleto, aveva aiutato nella fuga Luigi Napoleone, il quale gliene fu grato nel modo che tutti sanno.
Nel 1832 il partito massonico ripigliava ad agitarsi nelle Romagne, e gli austriaci ritornarono a muoversi verso Bologna e a spingersi fino a Ravenna. Il Governo di Francia, che aveva bandito il principio balordo del non intervento, col pretesto di non voler che l’Austria sola avesse merito di soffocare quella ribellione, contro il volere del Papa, mandò una flotta ad Ancona, fece occupare violentemente la città, vi si fortificò, liberò i prigionieri politici, diè protezione ai banditi e lasciò che impunemente questi, in numero di trecento, uccidessero il gonfaloniere, ladroneggiassero i cittadini, profanassero le chiese, disprezzassero e ferissero i sacri ministri, schernissero la religione, e formassero pestilenziali adunanze. L’Austria e la Russia si dichiararono pronte a far guerra alla Francia; ma Lord Palmerston, protettore dichiarato di ogni nemico ed offensore del Papa, approvò l’opera francese, intimò al Pontefice di dare riforme, ma poi tacque riserbando ad altri tempi il prendere l’aperta protezione dei ribelli in Italia. E però le due Potenze non si mossero, vedendo l’attitudine ostile dell’Inghilterra; e la Francia, smesse le prepotenze, si acconciò ad essere solamente il presidio e non la padrona della città, ritirando le sue truppe solo il 3 dicembre 1838, quando i tedeschi sgombrarono dal territorio pontificio.
Nel 1831 Giuseppe Mazzini, fondata una sêtta detta la Giovane Italia, stringeva i suoi adepti con terribili giuramenti di segreto, per rompere guerra contro ogni religione positiva e specialmente contro il Romano Pontefice, cui voleva in nome dell’unità d’Italia spogliare dei suo Stato, e poi, se gli fosse riuscito, toglierlo anche di mezzo, qualora non volesse acconciarsi alle leggi dategli. In pochi mesi la sêtta stendevasi [11] in varie provincie d’Italia, e Mazzini, che poneva sempre ogni sua cura nel non arrischiare la pelle, condannava a morte senza misericordia i settarii che non ubbidivano ai suoi mandati. Nel 1833 risolveva di fare entrare qualche migliaio di settarii in Savoia, corrompere le milizie piemontesi e con queste minacciare l’Austria, mentre l’esercito napoletano ribellato doveva correre su Roma, impadronirsi dei beni dei clero e dei nobili e proclamare l’Italia una e libera. Ma a Napoli la polizia scopriva e puniva i congiurati; in Piemonte ne venivano presi cento, duecento poterono fuggire e dodici furono archibugiati; e nel 1834 due centinaia di mazziniani, entrati in Savoia sotto il comando del generale Ramorino, vedendo che nessuno si univa loro, ritornarono alla corsa nella Svizzera, senza aspettare i soldati del Re.
E continuarono le sêtte a ordir congiure, con tumulti e omicidii, per annientare la Signoria del Papa, nel 1837, nel 1841, 43, 44, 45. Il furioso settario Ricciardi nel suo libro i Martiri di Cosenza scriveva chiaramente esser loro scopo scendere a Roma per annullare il Pontificato, ricetto d’impostura e d’infamia, che attrista ed appuzza la terra da diciotto secoli e più![3]. Ma le truppe erano fedeli, la polizia vigilante.
Falliti tanti conati, si vide chiaramente che, senza un esercito agguerrito, intorno al quale potessero raccogliersi le forze settarie, a nulla sarebbero riusciti i moti italici. Ma quale principe avrebbe dato ascolto al loro invito e con quali maniere lo avrebbero indotto a servirli? Massimo d’Azeglio additava loro Carlo Alberto e il Piemonte[4]. Col pretesto specioso e generoso dell’indipendenza d’Italia, si sarebbe [12] chiamata politica quella serie di falsi principii, di fatti compiuti, che avrebbero condotta la loro guerra contro Roma, contro il Papa, contro la Chiesa e contro Dio.
A questo punto erano portate le cose, quando compariva sulla scena del mondo D. Giovanni Bosco. Egli, a nessuno secondo nell’amare la prosperità e la gloria della sua patria, avendo compreso bene i suoi tempi, vide chiaramente a quali disastri l’avrebbe condotta la perturbazione di un ordine provvidenziale, che aveva posto in Italia la sede temporale e indipendente del Papato. La storia, da lui studiata con tanto amore, gli dimostrava, che ogni qualvolta i popoli si erano dichiarati avversarii del Vicario di Gesù Cristo, si erano pur sempre verificate le parole d’Isaia: Terra infecta est ab babitatoribus suis, quia transgressi sunt leges, mutaverunt ius, dissipaverunt foedus sempiternum. Propter boc maledictio vorabit terram[5]. Ed ecco perchè il programma di D. Bosco fu sempre questo: Tutto col Papa, pel Papa, amando il Papa.
CAPO II.
Margherita Occhiena, madre di D. Giovanni Bosco – Sua giovinezza – Suo carattere – Tempi burrascosi – Virtù esimie di questa donna.
MENTRE nero si addensava il turbine della rivoluzione sulla Chiesa Cattolica e lo sguardo umano esterrefatto non iscopriva raggio di speranza, l’occhio divino, che scruta i cuori, deliziavasi in contemplare migliaia e migliaia di anime, sconosciute al mondo, le quali colla preghiera e colla vita cristiana cooperato avrebbero a’ suoi trionfi sull’empietà. Erano desse le madri cattoliche, le quali, mettendo nel cuore dei loro figli il germe della santità, li avrebber fatti degni della missione per la quale Iddio li creava. Si leggano le vite dei Santi e si vedrà per regola generale chiaramente affermata questa verità. E il secolo XIX ha tale ricchezza di eroi cristiani, da non essere inferiore a nessuno dei secoli precedenti.
Una di queste anime, che Dio mirava con predilezione, fu certamente Margherita Occhiena, la madre di D. Giovanni Bosco. Sua patria fu Capriglio, paese di circa 400 abitanti, della Diocesi di Asti, posto in mezzo ad un piccolo altipiano circondato da vette di vaghe colline, in un territorio ricco di boschi, lontano sei miglia da Chieri. Nacque da Melchiorre Occhiena e Domenica Bossone il 1° aprile 1788, e nello stesso [14] giorno fu presentata al Sacro Fonte. I due genitori, di condizione contadini, discretamente provveduti di beni di fortuna, possedevano tuttavia la più grande di tutte le ricchezze, cioè il santo timor di Dio. Il Signore aveva benedetta la loro unione, e Margherita fu la terzogenita di cinque tra fratelli e sorelle. Gli esempi e gli ammonimenti del padre e della madre impressero in questi teneri cuori tale un sentimento del proprio dovere, che eziandio negli anni più caldi per fuoco di gioventù altro non vollero, se non ciò che voleva Iddio.
Paurose furono le prime impressioni che Margherita ebbe nella sua fanciullezza. Contava nove anni, e nel mese di luglio 1797 da Asti e da Chieri si udivano prolungati i rintocchi delle campane a martello. Gli emissarii francesi e i settarii piemontesi, protetti dall’ambasciatore di Francia in Torino, avevano sollevata a ribellione la feccia della plebe contro il legittimo Re Carlo Emanuele IV, proclamando il governo repubblicano. Ma accorrevano i contadini in aiuto delle regie truppe. In Chieri trenta rivoltosi furono subito passati per le armi, e nove altri per condanna subivano l’estremo supplizio. In Asti si eseguirono quattordici sentenze capitali.
Nell’anno seguente i borghigiani dell’Astigiano fremevano per rabbia, e nel segreto delle loro case imprecavano ai francesi, per avere costoro occupata la cittadella di Torino con prepotenza inaudita e costretto nei modi più villani il loro Re ad abdicare ed a ritirarsi in Sardegna; e nei primi giorni del 1799, rendendosi insopportabile il governo democratico, al grido di Viva il Re! si armarono e marciarono verso Asti. Ma i francesi di guarnigione facilmente li respinsero, li rincorsero nelle cascine e nei villaggi e moltissimi ne fucilarono presi colle armi alla mano. Quanti terrori e quanti lutti nelle famiglie! [15]
Poco dopo un’indignazione più grande, una compassione più viva trafisse i cuori cattolici. Passando per Casal Monferrato, Alessandria, Crescentino e Chivasso, nella notte dai 24 ai 25 aprile giungeva dalla Toscana nella cittadella di Torino Pio VI prigioniero, accompagnato da un commissario della Repubblica. In età di 82 anni, giaceva estenuato talmente di forze, da lasciar temere della sua vita. Era condannato dal Direttorio ad andare a Valenza nel Delfinato, attraversando le Alpi fra alte nevi e ghiacci e sull’orlo di orridi precipizii.
A questi dolori si aggiungevano le strettezze prolungate e persistenti, tra le quali vivevano le popolazioni del Piemonte, prima a cagione del proprio Sovrano, che necessitava di uomini e di danari per respingere gli eserciti francesi, e poi da parte dei francesi vincitori, bisognosi di tutto e avidi di ricchezze. La guerra incominciata nel 1792 era stata sospesa dall’armistizio di Cherasco il 28 aprile 1796. Fu un continuo esigere di tributi gravissimi, d’imposte straordinarie, di prestiti forzati, di doni gratuiti intimati con decreti, di multe dai comuni o dagli individui riluttanti, di enormi taglie di guerra. Eransi bandite leggi che diminuivano il valore della carta moneta, che confiscavano quasi tutti i beni ecclesiastici, che obbligavano i ricchi a comprare i beni nazionali. Le requisizioni di cibarie e vestiarii per le truppe, la scarsità di derrate, l’epidemia negli armenti e nelle popolazioni eran cagione di nuove angoscie.
La famiglia Occhiena risentivasi certamente di tante pubbliche sventure, ma la confidenza in Dio e la buona riuscita della figliuolanza le era di grande conforto. Margherita, alla scuola di sua madre e in mezzo a tante strettezze, dava sicura speranza di riescire un’eccellente massaia.
Benchè fanciulletta, aveva diviso tutto il suo tempo fra la preghiera ed il lavoro. La chiesa, ove andava a compiere i [16] doveri religiosi, coll’assistere alla Santa Messa, col frequentare i SS. Sacramenti, coll’ascoltare la parola di Dio, era il luogo delle sue delizie, il centro delle sue affezioni. Dalla natura era stata fornita di una risolutezza di volontà che, coadiuvata da uno squisito buon senso e dalla grazia divina, dovea farla riuscire vincitrice di tutti quegli ostacoli spirituali e materiali che avrebbe incontrati nel corso della sua vita. Regolando ogni sua azione secondo la legge del Signore, solo con questa poneva limiti alla sua libertà. Quindi, retta nella coscienza, negli affetti, ne’ pensieri, sicura nei suoi giudizi intorno agli uomini ed alle cose, spigliata nei suoi modi, franca nel suo parlare, non sapeva che cosa fosse esitare o temere in ogni incontro di leggiera o di grave importanza.
In una borgata vicina abitava un uomo, che tutti osservavano ed ammiravano per la straordinaria altezza e grossezza della persona, unita a regolari e belle forme. Quando egli passava per le vie, la gente usciva per vederlo ed i fanciulli gli tenean dietro come si suole a cose straordinarie. Il gigante era non poco annoiato da quella insistente curiosità, e un giorno che Margherita stava come incantata a contemplarlo, rivoltosi a lei e avvicinandosi: – Ma per bacco! esclamò; non son più padrone di me stesso? Non posso più andare ove mi pare e piace, senza essere da tutti osservato? Su, a voi! Non vi lascierò in pace, finchè non mi abbiate detto per qual ragione mi squadriate tanto da capo a piedi. – Margherita, senza ritirarsi nè scomporsi, gli rispose: – Per la medesima ragione, per cui un cane osserva stupefatto un Vescovo; e se vi può guardare un cane, con quanta maggior ragione vi potrò rimirar io, che in fine dei conti sono qualche cosa più di un cane. – Risposta ben franca per una giovinetta di quell’età! [17]
In tutte le sue azioni ella spiegava una simile energia. Un fatto abbastanza grazioso la dipinge al vivo. Nel 1799 l’esercito austro-russo, ritolta ai francesi la Lombardia, occupava il Piemonte in nome del Re di Sardegna, trattandolo però come paese dì conquista, cosicchè non fu mai visto tanto squallido come in quell’anno. Aumentavansi i tributi già esorbitanti, si chiamavano i giovani sotto le armi, si escludevano dai pubblici uffici, o si colpivano di ammende, o si incarceravano moltissimi, rei di aver parteggiato o per amore o per forza per la Repubblica. A Castelnuovo d’Asti, non molto distante da Capriglio, i gendarmi immanettavano il Vicario foraneo, D. Giuseppe Boscasso, e lo conducevano a Torino, con tre altri sacerdoti catturati in Asti, il Vicario generale, un Canonico e il Priore dei Serviti. Settanta preti, per accuse politiche, presi nelle loro chiese e alcuni mentre confessavano, incatenati a due a due, esposti agli insulti della plebaglia, a piedi, erano stati tradotti da Torino alla cittadella d’Alessandria. I viveri intanto scarseggiavano, il frumento costava l’enorme prezzo di 20 lire l’emina, e l’Austria vietava l’esportazione del grano dalla Lombardia. Per tutte queste cause gli abitanti della campagna avevano perduta la fiducia nei nuovi magistrati, che rappresentavano così male il governo del Re, e poco mancava che perdessero l’antico affetto per Casa Savoia: contro gli alleati però la loro irritazione era al colmo.
Margherita, benchè non sapesse odiare, non poteva non risentirsi della generale indignazione. Era il mese di settembre 1799, la stagione del raccolto della meliga, e questa stava distesa per disseccare al sole nell’aia innanzi alla casa Occhiena, quand’ecco giungere uno squadrone di cavalleria tedesca. I soldati fecero sosta nel campo vicino, e i cavalli liberati dai freni vennero in mezzo alla meliga. Margherita, che faceva la guardia all’aia, nel vedere quell’invasione nella [18] sua proprietà, alzando la voce, tentava di allontanare i cavalli spingendoti e percuotendoli colle mani. Ma quelle bestie poderose non si muovevano e continuavano a cibarsi avidamente di così lauto foraggio. Allora volgendosi imperterrita ai soldati, i quali al di là del fosso la miravano ridendo del suo agitarsi e de’ suoi vani sforzi, incominciò ad apostrofarli nel suo dialetto, perchè non facessero miglior guardia ai loro cavalli. I soldati che nulla capivano del suo linguaggio continuavano a ridere, ripetendo di quando in quando: – Ja ja.
– Voi ridete? proseguiva Margherita colle mani sui fianchi; a voi poco importa che i cavalli consumino il nostro raccolto, che vale quattordici lire e mezzo all’emina! A voi nulla costa questa meliga, ma noi ci abbiamo sudato attorno tutto l’anno! Che cosa mangeremo noi quest’inverno, con che cosa faremo la nostra polenta? È una prepotenza la vostra! Volete condur via sì o no questi cavalli?
– Ja ja, replicavano i soldati.
A Margherita, che intendeva benissimo come i soldati la mettessero in canzone, quel monosillabo dava ai nervi. Quindi a poco a poco si era scaldata. Alcuni soldati fattisi avanti le parlavano in tedesco, lingua che essa intendeva, come i soldati capivano il suo piemontese. Margherita allora, per rendere loro la pariglia, prese a rispondere con un altro monosillabo che in dialetto piemontese significa affermazione, ma in modo canzonatorio – bo bo! – S’intrecciò così un dialogo, nel quale si rinnovava la scena di colei che interrogata: dove vai? rispondeva: porto pesci. Nello stesso tempo veniva eseguito un magnifico duetto. Di qui si scherniva col ja ja, di là si ripeteva: bo bo; e il bo e il ja s’intrecciavano fra le risa sguaiate dei soldati. Margherita finì col perdere la pazienza e concluse: – Sì, sì: bo e ja, bo e ja; sapete voi che cosa fa? fa boia, quali siete voi, [19] che devastate i nostri campi e rubate i nostri raccolti. –
Era questa una dichiarazione di guerra in tutta forma. Margherita, vedendo infatti che le parole non giovavano e la sua meliga continuava a scomparire, corse a prendere il tridente e prima col manico incominciò a percuotere or l’uno ora l’altro cavallo; poscia, accorgendosi che non si risentivano di quelle offese, rivolse la sua arma e colle punte di ferro prese a punzecchiarli nei fianchi e a stuzzicarli nelle narici. I cavalli allora s’impennarono e fuggendo si allontanarono dall’aia. I soldati, che in altra circostanza non avrebbero in quei tempi di guerra lasciato il vezzo di spadroneggiare, andarono a prendere i loro cavalli sbandati e li legarono agli alberi di un prato poco lontano. Sarebbe stata infatti cosa ridicola venire a contesa con una ragazza di undici anni. Ma la vittoria riportata da Napoleone, primo Console, a Marengo, il 14 giugno 1800, costrinse gli austriaci a sgombrare dal Piemonte, il quale divenne provincia francese. I Subalpini ebbero pace. Da quei punto nessun esercito nemico invase più le loro terre. Le bande di briganti, composte di malfattori, di disertori dalle file degli eserciti, di gente fuggita dalle prigioni, che in tanto disordine civile stavano sicure di non esser colte, allora furono inseguite da ogni parte. Per più anni erano passate di comune in comune, quasi ogni giorno, rubando, incendiando, uccidendo. I contadini, pieni di paura, per andare da un luogo all’altro si univano in brigate e non si avventuravano ad attraversare i boschi in allora molto frequenti e molto estesi; non osavano lasciar sola la famigliuola in casa; e prima di sera si affrettavano al proprio focolare: nelle borgate piccole, come Capriglio, gli abitanti facevano talora la guardia bene in arme. Morte sicura v’era su chi fosse caduto in sospetto di delazione. Uno dei più terribili capi di quelle masnade era Mayno della Spinetta, [20] terra vicina ad Alessandria. I commissarii francesi, recatisi ad alzar tribunale nei luoghi più infestati, tanti ne incarcerarono ed inesorabilmente ne uccisero, che in tutto il tempo che durò l’Impero non vi fu alcuno che osasse ritentare le ladre imprese. Cessarono eziandio gli arbitrii inconsulti dei Prefetti alle provincie; la ferrea volontà di un uomo solo avea imposto ordine perfetto nell’esazione dei tributi e nelle amministrazioni dello Stato.
Avvenimenti mai più preveduti rallegrarono allora il cuore dei buoni piemontesi. Nel 1803 si celebrò in Torino il cinquantenario del Miracolo Eucaristico, accaduto nel 1453. Erasi ristorata splendidamente la Chiesa del Corpus Domini, e nella piazzetta innanzi alla porta si innalzò un ampio padiglione. Predicarono i migliori oratori, sfilò la processione col SS. Sacramento, portato da Mons. Valperga di Masino, già Vescovo di Nizza. Parteciparono alla solennità il Municipio e la guarnigione francese. La morte istantanea di un disgraziato nell’atto che insultava alla pietà dei torinesi accorrenti alla festa, da lui chiamata per dileggio del mulo, infuse terrore e più vivi sentimenti di fede in Torino e nella provincia.
Il 12 novembre 1804, Pio VII in viaggio per andare a Parigi ad incoronare Napoleone col diadema imperiale, passando per Asti giungeva a Torino, accolto con vivissimi applausi e feste. Ritornando da Parigi, vi rientrava il 24 aprile 1805, vi si fermava tre giorni e benediceva un popolo immenso dalla loggia del palazzo reale. La famiglia Occhiena, secondando l’impulso della religione e l’esempio dei terrazzani di tutti i paesi all’intorno, non doveva ristare dal recarsi a Torino per vedere il Papa. Margherita entrava allora nei 17 anni, e credo che in questa occasione ella si accendesse di quell’amore al Papa, che seppe poi così bene trasfondere nei [21] suoi figli. E questo divenne più tenero per la compassione che provò quando il 17 luglio 1809 Pio VII, strappato dal suo palazzo del Quirinale per ordine di Napoleone, scortato in una carrozza dai gendarmi a cavallo, sostava al mattino un’ora e mezzo nel Castello del Barone Rignon a Ponticelli tra Santena e Chieri, per poi avviarsi a Grenoble. Non poteva essere altrimenti in una giovane piena di fede e di costumi illibati, che era pure disdegnosa di cedere a qualunque rispetto umano.
Questa franchezza di carattere fu sempre una sicura salvaguardia alla sua virtù, perchè unita ad una prudenza che non lasciavate porre il piè in fallo. Bene spesso le giovanette sue amiche venivano nei giorni di festa ad invitarla a qualche amena passeggiata per quelle colline e per quei valloncelli. Sembrava loro cosa ben giusta un po’ di ricreazione dopo sei giorni di faticosi lavori. Margherita però non potea soffrire di trovarsi lontana dagli occhi de’ suoi genitori ed aveva, sempre in pronto la sua ragione per rifiutarsi a quell’invito. – Vedete! diceva alle compagne: la mia passeggiata io l’ho già fatta: sono andata fino alla chiesa. È una via abbastanza lunga, e non mi sento forze per andare più in là. – E per queste istanze e preghiere le facessero, non riuscirono mai a rimuoverla dal suo proponimento. Essa in quell’età non conosceva altra via fuor di quella che menava alla chiesa, dalla quale in vero era alquanto distante la sua abitazione.
Tutti sanno quali attrattive hanno per le popolazioni dei villaggi le sagre dei dintorni, e come la gioventù si lasci facilmente trascinare a prender parte, se non altro come spettatrice, alle danze che sogliono aver luogo in simili occasioni e protrarsi fino a notte avanzata. Non è mai abbastanza lamentato il danno che recano alla virtù queste profane costumanze. Or dunque alcune fanciulle di Capriglio, [22] spensierate ed avide di divertimenti, dopo essersi abbigliate il meglio che potessero e sapessero, andavano talora ad invitare Margherita. Alle loro voci essa usciva sulla soglia, e le amiche: – Vieni, Margherita, vieni in nostra compagnia. – Margherita le squadrava da capo a piedi, e dopo un oh! di meraviglia per i loro abbigliamenti, con un sorriso leggermente sardonico chiedeva: – E dove volete condurmi?
Al ballo! vi sarà tanta gente; vi è una bella musica; passeremo la sera allegramente! – Margherita si faceva seria e fissandole in volto rispondeva con queste sole parole: – Chi vuol giuocare col diavolo non potrà godere con Gesù Cristo! – Detta questa perentoria sentenza, ritiravasi in casa, lasciandole così sbalordite, che qualcuna, in vece di prendere la via della sagra, riprendeva quella della propria abitazione.
Ma sovratutto la buona figliuola era schiva di intrattenersi con persone di altro sesso. Alla domenica alcuni giovanotti aveano preso il costume di andarla ad aspettare sulla porta di casa, per accompagnarla allorchè usciva per avviarsi alla chiesa. Ciò le dava una gran noia, perchè sovente era costretta ad uscir sola, essendole stata affidata la custodia della casa, mentre gli altri della famiglia eransi recati in sull’alba a compiere i doveri del cristiano. Rincrescevale tuttavia usar parole scortesi con quegli importuni, conoscendo come a nulla avrebbero approdato, che anzi avrebbero dato loro appiglio per ridere e per berteggiare, e forse anche li avrebbero incitati a venir più numerosi sulla sua strada. Cercò dunque un ripiego che, senza farsi scorgere, la liberasse da quegli ineducati: usciva di casa molto tempo prima dell’ora solita. Per alcune domeniche le venne fatto di ottenere il suo intento; ma gli altri, conosciuta quell’astuzia, presero ad anticipare anch’essi la loro venuta. Margherita allora [23] pregò qualche buona donna delle vicine masserie a volerla accompagnare; ma tal fiata accadeva che costei, rattenuta a casa dai doveri di famiglia, non potesse prestarle quel servizio. Allora come fare? Margherita non si sgomentava per così poco. Non potendo schivare que’ ganimedi, salutata li risalutava, accettava l’offerta compagnia, e quindi si metteva a camminare con passo così rapido e risoluto, che gli altri erano costretti a seguirla correndo e facendo una ridicola figura presso quanti li vedevano. Stanchi e trafelati finivano con restare indietro dicendo: – Non vogliamo romperci i fianchi e i polmoni. – Margherita, ridendo in cuore del suo ritrovato, giungeva sola alla chiesa e, ascoltata la S. Messa, cercavasi tra la folla una compagna per ritornare a casa. La sua scelta cadeva quasi sempre sopra una vecchia, gobba, storpia, stizzosa, pronta a mostrare i denti a chiunque le desse noia e molestia, e messasi al suo fianco, rifaceva la via dei campi.
Si legge nell’Ecclesiastico: “Fórmati dentro di te un cuore di buon consiglio, perocchè altro non puoi averne più da stimarsi di questo. L’anima di una persona pia scopre talora la verità (nella pratica morale) meglio che sette sentinelle che stanno in luogo elevato. Ma sopra tutto invoca l’Altissimo, affinchè addirizzi i tuoi passi secondo la verità[6]”. Margherita, coi precetti del Catechismo, aveva corroborato il suo cuore e modellate le sue azioni secondo questi divini consigli, e riuscendo perciò ad evitare ogni pericolo, passò immacolata la sua giovinezza.
CAPO III.
Francesco Bosco modello dei padri di famiglia – Stato lagrimevole della Chiesa Cattolica e dei Parroci in Piemonte – Matrimonio di Francesco con Margherita Occhiena – Nascita di Giovanni Bosco – Morte del padre di Giovanni.
DISTANTE da Capriglio un’ora e mezzo di cammino, al Nordovest, nascosto tra ridenti colline, ai piedi di una di queste, riparato dai venti di settentrione, siede
Castelnuovo d’Asti. È cinto a levante dalle piccole borgate di Pino e di Mondonio; a mezzodì lo adornano feracissimi prati e campi; una collinetta lo divide a ponente da Moriondo e Lovanzito, terricciuole che gli stanno a poca distanza; e gli fanno corona preziosi vigneti. Conta cinque frazioni o villate: Morialdo, Ranello, Bardella, Nevissano e Schierone. Le case sono costrutte in gran parte sul dosso del colle, nel cui mezzo si innalza la chiesa parrocchiale. È lontano venticinque chilometri da Torino, alla cui Archidiocesi appartiene, e trentacinque da Asti. Capoluogo di mandamento per sette comuni, contava in quei tempi tremila abitanti, gente industriosa ed applicata al commercio che andava ad esercitare in varie città d’Europa. Le cave di gesso, che esistono nel suo territorio, davano al paese un notevole profitto. È assai piacevole il clima; vi si respira un’aria saluberrima, e nell’estate un [25] continuo e fresco zeffiro tempera i troppo cocenti calori. Il popolo, sotto un cielo bello e splendido, è di umore lieto ed aperto, di buona indole e assai cortese coi forestieri, i quali sono trattati con quella sincera ospitalità che generalmente si ammira in tutti i paesi dell’Astigiano.
Quasi a metà via tra Capriglio e Castelnuovo, sulla proda di un bosco, vi era un cascinale, composto di alcune case, detto i Becchi, del borgo Morialdo. Di una di queste casette, che, se non aveva l’aspetto di povertà assoluta, non dimostrava però di essere luogo di agiatezze, era proprietario un certo Francesco Bosco, nato il 4 febbraio 1784. La sua scarsa fortuna consisteva in alcuni piccoli poderi circostanti la casa, che esso stesso lavorava per vivere. Tuttavia, siccome questi non producevano abbastanza per sopperire a tutti i bisogni della sua famiglia, aveva preso a coltivare eziandio, come massaro, le terre attigue, appartenenti allora ad un certo Biglione, nelle quali aveva pur fissata la sua abitazione. Aveva seco la moglie, un figliuoletto di nome Antonio, nato il 3 febbraio 1803, e la vecchia madre, che trattava con tutti i riguardi imposti da una tenera pietà figliale. Era uomo di ottima indole, eccellente cristiano e fornito di un gran buon senso per l’istruzione religiosa, che si procurava col frequentare i catechismi e le prediche nella chiesa parrocchiale. La vera sapienza viene da Dio e insegna all’uomo a non perdersi in vani desiderii e a rimettersi pienamente ai voleri dell’amabilissima Provvidenza divina. Perciò “dolce è la vita dell’operaio contento di sua sorte, e in essa egli troverà un tesoro[7]”.
Tutto intento nei suoi lavori, quando meno aspettavaselo, cadeva inferma la sua compagna, che, assistita dal Vicario [26] foraneo D. Giuseppe Boscasso, quello stesso che era stato imprigionato e chiuso nella cittadella d’Alessandria nel 1800, munita de’ Sacramenti della Penitenza e dell’Estrema Unzione, spirava nell’ultimo giorno di febbraio del 1811.
E al dolore privato succedeva in questo stesso anno il dolore pubblico. L’11 novembre moriva improvvisamente il Vicario D. Boscasso nell’età di 74 anni, ed era seppellito nella chiesa così detta del Castello. Per Francesco, che era uomo tutto di chiesa, fu questa un’altra grande perdita. Nei paesi di campagna il parroco è naturalmente il padre, l’amico, il confidente, il consolatore de’ suoi parrocchiani. Egli conosce non solo ogni famiglia, ma i singoli membri di essa; e questi ogni volta che l’incontrano è col sorriso della gioia che lo salutano. I giovanetti furono da lui battezzati ed ammessi alla prima Comunione; una gran parte dei padri e delle madri innanzi a lui si promisero eterna fedeltà ed amore; i vecchi ai consigli della sua prudenza si appoggiano nel governare i loro dipendenti, e non di rado anche per reggere bene la cosa pubblica. Non vi è casa, nella quale non sia entrato per asciugare gli ultimi sudori dei morenti, innalzando i loro cuori colla speranza di un’altra vita felicissima, che non avrà più termine, temperando nello stesso tempo le angoscie dei superstiti. La nascita, la vita, la morte e la sepoltura di ogni individuo, come pure le gioie, i dolori e le miserie van sempre unite al ricordo del buon Pastore. Egli possiede i segreti di tutti e il suo divino ministero lo colloca sopra di tutti. La morte di un parroco è sentita come la perdita del capo di famiglia, e tronca relazioni, confidenze, affari gelosissimi in modo talora irreparabile.
Per la tristezza dei tempi, i cristiani più fervorosi pensavano chi mai sarebbe succeduto al defunto Vicario. Era stato promulgato il nuovo Codice, del quale Napoleone, che avealo [27] compilato, diceva essere un’arma potente contro la Chiesa. Dappertutto in Italia sorgevano e si dilatavano le loggie massoniche, favorite in ogni modo dal Governo imperiale. Dispersi erano i religiosi, chiusi i conventi, ai quali accorrevano con tanta fiducia i fedeli; confiscati e venduti i beni ecclesiastici. Il malcostume andava crescendo nelle popolazioni, e non si scorgeva quasi più nessuna vocazione ecclesiastica. La libertà dei culti dava all’errore gli stessi diritti inalienabili della verità: abolite erano le immunità ecclesiastiche; prescritto nei Seminarii l’insegnamento delle massime gallicane, lesive dei sacri diritti del Pontefice Romano; leggi speciali e severissime si emanavano contro quei membri del clero, che avessero disapprovato qualche atto del Governo; i Vescovi considerati come servi dell’Imperatore e sottratte alla loro vigilanza le scuole, perchè la mente dei giovanetti venisse informata secondo i politici intendimenti e le religiose aberrazioni di chi reggeva lo Stato. Pio VII si teneva prigioniero a Savona.
Oltre queste difficoltà di ordine generale, vi erano quelle inerenti all’ufficio di parroco, che richiedeva una grande prudenza e zelo apostolico. Doveva diffondere e spiegare un catechismo fatto compilare da Napoleone per tutte le Diocesi dell’Impero; catechismo pieno di inesattezze, di massime ereticali, di astute aggiunte, di non poche ommissioni, ed il quale indirettamente attribuiva al Sovrano l’autorità eziandio nelle cose di religione. Il parroco non poteva predicare direttamente o indirettamente contro gli altri culti autorizzati nello Stato. Eragli vietato dare la benedizione nuziale a chi non aveva prima contratto matrimonio davanti all’ufficiale civile. I membri della fabbriceria dovevano essere approvati dal Governo. Il Vescovo aveva bensì diritto di nominare e istituire il parroco; ma non poteva dare l’istituzione canonica, prima che questa nomina, tenuta segreta, non fosse presentata alla [28] approvazione imperiale per mezzo del ministro dei culti. E il parroco nominato non poteva andare in funzione, senza aver prestato il prescritto giuramento nelle mani del Prefetto.
Ma ritorniamo a Francesco Bosco. Egli era gravemente imbarazzato, non potendo, per l’urgenza de’ suoi lavori, assistere la madre e vegliare sull’unico suo figlio, che omai toccava i nove anni. Si risolse perciò a passare a seconde nozze. Recatosi sovente al paese di Capriglio, aveva conosciute le rare e casalinghe virtù di Margherita Occhiena.
Margherita non dimostrava nessuna propensione a prendere marito. Sempre occupata nei lavori domestici e di campagna, sempre ritirata e lontana da ogni sollazzo, rifuggiva dal trovarsi fra quelle allegre compagnie, alle quali prendevano parte nei giorni di festa eziandio le oneste persone. Omai contava 24 anni. Suo desiderio era di rimanere sempre così in casa, per assistere suo padre e sua madre nella vecchiaia. Il Signore però l’aveva destinata allo stato coniugale. “Una buona donna è una buona sorte; ella toccherà a chi teme Iddio, e sarà data all’uomo per le sue buone opere; sia egli ricco o sia povero, avrà il cuore contento e la faccia lieta in ogni tempo. La donna forte è la consolazione del marito, e gli fa passare in pace gli anni di sua vita[8]”. Francesco la chiese per moglie. Margherita, prima di dare il suo consenso, fece qualche difficoltà, manifestando la ripugnanza che provava nel dover lasciare la casa paterna. Il padre però approvava e consigliava quell’unione. Benchè fosse di età alquanto avanzata, dichiarava di sentirsi robusto in modo da non aver bisogno di alcuna assistenza. Una vigorosa sanità era il retaggio invidiato della sua famiglia. Esso infatti visse fino all’età di 99 anni e otto mesi; e suo fratello [29] Michele, più giovane, moriva vicino a compiere i 90. D’altra parte rimanevangli in casa altri figli ed altre figlie, specialmente una di nome Marianna, la quale proponevasi di prender cura della sua persona. Margherita, sempre pronta ad obbedire, sì rimise alla volontà del padre. Benchè non portasse agiatezze, quel partito era conveniente. “Egli è un gran capitale la pietà con il contentarsi di poco e vale più un pocolino col timor del Signore, che i grandi tesori, i quali non saziano[9]”.
Il Sacramento del matrimonio è grande in Cristo e nella Chiesa, ha detto S. Paolo, ed essendo Sacramento dei Vivi, si deve ricevere in grazia di Dio. Guai a chi incomincia il nuovo suo stato con un sacrilegio. È questa la cagione di tante sventure sulle famiglie, perchè il Sacramento ricevuto indegnamente è per esse come un peccato originale. Il sacrilegio porta la maledizione di Dio. Invece chi lo riceve santamente, ricordando che quest’unione figura l’unione divina di Gesù Cristo colla sua Chiesa, ottiene l’abbondanza della grazia e molte benedizioni eziandio temporali: benedizioni nel sostenere agevolmente il peso degli obblighi contratti innanzi a Dio, benedizioni nella pace della casa, benedizioni nell’aver il necessario per campar la vita e sovratutto benedizioni nei propri figliuoli.
A quei tempi, come pure ai nostri, in simili circostanze si facevano nei villaggi fragorose dimostrazioni di allegrezza, corteggi, conviti, spari, musiche; ma, prima di ogni altra cosa, non si mancava di fare una buona Confessione e una santa Comunione, e quindi, ricevuta la benedizione dal parroco, si dava e si riceveva l’anello ai piedi dell’altare e nel tempo del Santo Sacrificio. Così fecero Francesco e Margherita e, [30] dopo essere andati al Municipio, celebrarono le loro nozze nella parrocchia di Capriglio il 6 giugno 1812. Da quel punto furono esatti osservatori del gran precetto di S. Paolo: “Ognuno di voi ami la propria moglie come se stesso: la moglie poi rispetti il suo marito[10]”.
Margherita, entrata nella sua novella casa di Morialdo, tenne subito il piccolo Antonio per suo, e questi così ebbe una madre che sostituiva l’estinta, e non una matrigna, come molte volte suole accadere ai poveri orfanelli. Il giovanetto però, benchè così accarezzato, pare che per ragioni d’interesse non vedesse bene il secondo matrimonio del padre.
Intanto di questi stessi giorni, l’11 giugno, una carrozza partita da Savona attraversava a gran carriera i piani d’Alessandria; era in essa rinchiuso quasi agonizzante Pio VII, da tre anni prigioniero di Napoleone. Accompagnato da un commissario imperiale, attraversava incognito le colline dell’Astigiano, toccava Stupinigi, ed entrando in Francia pel Moncenisio, giungeva a Fontainebleau, ove angoscie amarissime aveagli preparato il suo persecutore. Passando il santo Pontefice, benediceva certamente i piemontesi, sapendo quanto a lui fossero affezionati. E quando Margherita ebbe notizia del suo passaggio, non avrà chiesto a Dio che questa benedizione le fosse di sostegno nel suo nuovo stato?
Margherita era felice, perchè “la mente tranquilla è come un perenne convito[11]”. La vecchia madre di Francesco, che portava il suo stesso nome, aveala accolta con festa indicibile e avea riposto in lei tutta la sua affezione e la sua confidenza. Margherita contraccambiava la suocera con amore ed obbedienza figliale. Questi due cuori fin dai primi [31] giorni si erano perfettamente intesi. Avevano le stesse inclinazioni e di lavoro e di economia e di carità, lo stesso sistema nel regolare le faccende domestiche, gli stessi principii nell’educare la famiglia. La madre di Francesco, sotto vesti contadinesche, era una vera matrona per nobiltà di sentimenti, fermezza di volontà, e slancio nell’amare e fare il bene.
Il Signore benedisse l’unione di Francesco e di Margherita, e gli 8 aprile 1813 vennero rallegrati per la nascita del primogenito, al quale fu imposto nel santo Battesimo il nome di Giuseppe dal nuovo Vicario D. Giuseppe Sismondo, che aveva preso possesso della parrocchia negli ultimi giorni di agosto 1812.
La gioia però non era senza lacrime ed apprensioni per lo stato miserando della patria. Le chiese erano squallide e spogliate di ogni ornamento prezioso e di opere d’arte. Mute nei giorni di festa le sacre torri delle loro confortanti armonie, perchè a migliaia le campane erano state fuse per fabbricare cannoni. I preti invecchiati, impoveriti e sorvegliati dalla polizia. L’esattore inesorabile nel riscuotere le imposte. Le madri si scioglievano in lacrime per la partenza dei lori figli destinati al servizio militare. Dal 1805 in poi continue avevano imperversate le guerre, benchè lontane. Moltissimi giovani italiani erano caduti combattendo contro la Germania; 20.000 in Ispagna, 15.000 nella ritirata di Russia. In quest’anno tutto il nord dell’Europa erasi collegato coll’Inghilterra contro Napoleone, e tutti i giovanetti sui diciotto anni furono costretti a prendere le armi e andare in Francia per essere macellati in difesa di quel despota, che un giorno li aveva definiti carne da cannone! E nelle chiese il popolo doveva sentir cantare: Domine, salvum fac Imperatorem nostrum Napoleonem! [32]
Le preghiere dei buoni continuarono intanto a salire al trono di Dio chiedendo perdono, e Dio misericordioso spezzò il flagello, che percuoteva le nazioni. Il 1815 portò pace e riposo all’Europa. Napoleone rilegato per tutto il restante di sua vita in mezzo all’Oceano, nell’isola di S. Elena, riconobbe, novello Nabucodonosor, che solo Iddio dà e toglie le corone imperiali e reali.
Pel Piemonte fu un anno di tripudii celesti. Tutte le leggi oppressive della Chiesa vennero abrogate. Pio VII, andato a Savona, alla presenza del Re Carlo Emanuele I, risalito sul trono dei suoi padri il 20 maggio dell’anno precedente, circondato dai Vescovi, in mezzo al concorso d’innumerabile gente, incoronava la Madonna della Misericordia per Genova, Novi, Voghera, Moncalieri, giungeva all’improvviso in Torino. Era il suo settimo viaggio nei paesi subalpini. Non è possibile descrivere il trionfo d’amore, col quale fu accolto dalla Real Casa di Savoia e dal popolo festante, nè la solennità colla quale la Santa Sindone fu presentata all’immensa moltitudine genuflessa, dalle loggie del palazzo Madama, prima dalla parte di ponente e poi di levante. Il Papa nel mezzo e i Vescovi ai lati sorreggevano la Reliquia più insigne che sia sulla terra, dopo quella della Croce, mentre le campane della città suonavano a festa ed il cannone annunziava ai lontani il faustissimo avvenimento. Il Papa lasciava Torino il 22 maggio, dopo aver visitato il Santuario della Consolata.
In questo stesso anno adunque, in cui si compirono sì fausti avvenimenti, pochi mesi dopo che il Sommo Pontefice aveva istituita la festa di Maria SS. Ausiliatrice dei Cristiani, alla sera del 16 agosto, nell’ottava consacrata a Maria Assunta in cielo, nasceva il secondogenito di Margherita Bosco. [33]
Fu battezzato solennemente nella chiesa parrocchiale del santo apostolo Andrea, all’indomani a sera, il 17, da D. Giuseppe Festa, essendo padrini Melchiorre Occhiena e Maddalena Bosco, vedova del fu Secondo; e gli furono imposti i nomi di Giovanni Melchiorre.
Nei momenti di pericolo, di turbolenze, allorchè la società corre estremo rischio e traballa sulle sue basi, la Provvidenza suscita uomini che diventano gli strumenti della sua misericordia, i sostegni e difensori della sua Chiesa, gli operai della ristorazione sociale Sembrava stabilita la pace nel mondo, ma non era duratura. Le società segrete continuavano il loro lavorío sotterraneo, minando i troni e gli altari, e di quando in quando scoppi di rivoluzione ne palesavano l’audacia, finchè, permettendolo Iddio, non rinnovarono apertamente la guerra, prima a castigo dei loro complici piccoli e grandi e poi per il trionfo e l’esaltazione del suo nome.
Giovanni Bosco vagiva nella cuna ai Becchi, mentre a Castelnuovo il giovanetto Giovanni Giuseppe Cafasso, di quattro anni, per la sua bontà e contegno in chiesa veniva di già appellato da’ suoi compagni il santino. Questi due bambini diventeranno uomini; e precisamente nel tempo in cui più furiosa ricomincerà la lotta tra il bene e il male, essi saranno al loto posto, ciascuno adempiendo la propria provvidenziale missione.
Una pace soave, che non venne mai turbata neppure per un istante, regnava nella famiglia Bosco. “La donna giudiziosa e amante del silenzio, col suo animo bene composto, è cosa senza paraggio. Come eterni sono i fondamenti gettati sopra salda pietra, così i comandamenti di Dio sul cuore di santa donna[12]”. Margherita, amante dell’ordine e del [34] silenzio, molto accorta, prudente, badava alla parsimonia; mentre il buon Francesco, quasi unicamente col suo sudore lavorando i campi, procacciava sostentamento alla madre settuagenaria travagliata da varii acciacchi, a’ suoi tre fanciulli ed a due servitori di campagna. Ad ambedue nulla più stava a cuore che conservare a Dio quei cari tesori che da Lui avevano ricevuti, e perciò vigilavano perchè nulla potesse offuscare la loro innocenza.
Essi godevano presso la popolazione del paese grandissima stima di onestà intemerata e di vita veramente cristiana, e la fama dopo tanti anni la ricorda ancora. E questa è la migliore eredità che possa toccare ai figliuolì, “perchè la gloria dell’uomo sta nella buona riputazione dei padre suo[13]”.
Ma ogni gaudio su questa terra ha il suo termine. Dio misericordioso visitò quella casa con una grave sciagura. Francesco, pieno di robustezza, sul fiore dell’età, animatissimo per dare educazione cristiana alla figliuolanza, un giorno ritornato a casa tutto molle di sudore, incautamente andò nella sotterranea e fredda cantina. Per la traspirazione soppressa, in sulla sera si manifestò una violenta febbre, foriera di non leggiera polmonite. Tornò inutile ogni cura, e in pochi giorni si trovò all’estremo della vita. Munito di tutti i conforti della Religione, esortava la desolata sua moglie a riporre tutta la sua confidenza in Dio; e negli ultimi istanti chiamatala a sè: – Vedi, le disse, la bella grazia che mi fa il Signore. Egli mi chiama a sè oggi venerdì, giorno che ricorda la morte del nostro divin Redentore, e proprio nella stessa ora in cui Egli morì sulla croce, e mentre io mi trovo nella sua stessa età di vita mortale. – Quindi dopo averla [35] pregata a non volersi affliggere troppo per la sua morte, ed a rassegnarsi intieramente alla volontà di Dio, soggiungeva: – Ti raccomando caldamente i nostri figli, ma in modo speciale abbi cura di Giovannino.
Francesco cessava di vivere nella buona età di 34 anni non ancora compiuti, l’11maggio 1817, in una stanza della masseria Biglione. Il giorno seguente il suo cadavere era portato al cimitero tra il compianto e le preghiere di tutta la borgata. E dalle labbra di mamma Margherita che Don Michele Rua ed altri appresero ciò che abbiamo scritto di Francesco.
Di questo giorno di lutto faceva sovente parola D. Giovanni Bosco a’ suoi piccoli amici, gli alunni dell’Oratorio di S. Francesco di Sales, inculcando loro il rispetto, l’obbedienza, l’amore ai propri genitori. Nei primi tempi, quando non erano così svariate le sue molteplici occupazioni, e la sanità lo favoriva, in sulla sera, nell’ora della ricreazione, egli compariva nel cortile, e all’istante centinaia di giovanetti correvano a lui che sedutosi li intratteneva con fatti edificanti. Sovente prendeva a narrare aneddoti della sua giovinezza. Allora da più d’uno gli si movea l’interrogazione: – Ci racconti quando morì il suo povero papà. – D. Bosco allora: “Io non toccava ancora i due anni quando mi morì il padre, e non mi sovvengo più della sua fisionomia. Non so che ne sia stato di me in quella luttuosa occorrenza; soltanto mi ricordo, ed è il primo fatto della vita di cui tengo memoria, che mia madre mi disse: – Eccoti senza padre! – Tutti uscivano dalla camera del defunto ed io voleva assolutamente rimanere. Mia madre, che aveva tolto un recipiente, nel quale stavano delle uova nella crusca: – Vieni, Giovanni, vieni meco – ripeteva dolorosamente. – Se non viene papà, non ci voglio venire anch’io – risposi. – Povero [36] figlio, ripigliò mia madre, vieni meco; tu non hai più padre! – Ciò detto ruppe in forte pianto, mi prese per mano e mi trasse altrove, mentre io piangeva perch’ella piangeva; giacchè in quell’età non poteva certamente comprendere quanto grande infortunio fosse la perdita del padre. Però mi ricordai sempre di quelle parole: – Eccoti senza padre! – Parimenti mi sovvengo di quello che si fece in casa in quell’occasione con mio fratello Antonio, che smaniava pel dolore. Dopo quel giorno fino all’età di quattro ovvero cinque anni non mi sovvengo più di cosa alcuna. Da quest’età in poi mi ricordo di tutto ciò che faceva”.
CAPO IV.
Grande carestia in Piemonte – Strettezze di famiglia – La vedova cristiana – Sapienza di Margherita nell’educazione dei figli.
LA morte di Francesco mise tutta la famiglia nella costernazione. Erano cinque persone che Margherita dovea mantenere, poichè non reggevale il cuore a congedare i due servitori di campagna. Fin dall’anno antecedente 1816, la carestia aveva ridotto a miserevole stato il Piemonte. I raccolti dell’annata, unica sua risorsa, andarono falliti per il gelo sopravvenuto fuori di stagione e per una terribile ed ostinata siccità. I campi, ove erano state seminate le biade, i prati, gli alberi di frutta, presentavano al riguardante uno spettacolo di desolazione. I commestibili giunsero a prezzi favolosi: il frumento si pagò fino a 1.25 l’emina, il grano turco o la meliga l.16. Parecchi testimoni contemporanei assicurano che i mendicanti chiedevano con premura un po’ di crusca da mettere nella bollitura dei ceci e dei fagiuoli per farsene nutrimento. Si trovarono persone morte nei prati colla bocca piena di erba, con cui avevano tentato di acquetare la rabbiosa fame. In tanta distretta la gente si rivolgeva a Colui, dal cui cenno dipende la pioggia, e si videro pubbliche dimostrazioni di penitenza, quali non sembrava dovessero più ricomparire, dopo tanta vantata indifferenza religiosa [38] portata dalla rivoluzione. Le popolazioni estenuate, squallide, andavano pellegrinando di santuario in santuario, scalze i piedi, con catene al collo, croci pesanti sulle spalle, chiedendo misericordia. Nel ritorno alle loro case, folle di miserelli, scoprendo in mezzo ai campi alcuna fattoria che avesse aspetto di agiatezza, là si trascinavano, e inginocchiate innanzi alla soglia, con voce fioca chiedevano un po’ di limosina. Il padrone, altre volte ricco signore ed ora ridotto a pensare con ansietà all’avvenire, usciva con un sacco, in fondo al quale eravi crusca e ne ponea un pugnello in mano a ciascuno di quegli affamati, che talora così asciutta l’ingollavano, bagnandola delle loro lagrime.
Causa le privazioni, si erano sviluppate molteplici malattie che menavano gran gente alla tomba. Nelle città, sulle soglie dei palagi e delle chiese, nelle vie, nelle piazze si affollavano torme di poveri, sfiniti, seminudi, tormentati da schifose piaghe prodotte dal tifo petecchiale, di cui facevano dolente mostra per eccitare l’altrui compassione e carità! A ciò si aggiunga che le strade erano malsicure. Accadde tale invasione di lupi fuggiti dalla Svizzera, ove loro si era data una caccia generale ed accanita, che ne erano infestati i boschi dell’Abbazia di Stura presso Torino e di là si spingevano in altre regioni condotti dalla fame.
Fra tante miserie la buona Margherita diede alimento alla famiglia fin che ne ebbe; di poi porse una somma di danaro ad un suo vicino di nome Bernardo Cavallo, affinchè andasse in cerca di cibarie. Nessuno della borgata di Morialdo voleva vendere per qualsivoglia prezzo le poche derrate che ancor possedeva. Le vacche e i buoi non erano più condotti sulle fiere mancando i compratori, poichè nessuno aveva potuto fare raccolta di fieno. Quell’amico andò in varii mercati e non potè nulla provvedere anche a prezzi esorbitanti. Ritornò [39] dopo due giorni, e giunse aspettatissimo in sulla sera. Ma all’annunzio che nulla avea seco, se non danaro, il terrore invase la mente di tutti, giacchè in quel giorno avendo ognun ricevuto scarsissimo nutrimento, temevansi in quella notte le funeste conseguenze della fame.
Margherita, senza sgomentarsi, andò ancora una volta dai vicini per farsi imprestare qualche commestibile, ma non trovò chi fosse in grado di venirle in aiuto. Radunata allora la famiglia, così prese a parlare: – Mio marito morendo mi raccomandò di avere sempre gran confidenza in Dio. Venite adunque, inginocchiamoci e preghiamo. – Dopo breve preghiera si alzò e disse: – Nei casi estremi si devono usare mezzi estremi. – Quindi coll’aiuto di quel vicino, andò alla stalla, uccise un vitello, e facendone in tutta fretta cuocere una parte, potè con quella sfamare la sfinita famiglia. Pei giorni seguenti si provvide con cereali, che a carissimo prezzo poterono farsi venire da lontani paesi. Ognuno può immaginare quanto abbia dovuto soffrire e faticare mamma Margherita in quella calamitosa annata. Ma con un lavoro indefesso, con un’economia costante, con una speculazione nelle cose più minute e con qualche aiuto veramente provvidenziale, si potè passare quella crisi annonaria. “Sono stato giovane, dice il reale Profeta, ed ora son già vecchio; e non ho veduto derelitto il giusto, nè la stirpe di lui cercante del pane[14]”. In mezzo a tante pene e tante fatiche, un dolore vivissimo feriva il cuore di Margherita. Sua madre Domenica moriva alli 22 marzo 1818 in età di 60 anni.
Questi fatti ci furono raccontati dalla stessa Margherita e confermati da vicini, parenti ed amici. [40]
Passata quella terribile penuria e ritornate le cose domestiche in migliore stato, venne fatta a Margherita la proposta di un convenientissimo collocamento; ma ella rispose costantemente: – Dio mi ha dato un marito e me lo ha tolto; morendo egli mi affidò tre figli, ed io sarei madre crudele, se li abbandonassi nel momento in cui hanno maggior bisogno di me. – Le fu replicato che i suoi figli sarebbero affidati ad un buon tutore, che ne avrebbe avuto gran cura… – Il tutore, rispose la generosa donna, è un amico; io sono la madre dei miei figli; non li abbandonerò giammai, quando anche mi si volesse dare tutto l’oro del mondo. È mio dovere consecrarmi tutta alla loro educazione cristiana. – Nello stesso tempo protestava di voler essa stessa provvedere ai bisogni della vecchia suocera.
A questo punto debbo fare un riflesso. L’educazione dei figli riesce come lo meritano le preghiere e le virtù delle madri, e come esse la vogliono colla loro solerzia cristiana e collo spirito di sacrifizio. L’amore semplicemente naturale non è altro che egoismo, e riesce sterile ogni sua fatica. E Iddio aveva dato a Giovanni Bosco una vera madre cristiana che doveva formarlo secondo i suoi disegni. Margherita comprese la sua missione.
Ha detto lo Spirito Santo: “Hai tu dei figliuoli? Istruiscili e domali fin dalla loro puerizia, perchè siano docili e sappiano frenare i loro capricci e le loro passioni[15]. Un cavallo indomato diventa intrattabile, e un figliuolo abbandonato a se stesso diventa pervicace[16]. Piaggia il figliuolo, e ti darà delle angoscie; scherza con lui, e ti arrecherà grandi dolori. Non lo lasciar fare a’ modo suo nella gioventù e non far le [41] viste di non vedere quel ch’egli pensa[17]. Il giovanetto, presa che ha la sua strada, non se ne allontanerà nemmeno quando sarà invecchiato[18]”.
Queste verità, che Margherita aveva apprese alla più grande scuola pedagogica che sia al mondo, nella Chiesa, alle istruzioni parrocchiali, furono la costante sua legge, interpretata dal materno amore cristiano e resa sempre più amabile dagli esempi persuasivi di sue virtù.
Il figlio ricopiò in se stesso la madre, e vedremo risplendere in lui la stessa fede, la stessa purità, lo stesso amore alla preghiera; la sua pazienza, l’intrepidezza, la costanza, la fiducia nel Signore; lo zelo della salute delle anime, la semplicità e l’amorevolezza nei modi, la carità verso tutti, l’operosità instancabile, la prudenza nel porre e condurre a termine gli affari, nel sorvegliare con mirabile maestria i soggetti, la tranquillità nelle cose avverse; tutti pregi riflessi in lui dal cuore di Margherita e in lui impressi, come la lente fotografica imprime sul vetro preparato le immagini che le stanno innanzi.
E questa stessa preparazione fu opera di Margherita, colle sue sante industrie e la sua antiveggenza, che non contrastava, ma andava modificando e rivolgendo a Dio le inclinazioni e i doni naturali, dei quali era arricchito Giovanni. Manifestava egli grande apertura di mente, attacco ai propri giudizii, tenacità di propositi; e la buona madre lo assuefece ad una perfetta obbedienza, non lusingandone l’amor proprio, ma persuadendolo a piegarsi alle umiliazioni inerenti al suo stato: in pari tempo non lasciò mezzo intentato, perchè potesse darsi agli studii, e ciò senza affannarsi soverchiamente [42] e lasciando che la divina Provvidenza determinasse il tempo opportuno. Il cuore di Giovanni, che doveva un giorno aver ricchezze immense di affetto per tutti gli uomini, era pieno di esuberante sensibilità che poteva riuscir allora pericolosa, se fosse stata secondata: Margherita non abbassò mai la maestà di madre a inconsulte carezze, o a compatire o tollerare ciò che poteva avere ombra di difetto; non per questo ella usò mai con lui modi aspri o maniere violenti, che lo esasperassero o fossero cagione di raffreddamento nella sua figliale affezione. Giovanni aveva in sè quel sentimento di sicurezza nell’agire, pel quale l’uomo sentesi naturalmente portato a sovrastare e che è necessario in chi è destinato a presiedere alle moltitudini, ma che si può con tanta facilità trasnaturare in superbia; e Margherita non esitò a reprimerne i piccoli capricci fin dal principio, quando egli non poteva ancor essere capace di responsabilità morale. Quando però lo vedrà primeggiare fra i compagni per scopo di fare il bene, osserverà in silenzio i suoi andamenti, non contrarierà le sue piccole imprese, e non solo lo lascierà libero di agire a suo piacimento, ma gli procaccerà ancora i mezzi necessari, anche a costo di sue privazioni. Per tal modo ella dolcemente e soavemente s’insinuerà nell’animo di lui e lo piegherà a far sempre la propria volontà.
Insomma le virtù della mamma dánno ragione delle virtù del figlio medesimo, perchè l’uno era ben degno dell’altra. Con ragione adunque Maria Matta, ava paterna di D. Secondo Marchisio Salesiano, e la signora Benedetta Savio, figlia di Evasio e maestra nell’asilo infantile di Castelnuovo, le quali convissero con Margherita, la dissero con enfatica espressione: La regina delle madri cristiane. Ed il metodo, che Margherita tenne con Giovanni, lo usò pure sempre cogli altri suoi figli.
Ed ora passiamo a contemplare in azione questa degna madre nel suo santo ufficio di educatrice.
CAPO V.
Il catechismo – Il pensiero di Dio – L orazione – La Prima Confessione – Il lavoro – Primi indizii della vocazione di Giovanni
APPENA i figli incominciarono a discernere sufficientemente il bene e il male, massima cura di Margherita fu di istruirli nei primi rudimenti della Religione, avviarli alla pratica di essa ed occuparli in cose compatibili coll’età loro.
L’amore a Dio, a Gesù Cristo, a Maria SS., l’orrore al peccato, il timore dei castighi eterni, la speranza del paradiso non si impara così bene, nè si scolpisce così profondamente nel cuore, come dalle labbra materne. Nessuno può avere tanta autorità di persuasione, nè tanta forza di amore, quanto una madre cristiana. Se ai giorni nostri si vede tanta gioventù crescere scapestrata, insolente, irreligiosa, una delle cause precipue si è perchè le madri più non insegnano il catechismo ai loro figliuoli. Il curato in chiesa insegnerà con zelo le verità eterne ai fanciulli, il maestro in iscuola, se per ventura è buon cattolico, farà studiare e spiegherà ai suoi discepoli il catechismo della Diocesi; ma essi dánno un istruzione in quel momento che talora è molto breve e talora in mezzo a mille distrazioni e tumulti, sicchè i giovanetti imparano, ma non ne restano impressionati. Invece [44] l’istruzione religiosa, che impartisce una madre colla parola, coll’esempio, col raffrontare la condotta del figlio coi precetti particolari del catechismo, fa sì che la pratica della Religione diventi natura e il peccato si abborrisca per istinto, come per istinto si ama il bene. L’esser buono diventa un’abitudine, e la virtù non costa grande sforzo. Un fanciullo cosi educato deve fare una violenza a se stesso per divenir malvagio.
Margherita conosceva la forza di simile educazione cristiana e come la legge di Dio, insegnata col catechismo tutte le sere e ricordata di frequente anche lungo il giorno, fosse il mezzo sicuro per rendere i figli obbedienti ai precetti materni. Essa quindi ripeteva le domande e le risposte tante volte, quanto era necessario perchè i figli le mandassero a memoria.
Essendo essa donna di gran fede, in cima a tutti i suoi pensieri, come pute sulle sue labbra, v’era sempre Iddio. D’ingegno svegliato e di facile parola, sapeva in ogni occasione servirsi del santo Nome di Dio per padroneggiare il cuore de’ suoi fanciulli. Dio ti vede: era il gran motto, col quale rammentava ad essi come fossero sempre sotto gli occhi di quel gran Dio, che un giorno li avrebbe giudicati. Se loro permetteva di andare a sollazzarsi nei prati vicini, li congedava dicendo: Ricordatevi che Dio vi vede. Se talora li scorgeva pensierosi e temeva covassero nell’animo qualche piccolo rancore, loro susurrava all’improvviso all’orecchio: Ricordatevi che Dio vi vede e vede anche i vostri più reconditi pensieri. Se, interrogando qualcuno di essi, cadeva in sospetto che potesse scusarsi con qualche bugia, prima di averne la risposta ripeteva: Ricordati che Dio ti vede. Senza saperlo ripeteva ai figli le parole dette da Dio ad Abramo: – Cammina alla mia presenza e sii perfetto. – E il ricordo che Tobia dava al suo figlio: – Tutti i giorni della tua vita abbi Dio nella [45] mente, e guárdati di acconsentir giammai al peccato e di trasgredire i precetti del Signore Dio nostro. – Questa grande verità è pur quella che fa rispondere, con Giuseppe, al tentatore: – Come posso io far questo male e peccare contro il mio Dio?
Cogli spettacoli della natura Margherita ravvivava in essi continuamente la memoria dei loro Creatore. In una bella notte stellata, uscendo all’aperto, mostrava loro il cielo e diceva: È Dio che ha creato il mondo e ha messe lassù tante stelle. Se è così bello il firmamento, che cosa sarà del paradiso? Al sopravvenire della bella stagione, innanzi ad una vaga campagna, o ad un prato tutto sparso di fiori, al sorgere di un’aurora serena, ovvero allo spettacolo di un roseo tramonto di sole, esclamava: Quante belle cose ha fatto il Signore per noi! Se addensavasi un temporale e al rimbombo del tuono i fanciulli si aggruppavano intorno a lei, osservava: Quanto è potente il Signore, e chi potrà resistere a lui? dunque non facciamo peccati! Quando una grandine rovinosa portava via i raccolti, andando coi figli ad osservarne i guasti, diceva: Il Signore ce li avea dati, il Signore ce li ha tolti. Egli n’è il padrone. Tutto pel meglio; ma sappiate che pei cattivi sono castighi, e con Dio non si burla. Quando i raccolti riuscivano bene ed erano abbondanti: Ringraziamo il Signore, ripeteva; quanto è stato buono con noi dandoci il nostro pane quotidiano. Nell’inverno, quando erano tutti assisi innanzi ad un bel fuoco e fuori era ghiaccio, vento e neve, essa faceva riflettere alla famiglia: Quanta gratitudine non dobbiamo al Signore, che ci provvede di tutto il necessario. Dio è veramente padre. Padre nostro che sei ne’ cieli!
Margherita sapeva eziandio trarre maestrevolmente conseguenze morali e pratiche da tutti quei fatti, che facevano qualche impressione sulla fantasia de’ suoi figliuoli. È dalla [46] madre adunque che Giovanni imparò a stare sempre alla presenza di Dio ed a ricevere ogni cosa o buona o trista come proveniente dalla mano di Dio; e parlando egli sovente di sua madre, si mostrò sempre riconoscentissimo per l’educazione eminentemente cristiana da lei ricevuta e pei grandi sacrifizii che ella aveva per lui sostenuti.
Finchè eran piccoli i figliuoli, Margherita insegnava a ciascheduno in particolare le preghiere quotidiane. Così fece con Giovanni, il quale, appena divenuto capace di associarsi agli altri, metteva in ginocchio mattina e sera, e da tutti insieme recitavansi le preghiere colla terza parte del rosario. Giovanni, sebbene fosse il più piccolo dei fratelli, tuttavia era il primo a ricordare questo dovere agli altri, quando ne era venuta l’ora, e coll’esempio suo inducevali a pregare con molta divozione. La buona mamma li preparò poi alla prima Confessione, appena ebbero raggiunta l’età del discernimento; li accompagnò in chiesa, cominciò a confessarsi ella stessa, li raccomandò al confessore, e dopo li aiutò a fare il ringraziamento. Ella continuò a prestar loro tale assistenza fino a tantochè li giudicò capaci di fare degnamente da soli la Confessione. E Giovanni per questi ammaestramenti incominciò a confessarsi con grande pietà e sincerità e con quella maggior frequenza che gli era concessa. Ogni domenica e festa di precetto conducevali a udir la Santa Messa nella chiesuola della borgata detta di S. Pietro, ove il cappellano predicava e faceva un po’ di catechismo; e Giovanni ritornato a casa ripeteva qualche ammaestramento udito, e tutti volontieri lo ascoltavano.
Le dolci maniere di Margherita nel guidare a Dio i suoi figli colla preghiera e coi Sacramenti le aveano dato tale un’influenza sull’animo loro, che più non perdette col crescere degli anni. Ai suoi figli, divenuti uomini, chiedeva, senza frasi [47] ambigue e con piena autorità materna, se avessero praticati i loro doveri di buoni cristiani e se avessero recitato le loro preghiere al mattino e alla sera. E i figli a trenta e più anni rispondevano collo stesso candore e confidenza, come quando erano bambini.
Allo stesso Giovanni, quando fu prete, non mancava di prodigare i suoi avvisi. Allorchè ad ora tarda giungeva a casa nella sua borgata, dopo aver dato faticose missioni nei paesi all’intorno; ovvero, quando stanco, sudato ritornava da lungo viaggio; oppure, quando già era nell’Oratorio, se, dopo aver predicato e confessato tutto il giorno, rientrava nella sua stanza, cadente dal sonno, e avesse subito dato mano a spogliarsi, la madre lo fermava e interrogavalo: – Hai già dette le orazioni? – Il figlio, che già le aveva recitate, sapendo quale consolazione recava a sua madre, rispondeva: – Le dico subito! – E la madre aggiungeva: – Perchè vedi: studia pure il tuo latino, impara fin che basta la tua teologia; ma tua madre ne sa più di te: sa che devi pregare. – Il figlio si poneva in ginocchio, e mamma Margherita intanto girando silenziosa per la camera, ravvivava la lucerna, accomodava il capezzale, rimboccava le lenzuola, e quando il figlio aveva finita la preghiera, usciva senza più dir parola.
Qualcuno osserverà essere questa una pretensione inopportuna, indiscreta. Io credo però di non appormi al vero dicendo, che in quell’istante la buona Margherita gioisse, pensando come, dopo passati tanti anni, i suoi figli fossero sempre per lei quelli di una volta, semplici, sottomessi, rispettosi. Quante madri ai giorni nostri non si vedono più riconosciute per tali dai figli irriverenti che, divenuti uomini, loro negano atto di rispetto e deferenza! Quante debbono piangere vedendosi disprezzate, derise, insultate da snaturati figliuoli, che prendono con esse il fare e l’imperio di un padrone! Margherita [48] invece nel poter ripetere ai figli quelle parole che loro, quando erano bambini, indirizzava tutte le sere, nello scorgerli così ossequenti alle sue ammonizioni, conosceva di essere sempre per essi quella di una volta Passavano gli anni, ma non passava la gioia della fanciullezza. Margherita, che aveva un cuore così sensibile e delicato, quante volte si ritirava nella sua stanza asciugando una lagrima, che la consolazione le faceva brillare sugli occhi! Le lagrime di gioia, che un figlio fa spuntare sugli occhi della madre, sono più preziose al cospetto di Dio di tutte le perle dei mari d’Oriente; e “quegli che onora la madre sua è come chi accumula tesori[19]”.
Ma, oltre l’istruzione religiosa e le preghiere, altro mezzo di educazione aveva Margherita nel lavoro. Ella non soffriva che i suoi figli stessero oziosi e addestravali per tempo nel disbrigo di qualche faccenda. Giovanni, appena valicati i quattro anni, già si occupava con molta costanza a sfilacciare le verghe di canapa, della quale la madre davagli una quantità numerata. E il fanciulletto, compiuto il suo còmpito, si metteva a preparare i suoi divertimenti. In quell’età già era capace a rotondare pezzi di legno per farne pallottole e bastoncini pel giuoco della galla. In ciò sta questo giuoco, che uno getta la pallottola con un’assicciuola e l’altro di rincontro la rigetta col bastone. Giovanni co’ suoi compagni trovava il suo gusto in questo sollazzo; ma non mancavano le questioni e le risse, solite in simili riunioni di bamboli; la sua parte allora era sempre quella di paciere e si gettava in mezzo cercando di calmare gli animi. Più di una volta però la palla, maneggiata da quelli inesperti ed imprudenti, lo colpiva nel capo o nella faccia, sicchè, soffrendo vivi dolori, correva in cerca della madre per farsi medicare. La buona Margherita appena [49] l’avea dinanzi in quello stato: – Possibile! diceva; tutti i giorni ne fai qualcuna. Perchè vai con quei compagni? Non vedi che sono cattivi?
– È apposta per questo che io vado con loro; se ci sono io, stan più quieti, più buoni, non dicono certe parole.
– E intanto vieni a casa con la testa rotta.
– È stata una disgrazia.
– Sta bene; ma non andar più in loro compagnia. Madre….
– Mi hai inteso?
– Se è per farvi piacere non andrò più; benchè se mi trovo in mezzo ad essi fanno come voglio io, e non rissano più.
– Già, capisco che verrai a farti medicare altre volte; ma bada – concludeva coi denti stretti e crollando leggermente il capo – bada che sono cattivi, sono cattivi. – E Giovannino immobile attendeva l’ultima parola della madre, la quale, dopo aver riflettuto alquanto, come se temesse di impedire un bene, dicevagli: – Va pure.
Sorprendente questa ragione sopra un labbro che ancora balbettava! Fin d’allora dipingevasi nella fantasia di essere in mezzo a numerosi fanciulli, che abitassero con lui, sui quali potesse avere imperio, che pendessero attenti dalle sue labbra, mentre parlava, che si facessero tutti buoni. Questa a lui sembrava l’unica felicità possibile sulla terra. Prevenuto dalla divina grazia, egli senza saperlo anelava alla sua futura missione, avendo sempre fisso nel cuore il santo timore di Dio, da cui procede la sapienza, “la quale previene coloro che la bramano, e per la prima ad essi si fa vedere. Chi di gran mattino andrà in cerca di lei, non avrà da stancarsi, perocchè la troverà assisa alla sua porta…. Ella va attorno cercando chi è degno di lei, e per le strade ad essi dolcemente si mostra e con ogni sollecitudine va loro incontro. Perocchè [50] il principio di lei è un amore sincerissimo della disciplina. La brama adunque della disciplina è dilezione: e la dilezione è l’osservanza delle sue leggi e l’osservanza delle sue leggi è la purezza perfetta; e la purezza fa che uno a Dio si avvicina. Così l’amore della sapienza al regno eterno conduce[20]”.
CAPO VI.
La saggia madre – I figli obbedienti – Il ritorno dal mercato – Il rendiconto.
SI legge nel libro dei Proverbi: “Dalle inclinazioni del fanciullo si riconosce se le opere di lui siano per essere pure e rette. Istruisci il tuo figliuolo, ed egli ti recherà consolazione e sarà la delizia dell’anima tua. L’orecchio che ascolta, e l’occhio che vede, amendue sono opera del Signore[21]”. Vegliate adunque, o genitori, per la sua gloria sulle vostre famiglie.
Margherita vigilava perciò continuamente sopra la condotta de’ suoi figliuoli. La sua sorveglianza tuttavia non era uggiosa, sospettosa, recriminatrice, ma quale la vuole il Signore, continua, prudente, amorevole. Studiavasi di render loro sempre cara la compagnia della mamma, avviandoli con dolcezza all’obbedienza e mettendo in pratica l’avviso dell’Apostolo: “Non provocate ad ira i vostri figliuoli; ma allevateli nella disciplina e nelle istruzioni del Signore[22]”.
Non si infastidiva pei loro clamorosi sollazzi, anzi vi prendeva parte ella stessa, e loro ne suggeriva dei nuovi. Rispondeva con pazienza alle loro infantili e talora seccanti ed [52] insistenti domande; e non solo li udiva volentieri a parlare, ma li faceva parlar molto, sicchè veniva a conoscere tutti i pensieri che essi svolgevano nelle loro tenere menti, tutti gli affetti che cominciavano a scaldare i loro piccoli cuori. I figli, innamorati di tanta bontà, non avevano segreti per lei, che sapeva trovare mille industrie amorose per adempiere degnamente il suo nobile uffizio.
In quei tempi non era cosa insolita trovare nelle case dei contadini più agiati la Storia Sacra o il leggendario dei Santi. Qualche buon vecchio a Capriglio soleva leggerne alcune pagine nella sera della domenica alla famiglia radunata, nella stalla se era d’inverno, o sotto il pergolato nell’aia se d’estate o d’autunno. Quindi mamma Margherita aveva ritenuto a memoria molti esempi tratti dalle S. Scritture o dalla vita dei Santi, riguardanti premi che dà il Signore ai figli obbedienti, e castighi coi quali punisce i figli disobbedienti; e spesso li narrava a’ suoi piccolini, dei quali sapeva eccitare la curiosità e trarre a sè l’attenzione. In modo speciale sapeva tratteggiare, descrivendo al vivo, la fanciullezza del divin Salvatore, sempre obbediente alla sua SS. Madre, e presentarlo come modello di umiltà ai giovanetti.
Tutti sanno quanto i fanciulli siano avidi di racconti e quanta impressione facciano sul loro animo. A questo modo. Margherita si rendeva tanto padrona della volontà dei figli e più tardi di quella dei nipoti, che una sola sua parola era prontamente obbedita e con amore indicibile. Abbisognando di qualche piccolo servizio, come aver legna, andar per acqua, provvedere un po’ d’erba o paglia per gli animali, pulire qualche pavimento, bastava facesse cenno ad uno, perchè corresse anche l’altro.
Era riuscita eziandio ad ottenere da’ suoi figliuoli due cose, che a molti padri e a molte madri sembrerebbero assai [53] difficili. Non voleva assolutamente che si associassero, senza suo permesso, a persone che non conoscevano, e che uscissero di casa, senza aver prima chiesta ed ottenuta licenza da lei. Talora le venivano attorno dicendo: – Mamma, è arrivato il tal compagno e ci chiama; possiamo andare a giuocare con lui? – Se rispondeva di sì, correvano allegri a divertirsi e a passeggiare per la collina. Alcune volte rispondeva con un no schietto, e allora non osavano neppure di affacciarsi alla soglia della casa, ma si fermavano egualmente contenti in quella stanza ove si trovavano, e parlando fra di loro sottovoce si divertivano con quei piccoli giuochi, che si erano fabbricati o che la mamma aveva comperati sul mercato. La mamma talvolta era andata alla campagna, ed essi, interrogati dai vicini sopravvenuti, perchè in una giornata di così bel sole non fossero usciti di casa o perchè stessero così quieti e buonini, rispondevano sempre: – Per non disgustare la mamma.
Avvezzati ad ubbidire per amore, la madre avrebbe potuto viver tranquilla eziandio quando era costretta per i bisogni della famiglia a recarsi ai mercati di Castelnuovo, il giovedì di ogni settimana, per vendere i prodotti del campo e dei pollaio, o per comprare drappi, tele ed altri oggetti per uso domestico. Tuttavia essa aveva troppo cara la loro innocenza, e sapeva come un leggier soffio di male basta per appannarla. Quindi prima di partire, dati loro i debiti avvisi, non mancava mai di pregare la nonna a volerli tener d’occhio.
I giovanetti, studiandosi di non far cosa che potesse dar dispiacere alla mamma, aspettavano ansiosamente il suo ritorno, tanto più che loro prometteva sempre che avrebbe recato seco per regalarli un pane benedetto. Per fanciulli di quell’età e condizione, pareva gran cosa quel regaluccio. [54]
Quindi dall’alto della collina si ponevano in vedetta, e quando la mamma stanca, sudata, polverosa spuntava in fondo al sentiero, pel quale salivasi alla casa, tutti le volavano incontro e stringendosele intorno: – Il pane benedetto, il pane benedetto! – andavano ripetendo. E la mamma arrestava il passo, sorrideva, ed esclamava: – Che premura! Che furia! Attendete un momento; un po’ di pazienza; permettetemi di andar prima in casa e di posare questo pesante canestro; per carità lasciatemi prendere un po’ di fiato. – Ed essi saltellando la seguivano in cucina. Quivi assidevasi, e, attorniata da’ fanciulli, toglieva dal canestro il pane benedetto. I fanciulli tendevano le mani: – A me, a me! – Ma la mamma: – Zitti, adagio; vi darò questo pane, ma prima ho bisogno che mi diciate come avete passata la giornata. – E i giovanetti attendevano silenziosi per rispondere alle interrogazioni che loro venivano mosse singolarmente. Ad uno per es. chiedeva: – Sei stato alla tale cascina, come ti avevo raccomandato, per domandare quella semente e quell’utensile? Che cosa ti hanno detto? Che cosa hai risposto? – E poi al secondo: – Hai fatto quella commissione, della quale ti aveva incaricato, se fosse venuta a casa nostra quella buona vicina? E in che modo l’hai eseguita? – E a tutti: – La nonna vi ha chiesto nessun servigio? Siete stati pronti ad obbedire? Le avete dato nessun motivo di gridare? Dei fanciulli del vicinato è venuto nessuno a visitarvi? E di che cosa vi siete intrattenuti con essi? In che modo avete occupata la giornata? Fra voi ci fu buona armonia? Avete recitato l’Angelus a mezzogiorno? – Con queste e simili interrogazioni si facea render conto esatto di tutto il loro operare e direi quasi persino dei loro pensieri. In mezzo a questi dialoghi i fanciulli narravano gli aneddoti accaduti con ogni menoma circostanza. Intanto la [55] buona madre, sempre amorevole, sempre serena ad ogni risposta, faceva la sua osservazione prudente, che dovesse servir di regola per l’avvenire. – Così va bene, rispondeva all’uno: benissimo detto. Un po’ più di pazienza, un po’ più di cortesia, rispondeva all’altro. Questo non va; un’altra volta sta più attento. Non vedi che è una bugia e le bugie dispiacciono al Signore? – Ovvero all’udire che erano stati obbedienti concludeva: – Sì, sono contenta; trattate bene la nonna e Dio vi ricompenserà. – Così, alla stregua della legge di Dio e delle oneste costumanze, li assuefaceva a giudicare della convenienza o sconvenienza delle loro azioni, e quindi a guardarsi nell’avvenire dai difetti nei quali erano caduti. Dopo le ammonizioni e le lodi, finalmente dava loro in premio un pezzo di pane benedetto, che veniva divorato subito con tutta divozione.
Con simili maniere li interrogava sempre tutte le volte che li incontrava, dopo essere stata qualche tempo, anche una sola ora, senza vederli, sia che ella si fosse recata in campagna, sia che i figli per qualche motivo si fossero allontanati da casa; e un avviso o un consiglio dato all’uno o all’altro de’ suoi cari figliuoli era il frutto di quelle interrogazioni. Continuò questa saggia costumanza finchè non furono uomini fatti.
I figli, educati a questo modo, crescevano ben costumati, contegnosi, guardinghi in ciò che facevano; e se talora commettevano qualche sbadataggine, erano i primi essi ad accorgersene, a riconoscerne la colpa e a proporre di essere un’altra volta più attenti. Giovanni intanto, che in suo cuore ruminava ogni parola della madre e di ogni sua azione stampava in mente la memoria, senza accorgersene faceva suo per l’avvenire quest’ottimo sistema di amorevolezza e di sacrifizio nell’educazione. Lo Spirito di ardore e di carità, [56] inspiratore dei libri sapienziali, fra i dolcissimi inviti coi quali cerca di attirare a sè la figliale attenzione delle anime, interrompendo la serie de’ suoi ammaestramenti, ha pure queste care parole: – Figliuolo, dammi il tuo cuore; e gli occhi tuoi siano intenti alle mie vie[23]. – E Bosco prese questo motto, e mille volte lo abbiamo udito ripetere dalle sue labbra che ci invitavano al bene. E abbiamo veduta riprodursi in lui eroicamente quella continua vigilanza, quell’amore di star quanto più poteva in mezzo a’ suoi giovanetti, quella pazienza di dar ascolto a tutte le parole che gli indirizzavano, e quel premuroso e prudente interrogare, col quale invitava i suoi amici a rendere conto della propria condotta, di che gli era stata maestra la diletta sua madre.
CAPO VII.
Correzioni – La prudente pazienza di una madre – I trionfi dell’amore materno.
MARGHERITA non era donna che alzasse la voce per garrire i figli, che si irritasse nel far correzioni, o che prendesse una decisione per isfogo di stizza. Compariva sempre calma, sempre affabile, sempre sorridente e mai si vide rannuvolata in fronte. I figli sapevano di essere amati da lei, e la contraccambiavano di un amore che pareva giungere all’ultimo limite possibile. Tuttavia la buona madre non mancava di avvisare e rimproverare opportunamente e di essere costante nelle correzioni. “Chi risparmia la verga, odia il figlio suo, ma chi lo ama, lo istruisce con istanza. La stoltezza, cioè la leggerezza, l’incostanza, la proclività al male, sta legata nel cuore del fanciullo; la verga della disciplina ne la discaccerà. Il fanciullo abbandonato a’ suoi voleri è di rossore a sua madre[24]”.
Benchè Margherita avesse l’animo fornito di tanta dolcezza, pure non era debole, e i figli conoscevano che se si fossero ostinati in qualche mancamento, ella non avrebbe esitato di ricorrere al castigo. Non avea rinunziato alla sua podestà punitiva; e simbolo di questa era una verga posta in un angolo [58] della stanza. Non l’usò però mai, come non diede mai a’ suoi figli neppure uno scappellotto.
Suppliva a ciò con artificii tutti suoi particolari, i quali, usati prudentemente, riuscivano di mirabile effetto su cuori avvezzi ad obbedire. Giovanni avea soli quattro anni. Tornato un giorno dal passeggio col fratello Giuseppe, ambidue arsi da molta sete per essere quella la stagione estiva, la mamma andò ad attingere acqua e diede a bere pel primo a Giuseppe. Giovanni, osservata quella specie di preferenza, quando la mamma fu a lui coll’acqua, un po’ permalosetto, fece segno che non volea bere. La mamma, senza dire parola, portò via l’acqua e la ripose. Giovanni stette un momento così, e poi timidamente: – Mamma!
– Ebbene?
– Date dell’acqua anche a me?
– Credevo che non avessi sete!
– Mamma, perdono!
– Ah, così va bene! – E andò a prendere 1’acqua e sorridendo gliela porse.
Altra volta Giovanni erasi lasciato andare a qualche vivacità o impazienza propria dell’età sua e di un naturale tutto fuoco. Margherita lo chiamò a sè. Il giovanetto corse.
– Giovanni, vedi tu quella verga? – e gli accennava la verga appoggiata al muro nell’angolo della stanza.
– Sì, che la vedo – rispondeva il figlio, ritraendosi indietro peritoso ad una certa distanza.
– Dunque prendila e portamela.
– Che cosa volete farne?
– Portamela e poi vedrai.
Giovanni andò a pigliare la verga e gliela porse, dicendo: Ah, voi volete adoperarla sulle mie spalle!
E perchè no, se tu mi fai di queste scappate [59]
– Ebbene, mamma, non le farò più! – E il figlio sorrideva al sorriso inalterabile della sua buona madre. Ciò bastava perchè stesse più attento un altra volta. Giovanni però avrebbe accettata la punizione, se la madre, paga dell’obbedienza e docilità, non lo avesse perdonato. E Margherita asseriva che Giovanni giammai le aveva cagionato alcun dispiacere, e che, se per inavvertenza stava per commettere qualche piccolo fallo, bastava che ne lo avvertisse, perchè tosto desistesse. Prometteva e manteneva le sue promesse.
Giuseppe, benchè d’indole affettuosa e mite, essendo bamboletto ancora, talvolta si stizziva, s’incapricciava, mostrandosi restio ad eseguire qualche ordine. La mamma lo prendeva per mano, mentre l’altro si lasciava andare per terra, si dibatteva, strillava; e la madre sempre ferma, sempre ilare, sempre paziente lo teneva: – È inutile, guarda, dicevagli; io non ti lascio andare dovessi star qui tutto il giorno. Tocca a te cedere. – E se Giuseppe continuava a smaniare, essa faceagli riflettere: – Non vedi che sono più forte di te? Sta certo che non mi vincerai, e pensa che, se tu fai il cattivo, il Signore ti afferrerà per condurti al suo tribunale e ti castigherà; ed allora come farai a fuggire da Lui? – Giuseppe, vedendo che riusciva inutile ogni suo conato, finalmente si acquetava, alzava gli occhi in volto alla madre, che portava sempre l’impronta della bontà e dell’allegrezza, e sorrideva. Sulle labbra eziandio della madre fioriva il sorriso, e tutto era finito.
Chi può descrivere il bene che fa ad un fanciullo il sorriso della madre? Esso infonde gioia ed amore; è un ricordo soave negli anni dell’età avanzata, e uno sprone efficace nell’adempimento de’ propri doveri; è un riverbero dell’allegrezza del paradiso, e a questo fa sollevare i cuori col renderli più buoni. [60]
Tale era il metodo di Margherita nel correggere i propri figliuoli, volendo ad ogni costo che la correzione non provocasse iracondie, diffidenze, disamore. La sua massima su questo punto era precisa: indurre i figli a far ogni cosa per affetto e per piacere al Signore. Essa perciò era una madre avventurata.
Essere però buona coi figliuoli amorevoli, tirare a sè coll’amore cuori ben fatti, non sembra cosa tanto difficile. Il difficile è realmente saper domare colla bontà un naturale stizzoso, prepotente e avverso. Ed eziandio in ciò riusciva Margherita. Il figliastro Antonio, che era già grandicello quando Francesco passò a seconde nozze, avea accolta con freddezza la nuova madre, e come accade in simili circostanze, quasi la riguardava come un’intrusa. Le carezze che il padre prodigava a Giuseppe e a Giovanni erangli sembrate usurpazioni dei fratellini a suo danno. Tanto più essendo cosa evidente che di quel povero patrimonio, prima da lui riguardato come tutto suo, ne avrebbe perduti due terzi. La fredda ragione non lo scuserà, ma in quegli anni di fervida immaginazione è compatibile se lamentava il suo danno. Quindi nutriva una certa antipatia contro la madrigna. Margherita però, specialmente dopo la morte del marito, prese a trattare Antonio con ogni preferenza, con que’ riguardi che un primogenito prediletto non poteva desiderare maggiori, tentando di vincerne l’animo caparbio. Con ciò riusciva a far sì che nella casa non fosse turbata la pace, ma non poteva impedire che talora venissero scene disgustose o per disobbedienze o per risposte insolenti. Ci voleva una virtù eroica per resistere a quel naturale bizzarro e impetuoso, che talora non temeva di venir a contesa colla sua stessa vecchia nonna. Tuttavia mamma Margherita non fu mai inferiore a se stessa in prove così ardue. [61]
Antonio sovente si lasciava andare a battere i fratellini, e mamma Margherita dovea correre per levarglieli di mano. Essa però non usò mai della forza per difenderli, e fedele alla sua massima, non torse mai ad Antonio neppure un capello. Si può immaginare qual padronanza avesse Margherita sovra di sè per comprimere la voce del sangue e dell’amore che portava sviscerato a Giuseppe ed a Giovanni. In queste circostanze però assumeva un contegno sostenuto verso di lui, e non facendo alcuna allusione a ciò che era occorso, in tutto il giorno più non gli indirizzava parola. Dopo qualche ora, ma il più delle volte verso sera, Antonio le si avvicinava e: – Mamma, dicevale, che cosa avete?
– Lasciami tranquilla, rispondeva mamma Margherita, ora sono troppo commossa per parlare. Lascia che io mi calmi, domani te lo dirò. – La notte è la madre dei buoni consigli, – e all’indomani mattina Antonio si presentava a Margherita dicendole: – Mamma, perdonatemi!
– E quale giudizio fai di ciò che ieri ti accadde?
– Ma sono gli altri che mi hanno incitato, che mi hanno offeso. Io voglio essere rispettato. Essi furono i primi.
– Basta! Se la cosa è così, basta! E poi mi chiedi che io ti perdoni?
– Ma io aveva ragione.
– Ragione? Ammettiamo che tu avessi realmente ragione sul principio e nella sostanza della cosa; ma concedi almeno che tuo è il torto nel modo, e che tu non dovevi farti giustizia da te stesso. Del resto il torto nella quistione non è tutto degli altri, ma anche tu hai la tua parte. Confessa dunque la tua parte di torto, riconosci l’errore tuo dove sta e prometti di emendarti. Allora potrò credere che sei pentito. – Antonio alle calme parole della madre talora rispondeva: – Sì, sono pentito, riconosco il mio torto e nol farò più. [62]
– Ebbene, replicava allora la mamma, – ed io ti perdono. – E gli sorrideva così amorosamente, che Antonio ne restava tutto contento.
Ma talvolta ei non voleva riconoscere il suo mancamento e indispettito si ritirava brontolando. Margherita pazientava sino alla sera, finchè veniva l’ora di recitare le orazioni. Antonio se ne stava in un angolo ingrugnito, da solo. Margherita, temendo non venisse a dire le orazioni in comune, andava a prenderlo amorevolmente per mano e gli diceva: – Ebbene, hai pensato a ciò che ti ho detto?
Antonio alzando le spalle, cercando svincolarsi dalla madre, ripeteva di aver ragione. Margherita allora mutava discorso, esortavalo a pregare il Signore perchè volesse benedirlo, e traevalo per un braccio ove gli altri già attendevano da qualche tempo, con quella pazienza che ognuno può immaginarsi, senza sdegno, senza violenza, e adducendo sempre ragioni persuasive. Ce ne voleva, ma pur finalmente riusciva a farlo mettere in ginocchio, benchè distante dagli altri della famiglia. Alle volte per rabbonirlo Margherita pronunciava qualche burletta, qualche frizzo e Antonio leggermente sorrideva. Margherita allora incominciava ad alta voce la preghiera. Detto l’atto di contrizione, si recitava il Pater noster. Ma alle parole: Rimetti a noi i nostri debiti, siccome noi li rimettiamo ai nostri debitori, Margherita sospendeva le preghiere e voltasi ad Antonio dicevagli
– Lascia le parole: Rimetti a noi i nostri debiti; queste parole non debbono essere dette da te.
– Ma come? se sono nel Pater
– Eppure tu non devi dirle.
– Che cosa dunque dovrò dire?
– Ciò che vuoi, ma queste parole no!
– Oh bella! e perchè? [63]
Perchè? Con qual coraggio oserai tu pronunziarle, mentre non vuoi perdonare ai compagni, mentre nutri astio verso di essi, avendo ancora per soprappiù rotta tu ad essi la testa? Non temi che il Signore ti castighi, mentre pronunci simili parole, che sono in tua bocca una menzogna, un insulto a Dio, non volendo perdonare? E come speri che il Signore perdoni a te, se tu così ostinatamente neghi il perdono agli altri? – Queste ed altre simili espressioni che partivano dal cuore, ispirate dal desiderio dì far del bene all’anima e dì riconciliarla con Dio e dette in modo da commuovere, ottenevano generalmente il loro effetto. Antonio finiva con dire: – Mamma, ho torto, perdonatemi. – Ed il perdono era subito concesso.
Ma più di una volta Antonio, ripreso o contrariato in qualche suo capriccio, andava talmente su tutte le furie, che più non udiva la voce del dovere. Stretti i pugni e stese le braccia, si avanzava contro Margherita fino ad urtar quasi nel suo petto, gridando: Ah matrigna! ovvero irrompendo in altri termini non meno irriverenti. Margherita, donna robustissima, avrebbe potuto con quattro manrovesci rimandargli le parole in gola e tenerlo a freno. Ma no; essa si ritirava di alcuni passi, fissava il figliastro con uno sguardo così penetrante che lo frenava subito, mentre i due piccolini gettandosi in mezzo a lei e stringendosele intorno dicevano: – No, madre, non temere. Calmati, Antonio! – E Margherita: – Senti, Antonio, gli diceva, io ti ho chiamato figlio, e quando ho detto una volta questo nome l’ho detto per sempre. Tu sei mio figlio, perchè lo sei di Francesco tuo padre, perchè tuo padre ti ha affidato a me, e perchè come tale io ti amo. Tu lo vedi che, se volessi, potrei batterti in modo che saresti costretto a cedere. Ma io non voglio. Ho stabilito che coi miei figli non vincerò mai colla forza materiale, ma solo [64] colla forza morale. Tu sei mio, figlio e non ti voglio battere. Tu fa come credi, ma il torto è tuo. – E si ritraeva. Antonio a queste parole avvilito, confuso, ritornava in se stesso, abbassava la fronte e si allontanava. Molte furono le furie di Antonio, ma furono sempre infrante dalle soavi parole di Margherita, che metteva in pratica il generoso consiglio dei Proverbi: “Correggi il tuo figliuolo, non perdere speranza[25]”. Antonio però si fermò sempre alle sole minacce, delle quali non mancava di domandar scusa, cessato l’impeto della passione, specialmente per le serie ammonizioni che non mancava di fargli la nonna. E coll’andare degli anni seppe moderarsi in modo, da lasciar fama, viva ancora presentemente, di uomo non solo distinto per grande onoratezza e che trattava bene con tutti, ma ancora di amico fedele, il quale sapeva tener desta l’allegria in qualunque luogo si presentasse. Il rispetto e l’amore, che in realtà stava nel suo cuore, benchè imbrogliato e nascosto, verso Margherita, si esplicò chiaramente quando prese per sè stanza a parte, dividendo i beni paterni. Spesse volte si recava a visitare la matrigna, che appellava sempre col dolce nome di madre, in quel tempo che dimorò ancora a Morialdo; e quando essa trasferì in Torino il suo domicilio, partiva dai Becchi per goder la consolazione di passare qualche ora con lei, ascoltando riverentemente i suoi consigli.
Intanto alla scuola di sua madre Giovanni imparava quell’ammirabile dolcezza e quel metodo preveniente i disordini, che rende l’educatore padrone del cuore de’ suoi allievi.
CAPO VIII.
La nonna – Rispetto ed affezione figliale di Margherita verso la suocera – Unità di governo nella famiglia – Giovanni intercede per il fratello presso la nonna.
SE Margherita erari uscita con tanta facilità a piegare i figli ad una esatta obbedienza, ciò non era frutto solamente delle sue parole, ma specialmente de’ suoi esempi. Suo marito Francesco morendo aveale lasciato in custodia la propria madre, vecchia, infermiccia, da vari acciacchi ed incomodi costretta a stare la maggior parte del giorno o seduta sovra una sedia o nel letto. Tuttavia questa buona e santa creatura, assuefatta fin dalla fanciullezza ad una grande attività, si prestava per la famiglia a tutto quel poco che le forze le permettevano. Quindi faceva calze, rappezzava, cuciva, preparava il mangiare, scopava; e per sua cura in quella piccola casetta ogni cosa era sempre lustra e in ordine. Quando non riusciva a terminare quelle faccende, rientrando in casa la nuora, questa aiutavala a dare l’ultima mano, essendo essa pure amante della pulizia e del decoro famigliare.
Margherita però teneva la suocera come regina della casa. La venerava come se fosse la propria madre, la obbediva in ogni circostanza e la consultava in ogni affare. Quando sorgevano disparità di opinioni, era pronta ad assoggettare la [66] propria sentenza a quella della vecchia. In tutto ciò che sapeva farle piacere, davasi dattorno premurosamente per accontentarla, procurandole eziandio quei cibi, che aveva potuto congetturare le sarebbero tornati di maggior gradimento. Di giorno, nei momenti che aveva liberi dal lavoro, e nella stagione invernale, andava volentieri ad assidersi al suo fianco per tenerle compagnia. Di notte, tutte le volte che le infermità faceano, rincrudire gli spasimi della vecchia, Margherita vegliava, avendo per lei una cura più che figliale. Andando al mercato o alla fiera, e ciò capitava quasi tutte le settimane, non ritornava mai a casa senza recare alla nonna qualche segno d’aver pensato a lei, come paste fine per la minestra, pan grissino, biscotti, o frutta primaticcie.
Questo rispetto per la nonna Margherita lo pretendeva eziandio dai figli, e voleva che fosse senza limite ed in ogni circostanza. Era solita a dir loro: – Voi dovete obbedire a vostra nonna più prontamente ancora che a me stessa. – Ed era inesorabile, quando accadeva che le avessero in qualche modo mancato di riverenza o di obbedienza.
Essa benchè tutta tenerezza pei figli, pure non prese mai le loro parti contro la buona vecchia, mai diede loro ragione quando la nonna dava loro torto. Un castigo inflitto da questa, era sempre dato giustamente, e non vi era caso nel quale essa togliesse o diminuisse la pena al castigato, o cercasse di contrapporre un’inconsulta bontà alla momentanea severità della nonna.
Questa perfetta armonia era necessaria per la buona educazione dei fanciulli, poichè tutta l’amministrazione domestica pesava su mamma Margherita. Solo essa curava la coltivazione del podere e le compre e le vendite. Con virile coraggio non solo sbrigava quei lavori di campagna che soglionsi affidare alle donne, ma si assoggettava volentieri [67] a tutti gli altri più pesanti e più faticosi lavori propri degli uomini. Il fratello Michele non ricusavasi dal prestare aiuto alla sorella; ma talora, chiamato, non poteva venire, per essere impedito dalle proprie faccende. Allora Margherita, falciava l’erba, o solcava il campo coll’aratro, e seminava, mieteva il grano, ne faceva i covoni, li poneva sui carri, li trasportava sull’aia, formava le biche, trebbiava e riponeva il raccolto nel granaio. Alla testa degli uomini presi a giornata, li stancava tutti a morte col suo esempio, non volendo essi in attività lasciarsi vincere da una donna. Antonio non le dava troppo aiuto in questi lavori. Mamma Margherita doveva perciò rimanere molto tempo fuori di casa; stava però tranquilla, avendo la certezza che i figli erano ben sorvegliati. Nella nonna aveva un potentissimo aiuto per educarli e un cuore disposto a secondarla in ogni modo e cogli stessi mezzi. Abbiam già detto che mamma Margherita avea trovato in questa casa quel sistema di educazione, col quale essa stessa era stata allevata.
La nonna adunque sovente inchiodata in quel suo seggiolone, colla sola voce regolava e ordinava ogni cosa; ed i nipoti aveano per lei ogni maggior deferenza. Ogni sua volontà era per essi una legge infrangibile. Donna di una dolcezza estrema di modi, di una sensibilità di cuore perfino eccessiva, era di una inflessibilità incrollabile e senza pari nel volere che chi aveva fallato riconoscesse il suo torto. Quando qualcuno dei nipoti mancava, essendo assente la madre, non dissimulava, non transigeva, ma chiamatolo per nome: – Vammi a prendere quella verga.
Ma voi volete battermi?
– Precisamente: dammela. – Il giovanetto andava a prenderla e gliela porgeva.
– Ora avvicinati. – Il giovanetto le si poneva al fianco. [68]
– Ma, nonna, io non fui il primo in quell’alterco: non sono io che ho fatto quella disobbedienza.
– Sta bene: dunque invece di una vergata, te ne darò due.
– Nonna, perdonatemi!
– Questo non mi basta!
– Nonna, ho torto e non lo farò più. – E confessava in che cosa il suo torto consistesse.
– Lo riconosci davvero il tuo torto?
– Sì, nonna!
Talora la nonna avea già alzata la mano, se il piccolo colpevole esitava a rispondere, ma alla voce: – Perdono; ho torto! – essa ritraevala e: – Va, gli diceva; riponi la verga al suo posto e non lasciarti più andare a simili mancanze. – In generale finivano sempre così quelle minacce, perchè i giovanetti, sapendo qual fosse il mezzo per isfuggire il castigo, accusavano subito schiettamente il loro difetto.
Rarissime volte le accadde di percuotere, e allora era un colpo o due di verga, che certo non bastava a far sentire il dolore; ma, avendo unita l’idea di castigo, era sufficiente a strappare il pianto dal punito, il quale si guardava dall’allontanarsi anche di un solo passo. Essa, donna di Chiesa, sapeva a memoria le istruzioni del parroco. “Non privare il fanciullo della correzione, perchè se tu lo percuoterai colla verga, egli non morrà. Se tu lo percuoterai colla verga, libererai l’anima di lui dall’inferno[26]”.
La nonna a stento potea alzarsi dalla sedia, e quindi talora vi fu chi interrogava quei giovanetti: – Perchè andate vicini alla nonna, quando vi chiama per punirvi? Perchè non fuggite? Essa non potrebbe raggiungervi! – Per non fare dispiacere alla mamma! – era la solita risposta. [69]
Un giorno la nonna si accorse come fossero scomparse alcune frutta, che ella avea messe in serbo, e il suo sospetto cadde sul più piccolo dei nipoti. Lo chiamò: – Giovanni! – Questi, essendo innocente di quel furto, corse giulivo alla nonna; ma essa tutta seria gli disse: – Vammi a pigliare quella verga che vedi là in quel cantuccio. – Il piccolino tutto confuso obbedì, ma sapendo come stava la cosa: – Nonna, disse, io obbedisco, ma sappiate che non sono io che ho preso quelle frutta.
– Ebbene, ripigliò essa, tu mi dirai chi ha fatta la mancanza, ed io ti risparmio le vergate.
– Io ve lo dirò, ma a condizione che voi perdoniate al colpevole.
– Farò così. Conduci qui il cattivello, e se egli mi chiederà perdono e mi recherà la verga, riconoscendosi con quest’atto meritevole di castigo, io lo perdonerò. – Il piccolino corse al fratello più grande, che avea allora circa 15 anni, pel quale non conservava alcuna malevolenza per il mal occhio ond’era da lui guardato, e gli raccontò l’avvenuto. Antonio, già lavoratore alla campagna, trovò un po’ ridicola quella pretensione della nonna. Essere punito come un bambolo di sei anni sembravagli un’umiliazione un po’ strana. Alzò quindi leggermente le spalle con un gesto che voleva dire: – Sciocchezze! – Ma Giovannino insistè: – Vieni, caro mio; non contrastare alla volontà della nonna. La nonna è gelosa della sua autorità, e ne avrebbe troppo vivo dispiacere. La mamma pure ne sarebbe molto disgustata. È vero che sei già grande, ma non sia detto che per causa tua la nonna si veda poco rispettata. – Il fratello cedette e dicendo: – Andiamo – prese la verga, la porse alla nonna e brontolò un: – Non lo farò più – con un viso che certamente non ricopiava in sè l’umiltà di [70] un novizio certosino. La nonna però mostrandosi soddisfatta di quell’atto, lo prese con amorevolezza per un braccio e gli disse: – Figliuol mio, ritieni che, se egli è vero che ne uccide più la gola che la spada, è pur vero che ne manda più all’inferno la gola colle sue conseguenze, che qualunque altro peccato.
Giovanni intanto a questo perfetto accordo di sua madre colla nonna toccava con mano l’estrema necessità e i vantaggi inestimabili dell’armonia dei superiori di una casa, per condurre a buon porto l’educazione dei giovani; poichè, se entrano gelosie, rancori, opinioni diverse, metodi non conformi in quelli che debbono mantenere la disciplina, se ne vedranno le dolorose conseguenze negli alunni e si avvererà il detto: Un regno diviso sarà desolato.
CAPO IX.
Margherita avvezza i figli alla nettezza, alla riflessione e ad una vita dura e mortificata.
MARGHERITA, oltre l’ordine e la bellezza nell’anima dei figli e la docile e costante allegrezza, della quale voleva fossero sempre accompagnatele loro azioni, esigeva l’ordine e la pulizia nelle loro persone. Questa sua diligenza era secondo lo Spirito del Signore: “Mangia lietamente il tuo pane e bevi con letizia il tuo vino, mentre le opere tue a Dio sono accette. In ogni tempo siano nitide le tue vesti e non manchi unguento al tuo capo, secondo il patrio costume[27]”. Laonde Margherita fino agli otto o dieci anni non solo procurava di mandare i suoi figliuoli puliti, ma eziandio si compiaceva di una certa ricercatezza nei loro abbigliamenti. Alla domenica specialmente adattava alla loro persona i vestiti più belli da festa, ravviava i loro capelli, che naturalmente ricciuti lasciava crescere alquanto, stringendoli per vezzo con un piccolo nastro. Presili quindi per mano li conduceva alla Messa. Talora permetteva che Antonio la precedesse col più grandicello, ma di pochi passi, in modo che non si allontanasse dal suo sguardo. Coloro che s’imbattevano in quella [72] famigliuola, specialmente le madri, si fermavano a congratularsi con Margherita! – Oh! i bei fanciulli, dicevano; sembrano proprio angioletti! – Margherita gioiva tutta a questi elogi. Ella sentiva profondamente nel cuore, ma con maggior nobiltà, gli affetti espressi un giorno dalla madre dei Gracchi, la quale ai romani, richiedenti di vedere i suoi monili, presentando i figli avea risposto: – Ecco le mie perle! – Per Margherita i figli erano tutto il suo tesoro, il suo ornamento, la sua gloria.
I figli nell’avanzarsi verso la chiesa, in mezzo al popolo che cresceva di numero, veggendo certi vecchi che a quel tempo portavano ancora un lungo codino, lucido, legato col nastro: – Mamma! le dicevano; vedi là Giacomo (era un buon vecchione, il Nestore della borgata): quando a noi eziandio farai scendere i capelli così intrecciati dietro alle spalle?
– A voi bastino i ricci, dei quali lo stesso buon Dio ebbe cura di ornarvi. – Vi piace fare una bella figura, non vero?
– Ma sì!
– Or bene: ascoltatemi. Sapete perchè vi metto questi bei vestiti? Perchè essendo domenica, è cosa giusta che mostriate esternamente la gioia che deve provare ogni cristiano in questo giorno, e poi perchè desidero che la pulitezza dell’abito sia la figura della bellezza delle anime vostre. Che importerebbe aver bei vestiti, se poi l’anima fosse brutta per il peccato? Attendete adunque a meritarvi le lodi di Dio e non quelle degli uomini, che non valgono a niente altro, fuorchè a farvi ambiziosi e superbi. Dio non può soffrire gli ambiziosi e superbi, e li castiga. Vi han detto che sembrate angioletti; e angioletti dovete essere sempre specialmente adesso che andiamo in chiesa, e stare in ginocchio, senza [73] voltarvi attorno, senza chiaccherare, e pregare colle mani giunte. Gesù Cristo in Sacramento sarà contento di vedervi divoti innanzi al suo tabernacolo e vi benedirà. – Con queste lezioni di pulizia e di compostezza, li avvezzò a portare rispetto a se stessi e agli altri. Giovanni fino alla più tarda età aveva tale amore alla pulizia degli abiti, che sopra di questi non vedevasi macchia di sorta, assoggettandosi egli volentieri all’incomodo di una frequente rivista alla sua talare e al suo mantello, e perciò poteva entrare in qualunque palagio, casa, o conversazione, ed era accetto alle persone anche più schifiltose. L’ordine esterno della sua persona era indizio dell’ordine mirabile che regnava nell’anima sua.
Avea pur cura mamma Margherita che i suoi giovanetti si assuefacessero in ogni circostanza ad operare con riflessione, poichè la sbadataggine, anche incolpevole, è fonte di danni morali e materiali. Giovanni aveva otto anni, ed un giorno, mentre la mamma era andata ad un paese vicino per sue faccende, ebbe l’idea di togliersi alcun che riposto in alto. Non giungendovi prese la sedia, e salito su di essa, urtò in un vaso pieno di olio. Il vaso cadendo per terra si ruppe. Confuso il piccolino, cercò di rimediare a quella disgrazia collo spazzare via l’olio sparso; ma conoscendo che non sarebbe riuscito a togliere la macchia e l’odore diffuso, pensò a far sì che la mamma non avesse dispiacere. Tolta una verga da una siepe, aggiustolla per bene, e strappandole a disegno in varii luoghi la verde corteccia, adornolla di fregi il meglio che seppe. Venuta l’ora, nella quale sapea che la mamma sarebbe di ritorno, le corse incontro fino in fondo alla valle e appena le fu dappresso: – Ebbene, mamma, come state? avete fatta buona passeggiata?
– Sì, mio caro Giovanni! e tu stai bene? sei allegro? sei buono? [74]
– Oh! mamma! guardate qui! – E le porgeva la verga.
– Ah! figlio mio, me ne hai fatta qualcheduna.
– Sì; e mi merito proprio che questa volta mi castighiate.
– E che cosa ti accadde?
– Son salito così e così, e per disgrazia ho rotto il vaso dell’olio. Sapendo che merito il castigo, vi ho portato la verga, perchè la usiate sulle mie spalle, senza prendervi il fastidio di andarla a cercare. – Intanto Giovanni porgeva la verga tutta fregiata e mirava in volto la madre con un fare furbo, peritoso, scherzevole. Margherita osservava il figlio e la verga, e ridendo di quella infantile furberia, finalmente gli disse: – Mi rincresce molto della disgrazia che ti è occorsa, ma siccome il tuo operare mi fa conoscere la tua innocenza, io ti perdono. Tuttavia ricorda sempre il mio consiglio. Prima di fare una cosa, pensa sempre alle sue conseguenze. Se tu avessi guardato se nulla vi fosse che si potesse rompere, saresti salito più adagio, avresti osservato attorno e nulla di male ti sarebbe avvenuto. Non sai che colui il quale da giovanetto si assuefà alla sventatezza, fatto uomo continua ad essere irriflessivo e si attira molti dispiaceri e forse anche va incontro all’offesa di Dio? Abbi dunque giudizio! – Questi ammaestramenti soleva essa ripetere ogni volta facea d’uopo e con tanta efficacia di parola, da rendere i figli più guardinghi per l’avvenire.
“Chi fa caso delle riprensioni, diventerà più saggio[28]”. E questa saggezza gli insegnerà eziandio a non meritar riprensioni, a sottomettervisi quando son meritate ed anche ad allontanarne le conseguenze coll’umiltà e colla sincerità. Così faceva Giovanni; ma in questo fatterello non si vede [75] già in lui un lampo di quella politica cristiana, la quale, colla semplicità della colomba e la prudenza del serpente, dovette egli adoperare tante volte per difendere le sue istituzioni e spezzare le reti a lui tese da’ suoi avversari, senza renderseli nemici?
Notiamo anche qui quanta differenza passi tra Margherita e tanti genitori, i quali, mentre non sanno allevare i figli amanti dell’ordine e dell’economia, anzi mentre essi stessi loro danno esempio di trascuratezza e di precipitazione, poi ad ogni minima disgrazia di vetro rotto, di abito sdruscito, di sedia caduta, vanno sulle furie, apostrofano, percuotono i loro fanciulletti, come se avessero commessa una gravissima colpa! E i figli tremano, piangono, si irritano, odiano e finiscono talora col ribellarsi all’autorità paterna o materna. Non si riflette che si snatura eziandio il senso morale dei figli. Infatti si tollera talora in essi, o tutt’al più si punisce con fiacchezza, la bugia, le risse, il parlar poco misurato, le disobbedienze; mentre una piccola jattura materiale è punita con una tempesta furiosa di parole e di percosse, che soventi volte sono cagione di scandalo e offesa di Dio. Quale stoltezza paragonare o anteporre una piccola disgrazia alle mancanze contro la legge del Signore!
Tuttavia, benchè Margherita amasse tanto i suoi figli, non dava mai loro alcuna dimostrazione di affetto sdolcinato; anzi sua cura era di avvezzarli ad una vita sobria, faticosa e dura. Così crebbero robusti. Le lunghe marce non li stancavano: essi non misuravano le distanze. Molte volte Giovanni, quando era al Convitto, partiva da Torino alle due pomeridiane e arrivava tranquillo a Castelnuovo d’Asti alle 8 di sera.
A colazione non voleva che si assuefacessero a mangiare companatico, non frutta, benchè fossero in campagna, non caffè e latte. Preparava loro un pezzo di pane e così asciutto [76] voleva che lo mangiassero. In tal modo li avvezzò, che loro non importava mancassero di companatico a colazione. Così faceva pure con Giovanni, quando tornava dalle scuole in vacanza, anzi quando era già chierico.
Siccome in Seminario usavasi il materasso, essa preparavagli il letto in casa con un semplice e duro pagliericcio, dicendo: – È meglio che ti assuefaccia a dormire con un po’ di disagio: alle comodità facciamo presto ad avvezzarci. – E nei quattro mesi di vacanza era questo il suo letto costantemente. Dal figlio stesso facea involgere il materasso in una copertina, ordinandogli di riporlo fino al principiare del nuovo anno scolastico. – Non sai quel che potrà essere di te in avvenire, gli ripeteva; chi sa a qual sorte ti destini la Provvidenza; sta quindi bene che tu sia abituato ad un po’ di privazione.
Eziandio nella durata del sonno voleva che sostenessero qualche mortificazione. – Perchè, diceva, uomo che dorme non piglia pesci. – Spesse volte alla sera per varie faccenduzze, che avevano per fine l’ospitalità cristiana chiesta da qualche poverello che invano aveva cercato altrove ricovero, li facea stare alzati fino ad ora alquanto tarda. Al mattino, prima della levata del sole, li destava e voleva che senza indugio fossero in piedi. Talora perfino nel corso della notte loro interrompeva il sonno per varie occorrenze di servizio a qualche infermo delle case vicine. Con ciò Giovanni si avvezzò a non patire troppo le veglie. Quando sembrava alla madre che Giovanni nella notte non avesse riposato abbastanza, gli diceva di andare a dormire nelle ore calde del giorno. Giovanni obbediva: sedevasi su d’una panca vicina al tavolo, e sopra appoggiava le braccia ed il capo; ma non c’era verso di poter prender sonno.
– Ma dormi, Giovanni, dormi, gli diceva Margherita. [77]
– Ma sì, mamma, rispondeva il figlio, non vedete che dormo? – E così dicendo chiudeva gli occhi. Mamma Margherita rideva: – Vedi, figlio mio, la nostra vita è così breve, che abbiamo poco tempo per fare il bene. Tutte le ore, che noi consumiamo in un sonno non necessario, è tempo perduto pel paradiso. Tutti i minuti che noi possiamo togliere ad un riposo inutile, è un prolungamento di vita, perchè il sonno è immagine della morte. In questi minuti quante buone opere non possiamo fare e quanti meriti acquistarci! – Questo suo consiglio era l’eco della divina parola: “Tutto quello che può operar la tua mano, fallo con sollecitudine; perocchè nè azione, nè pensiero, nè sapienza, nè scienza ha luogo nel sepolcro, verso del quale tu corri[29]”.
E vedremo più tardi come Giovanni sapesse occupare incessantemente il suo tempo.
CAPO X.
Un cattivo negozio – I polli d’India rubati e lezione di prudenza – La guardia alla vigna – Il folletto e il fanciullo coraggioso
SEMBRERANNO a taluno cose di poca importanza quelle che passiamo a descrivere in questo capitolo; ma pure io giudico non doverle tralasciare, perchè giovano a palesare sempre meglio i modi, coi quali Margherita procedeva nell’educazione de’ suoi figli. Giovannino avea soli cinque anni e stava con Giuseppe guidando al pascolo un piccolo branco di tacchini. Passando per di là un uomo furbo matricolato e vedendo i due ingenui fanciulli, pensò di truffar loro un gallo d’India. Quindi si avvicinò e disse: – Volete vendermi un tacchino? – I due fanciulli si guardarono in faccia, sembrando loro una fortunata occasione quella, che loro offriva il mezzo di fare il negoziante e guadagnar danari. E l’altro soggiunse: – Vi do cinque soldi. – Cinque soldi! – esclamarono. Parve loro che si trattasse d’una somma enorme; quindi senza pensare ad altro accettarono i cinque soldi, mentre quel farabutto, preso il tacchino più grosso, s’involò prestamente ai loro sguardi. I due giovanetti subito corsero ansanti dalla mamma: – Mamma, abbiam venduto un tacchino. [79]
– Oh! – rispose la madre, che non aspettava una simile notizia.
– E lo abbiam fatto pagar bene! Cinque soldi! – E a lei li porgevano trionfanti in palma di mano! Mamma Margherita non poteva credere a’ suoi occhi: – Poveretta me! Cinque soldi! Avete fatto un bel negozio! Non sapete che per lo meno potea valere quattro lire e mezzo? Quell’uomo è uno scroccone, e ve lo ha rubato.
I due bambini restarono di sasso a quelle parole, e quindi riavutisi e desolati si misero tutti e due a correre a precipizio in cerca del compratore. La mamma ebbe un bel chiamarli: essi nulla udirono, e si involarono uno da una parte e l’altro dall’altra in mezzo alle colline. Per andare in cerca di un tacchino, non badarono che lasciavano in piena balìa del primo che fosse passato tutta la frotta degli altri affidati alla loro custodia. La mamma, che dall’alto della finestra avea tutto osservato, scese con alcuni vicini e condusse i tacchini, che già incominciavano a sbandarsi, nel pollaio ed ivi li chiuse. Intanto i due fanciulletti che, come era da prevedersi, non si erano imbattuti con chi cercavano, ritornarono colla testa bassa, trasfigurati dall’angoscia e dal sudore; ma giunti che furono nel prato, pensate come rimanessero vedendo scomparsi tutti gli altri tacchini. Guardarono attorno: non vi era anima viva. Alzarono gli occhi alla casa, e anche lassù nessuno. Senz’altro pensarono che anche questi fossero stati rubati; perciò non è a dire quale fosse lo stato del loro animo nel ritornare a casa. Appena messo piede sulla soglia, a stento esclamarono: – Mamma, i tacchini non ci sono più! – Margherita li guardò sorridendo. Essi sospettando una migliore notizia le corsero ai fianchi: – Perchè ridete?
– Perchè i tacchini li ho ritirati io, e voi fate le cose senza riflettere. Un’altra volta non fidatevi del vostro giudizio, [80] ma chiedete consiglio a chi ne sa più di voi, e non avrete da pentirvi dopo il fatto. Così non venderete un tacchino per cinque soldi, e non vi metterete a rischio di perdere tutti gli altri. E che cosa avreste fatto qualora da soli così piccini aveste raggiunto il ladro?
Qui non posso trattenermi dall’osservare: chi avrebbe pensato allora che la divina Provvidenza deputava Giovannino ad essere il suo tesoriere e ad amministrare somme enormi in soccorso di tante svariate opere di carità?
Alcun tempo dopo Giovanni si accorse che mancava dal prato uno dei gallinacci, che egli aveva in guardia. Non aveva visto alcuno che si fosse avvicinato per rubarlo; ma ecco che, girando gli occhi attorno, scopre un cotale barbuto, di alta statura, il quale faceva sua via, con l’indifferenza di chi si preoccupava per nulla del piccolo pastorello. Ma il pastorello aveva fatto il suo ragionamento ed aveva conchiuso nella sua mente che niun altro poteva essere il ladro, fuori di colui. Nessun indizio però addimostrava quel tale di recar seco il tacchino mancante. Pure Giovanni si era così bene persuaso della cosa, che saltò sulla strada, gli corse dietro e con il coraggio di chi è sicuro di sè gl’intimò: – Non andrete avanti, se non mi restituite il tacchino. – Il forestiero guardò burbero l’arditello e – Ti ha dato volta il cervello, non è vero? Stammi allegro e buon giorno! – E Giovanni: – Non avete inteso? Fuori il tacchino! vi ho detto, che mi avete rubato. – Il forestiero aperse la giubba: – E dove vuoi che io lo abbia nascosto? – Giovanni non si sgomentò: – Ciò non fa che lo abbiate indosso: vi dico che lo voglio. – E quel tale: – Vedo che tu ami lo scherzo, e ciò non sta bene. Io non ho tempo da perdere con te. – Così dicendo si avviava. Ma Giovanni gli saltò innanzi: – No, che non partirete, senza avermi restituito il fatto mio, [81] perchè io griderò al ladro tanto che basti, e se non verrà nessuno, io mi avviticchierò alle vostre gambe, ma non vi lascierò andare. – Quell’uomo, vedendo tanta risolutezza e temendo di essere scoperto, andò dietro ad una siepe vicina e trasse fuori da un fosso un sacco, nel quale aveva nascosto il tacchino. Egli aveva divisato di ritornare sul far della notte e, quando fosse deserto il luogo, portarsi via tranquillamente la preda. Facendo però in quel momento di necessità virtù: – Vedi, disse a Giovanni, io volevo farti uno scherzo per vedere se ti accorgevi che fosse sparito il tuo gallo. – Così dicendo glielo rimetteva. – Va bene, finì con dire Giovanni; ora andate pei fatti vostri, ma guardatevi dal fare di questi scherzi una seconda volta, perchè non è scherzo da galantuomo.
Alla sera Giovanni salì a casa per raccontare alla madre la sua prodezza. Un’altra madre avrebbe lodato la franchezza del figlio e avrebbe inveito contro il ladro, riempiendo di quell’avvenimento le orecchie delle vicine. Margherita invece trovò che il figlio si era arrischiato troppo e gli diceva: – E se per caso non fosse stato lui che ti avea preso il tacchino, ti mettevi ad un brutto rischio, perchè poteva offendersi e darti una buona dose di busse.
– Ma io era sicuro che me l’aveva rubato! Non vi era nessun altro, e il tacchino l’avea visto pochi momenti prima.
– Non aver tu visto nessuno non era ragione per accusare subito costui. Poteva qualcun altro essersi avvicinato al prato e poi essersi nascosto dietro a qualche albero o siepe.
– Se io avessi fatto tutto questo ragionamento, il tacchino sarebbe stato perso.
– Ascoltami: non sarebbe stata una gran perdita; sai che io poi non ci tengo gran fatto a pretendere i miei diritti, quando si corre pericolo di offendere la carità o la pace coi [82] vicini. Per un grappolo d’uva o per un po’ di frutta che mi fosse tolta, io non amo far guerra a nessuno. Se fa d’uopo, si avvisa; del resto non casca il mondo per certe bazzecole.
– Dunque vi lasciereste portar via tutto, senza lamentarvi?
– Adagio: se si trattasse di compromettere il benessere della mia famiglia, allora vedresti se sono donna da far stare i prepotenti.
– Ma non vedete che quell’uomo era tanto sfrontato da aggiungere la bugia?
– E chi ti disse che fosse bugia? Potea benissimo averti fatto uno scherzo. Tu non ne avevi prova in contrario.
– Uhm! brontolò Giovanni un po’ incredulo.
– Ebbene: fosse anche stato colpevole, tu potevi accettar la scusa e risparmiargli quella confusione. Ti faccio poi osservare che le ultime tue parole erano di troppo. Dal punto che tu eri riuscito ad avere il gallinaccio, non c’era più bisogno di altro.
– Dunque ho fatto male?
– Non dico questo: la tua intenzione era buona e la cosa riuscì bene. Guárdati però dal parlare di questo fatto cogli altri; e, se incontrerai quell’uomo, fa le viste di aver tutto dimenticato. Ricordati che aver un solo nemico è di troppo.
Tuttavia, se Margherita era maestra di prudenza, era pur dessa che col suo esempio avea avvezzato i suoi fanciulli ad essere coraggiosi. A questo proposito ecco un grazioso aneddoto.
In uno di questi anni lamentavasi uno scarso raccolto di uva, e, costando quindi a caro prezzo, in sull’avvicinarsi della vendemmia era custodita con molta vigilanza dai contadini. In fatti certi ladruncoli andavano attorno di notte e spogliavano le vigne per arricchire a spese altrui le proprie cantine. [83]
Mamma Margherita, che abitava in una casa isolata, circondata da boschi, ed era sola con tre ragazzi, non trovavasi certo in istato di poter respingere chi fosse venuto a rapirle il fatto suo. Era perciò sempre in pericolo di veder un bel mattino scomparso il reddito migliore del suo podere. Qualche vite lungo il sentiero era già stata spogliata dai malviventi. Essa però avea un non so che di virile nel suo modo di pensare e di operare, da non lasciarsi sgomentare di nulla. Un giorno vide un uomo, il quale costeggiava la sua vigna come chi ha solo scopo di ricrearsi passeggiando, ma si accorse che di quando in quando osservava la siepe e le ripe quasi per istudiare un passaggio. Margherita sospettò come in quella notte le si volesse fare un brutto tiro, e, mettendosi in guardia, chiamò a sè i figliuoli, dicendo loro: – Temo che questa notte ci vogliano rubare l’uva: quindi staremo all’erta. Ma voi non dite una sola parola, osservate un profondo silenzio, e griderete con quanta voce avete in gola e col maggior fracasso possibile al ladro! al ladro! quando io ve ne darò il segnale.
Fattasi notte oscura, Margherita uscì fuori dall’uscio di casa, e senza alcun lume si assise per terra coi figli, che si erano essi pure seduti intorno a lei. Passò qualche tempo, ed ecco comparire un’ombra in fondo alla vigna, girare intorno alla siepe, e poi entrare nel podere, innoltrarsi lungo un filare e quindi fermarsi. Margherita osservava. Tutto era silenzio. I figli attenti non aspettavano che il segnale. Quell’uomo avea già staccato un grappolo, quando Margherita gridò: – Assassino! Dunque vuoi andare all’inferno per un po’ d’uva? – E i tre giovanetti ad urlare subito: – Ai ladri, ai ladri, presto, presto, gendarmi da quella parte; il ladro è là! Su, su, gendarmi, gendarmi – E, sbatacchiando molle e palette di ferro, facevano un fracasso dell’altro [84] mondo. A quelle grida improvvise il ladro, fuori di sè per lo spavento, lasciava l’uva, si precipitava giù dalla collina, e si dileguava non senza cadere a rompicollo in qualche fosso. Margherita, soddisfatta di quella vittoria, diceva allora ai figli: – Vedete, anche senza fucili noi abbiamo fatto scappare i ladri. – Tutti ridevano saporitamente. Il ladro però dopo poco tempo per altri furti cadde in mano della giustizia, ed ebbe parecchi anni di carcere.
Assuefatto così Giovanni ad aver l’animo insensibile alla paura, sapeva mantenere quel sangue freddo, che poi gli fu tanto necessario nelle svariate vicende e nei pericoli, ai quali tante volte andò incontro nella lunga sua vita. Il motivo soprannaturale è certamente quello che animavalo; ma la virtù in un cuore avvezzo da fanciullo ad essere meticoloso è come un generoso liquore in fragile vaso; ci vuole un miracolo perchè resista. Di Giovanni si può dire con verità ciò che del giusto si legge nell’Ecclesiastico: “Il padre di lui si morì…. e quasi non morì, perocchè ha lasciato dopo di sè chi lo somiglia; e nella morte sua non si attristò…. perocchè egli ha lasciato alla casa un difensore contro i nemici ed uno che sarà grato verso gli amici[30]”. E non doveva invero Giovanni essere custode della vigna del Signore, uno dei difensori della sua casa?
Altra prova d’intrepidezza diede Giovanni qualche anno dopo. Mamma Margherita si era sempre ben guardata dal raccontare a’ suoi figli paurose novelle, che alterassero la loro fantasia, come purtroppo fanno certe genitrici imprudenti, le quali a questo modo invece di giovani coraggiosi allevano dei codardi. Orbene un autunno, essendo Giovanni andato a [85] passare breve tempo di vacanza al suo paese, recossi alla casa materna in Capriglio, ove Margherita, per cagione delle vendemmie, soleva dimorare per qualche giorno. Il nonno, gli zii e le zie fecero liete accoglienze al nipote, ed avvicinandosi la notte, in aspettazione che fosse pronta la cena, qualcuno prese a narrare come nei tempi passati si udissero sopra nel solaio dei rumori di varia intensità, ora prolungati, ora brevi, ma sempre spaventosi. Tutti affermavano che solo il demonio era capace di recar disturbo in siffatto modo alla gente. Giovanni non voleva prestar fede a queste fole, ma sosteneva quei fenomeni doversi attribuire a più di una causa naturale, al vento per esempio, alla faina e via discorrendo. Intanto, essendo già oscuro, accendevansi i lumi. La stanza, nella quale si tenea conversazione, aveva un soffitto di assi, che serviva di pavimento ad un largo sottotetto, destinato a granaio ed a magazzino degli altri raccolti. Ad un tratto si ode il fracasso di un corpo che cade, come di un cestone pieno di bocce, e poi un rumore sordo e lento che si strascina sul loro capo da un angolo all’altro della stanza. Cessano i ragionamenti, e si fa un cupo silenzio. Ed ecco rinnovarsi quel sinistro inaspettato rumore. Le faccie di tutti impallidiscono.
Che cosa sarà? si interrogano a vicenda sottovoce.
– Allontanati: dice Margherita a suo figlio: vieni, usciamo; ti potrebbe far del male una paura inaspettata.
– Ma no, replica Giovanni: voglio vedere che cosa c’è.
Intanto il rumore continuava ad intervalli, e realmente a quell’ora avea un non so che di pauroso per essere inesplicabile. Tutti i radunati si guardavano in faccia.
– La porta di casa forse fu lasciata aperta? – interrogò uno di quelli.
– No, è chiusa a chiave – rispose un altro. [86]
– Dunque?
Giovanni si alzò risoluto, accese una lucerna e disse: – Andiamo a vedere.
– Ma senti, aspettiamo domani…. la prudenza…
– Che! avreste paura?
Così dicendo, salì la scala di legno che metteva nella soffitta. Gli altri, ciascuno con una lucerna accesa ed un bastone in mano, venivangli tutti dietro tremanti e parlando sottovoce. Giovanni spinse la porta del solaio, entrò e alzando la lanterna guardò attorno. Non si vedeva nessuno. Tutto era silenzio. I suoi parenti parte si erano affacciati alla porta; uno o due soli avevano osato entrare. Ed ecco tutti levare un grido ed alcuni darsi alla fuga. Accadeva un fatto strano: un vaglio da grano, che era in un angolo, muoveasi da sè e si avanzava. Alle grida di spavento, il vaglio erasi fermato; ma, cessate queste, dopo qualche istante si rimise in moto e venne a fermarsi ai piedi di Giovanni, che aveagli fatto qualche passo incontro. Giovanni porge il suo lume a chi gli era più vicino, ma costui spaventato lo lascia cadere per terra e il lume si spegne. Allora, fattosi dare un altro lume acceso, lo pone sopra una vecchia sedia e curvandosi mette le mani sul vaglio. – Lascia, lascia! – gli si grida da chi sta sulla porta. Egli non bada e solleva da terra il vaglio. Qui fu uno scoppio di risa universale. Sotto il vaglio stava una grossa gallina!
Ecco come era andata la cosa. Il vaglio stava appoggiato piuttosto pendente verso il pavimento, coll’orlo dalla parte del muro. Siccome tra i vimini rimanevano alcuni granelli di frumento, così la gallina era passata disotto per beccarseli. Ma il vaglio scorrendo cadde sulla gallina, la quale restò così prigioniera. Stanca però di star là sotto e affamata, cercava di uscire, e non potendo sollevare quel peso, urtava nelle sue pareti. Così essa spingeva la sua [87] carcere, che essendo molto leggiera facea correre da una parte all’altra del solaio. Il silenzio della notte, il pavimento di assi e la paura aveano fatto sembrare formidabile quel rumore.
Una matta allegria successe a quel panico e la gallina ne pagò le spese. Margherita la prese: – Non ce ne farai più di queste paure – disse, e issofatto le torse il collo, e, spiumata, fu messa a cuocere. – Il folletto è nella pentola! – gridavano quei della famiglia. Fu apprestata all’improvviso una magnifica cena; nessuno ebbe voglia di andare a dormire, e così passarono la notte contenti di essere liberati da quello spauracchio e occupati nel sorvegliare tini e le botti
Tale fu sempre Giovanni. Dà una gran sicurezza al giovane l’essere persuaso di trovarsi in grazia di Dio: “Non tremerà e non avrà paura di cosa alcuna colui che teme il Signore; perchè questi è sua speranza. Se ti fiderai dell’aiuto di Dio, non temerai i notturni spaventi, nè lo spettro che va attorno nelle tenebre[31]”.
CAPO XI.
Il pastorello diligente – Umiltà di Giovanni e sua mortificazione nel cibo – Suo esercizio di preghiera.
PRIMA di procedere nel nostro racconto egli è d’uopo accennare al luogo, ove accaddero le scene che stiamo per esporre. Chi fa la strada che da Buttigliera mette alla borgata dei Becchi, frazione di quella di Morialdo, vede alla sua destra una collina, su di essa un’umile casetta e ai piedi fino alla strada un prato ombreggiato da varii alberi. Quella casetta era l’abitazione di Margherita, e in quel prato i suoi figli, prima Giuseppe e poi Giovanni, conducevano al pascolo e custodivano una vaccherella.
“L’oziosità è maestra di molti vizii[32]”, era l’avviso che, ripetuto all’orecchio di questi giovani, li persuadeva a fuggir l’offesa di Dio e a spiegare un’attività continua, sicchè per loro era divenuto necessario un non mai interrotto lavoro. Ed era cura di quella sollecita genitrice di tenerli sempre occupati in cose compatibili colla età loro.
Margherita aveva adunque affidato a Giovannino l’ufficio di pastore, ed egli l’aveva preso con singolare diligenza; e però ogni giorno vedevasi tenere con una mano la corda [89] legata alle corna della mucca, perchè non andasse a recar danno al campo dei vicini. Così ci narrava Giovanni Filippello, suo coetaneo, il quale affermava, che fin da quella prima età Giovannino faceva trasparire dalle sue azioni come in lui vi fosse qualche cosa di non ordinario. “Io andava al pascolo con Giovanni Bosco, che allora aveva circa sette anni: egli si attirava l’ammirazione di chi lo guardava, poichè il vederlo per una parte così modesto in volto ed umile, col capo leggermente chino, e per altra parte così allegro e faceto, rapiva i cuori. Io spesso gli diceva: – Tu, Giovanni, non mancherai di riuscire a bene. – Egli mi rispondeva con semplicità: – Lo spero”.
Un altro suo compagno in quei luoghi di pascolo, certo Secondo Matta, servitorello in una delle masserie circostanti, e della sua stessa età, ogni mattino scendeva dalla collina traendosi dietro la vacca del padrone. Per la colazione era provvisto di un pezzo di pane nero. Giovanni invece teneva fra le mani, sbocconcellandolo, un pane bianchissimo che mamma Margherita non lasciava mai mancare a’ suoi cari figliuoli. Un bel giorno Giovanni disse a Matta: – Mi fai un piacere?
– Ben volentieri, rispose il compagno.
– Vuoi che facciamo lo scambio del pane?
– E perchè?
– Perchè il tuo pane deve essere più buono del mio, e mi piace di più. – Matta, nella sua infantile semplicità, credette che Giovanni reputasse realmente più gustoso il suo pan nero, e facendogli gola il pane bianco dell’amico, volentieri accondiscese a quella permuta. Da quel giorno, per ben due primavere di séguito, tutte le volte che al mattino s’incontravano in quel prato facevano lo scambio del pane. Matta però, divenuto uomo e riflettendo su questo fatto, lo raccontava soventi volte a suo nipote D. Secondo Marchisio Salesiano, osservando che il [90] movente di Giovanni a far quello scambio non poteva essere altro che lo spirito di mortificazione, poichè il suo pan nero non era certamente una ghiottoneria.
Quella specie di solitudine era per Giovanni occasione di pregare. Aveva imparato da sua madre; la quale, oltre le orazioni prescritte dall’usanza, cui recitava in ginocchio col massimo raccoglimento, lungo la giornata, in mezzo alle più svariate occupazioni, continuava a labbreggiare parole di affetto verso Dio. Quanti conobbero Giovanni fanciullo, ci attestano questo suo amore alla preghiera e la sua grande divozione verso Maria SS. Il santo Rosario gli dovea essere famigliare, imperocchè dai primi tempi dell’Oratorio fino agli ultimi anni di sua esistenza, volle che impreteribilmente fosse recitato dai giovani tutti i giorni: non ammise mai che ci potesse esser causa che dispensasse una comunità dalla recita di questo. Era per lui pratica di pietà necessaria per ben vivere, quanto il pane quotidiano per mantenersi in forze e non morire. Oltre a ciò, tutte le volte che la campana di Morialdo suonava l’Angelus Domini, ei toglievasi immantinente il cappello e piegava il ginocchio per salutare la sua Madre celeste. Giovanni Filippello aggiungeva tale essere stato il suo trasporto per la pietà, che sovente udivasi coll’argentina sua voce far risuonare il colle di laudi sacre.
La preghiera unita al lavoro mantiene la purità dell’anima; sicchè puossi argomentare che Giovanni conservasse immacolata quella virtù che rende gli uomini simili agli angioli. Non fa quindi meraviglia che Marianna Occhiena affermasse molte volte e con persuasione vivissima a Giuseppe Buzzetti, che di quando in quando la Madonna SS. apparisse a suo nipote, mentre era solo nel prato in pastura, e gli rivolgesse la parola. Non abbiamo argomenti per provare un simile favore celeste, ma notiamo come questa diceria ben dimostra [91] in quale stima fosse tenuta la sua fanciullezza da chi lo conosceva così da vicino.
Mentre sulla collina dei Becchi si svolgevano queste semplici scene, una straordinaria funzione, in un giorno feriale del 1822, attirava in parrocchia i Castelnovesi. Il Vicario foraneo D. Giuseppe Sismondo, con tutto il suo clero radunato innanzi all’altar maggiore, essendo presenti il sindaco ed un consigliere municipale come testi, giuravano fedeltà al Re Carlo Felice, salito in trono nell’anno antecedente, e a’ suoi successori. Quest’ordine sovrano riguardava tutto il clero del suo regno. Il Papa ne aveva accordata la chiesta licenza, benchè fosse un’ingiuria dubitare della fedeltà dei sacerdoti al loro Sovrano. E fu allora che Mons. Fransoni, Vescovo di Fossano, esclamò con ragione: Incidimus in tempora mala; prevedeva l’avvenire e conosceva il mal animo dei cortigiani. Questi infatti aveano messo la diffidenza nell’animo del Re verso di Mons. Chiaverotti, Arcivescovo di Torino, benchè non si venisse mai ad aperta rottura. Monsignore era troppo rispettoso verso il suo Sovrano, e Carlo Felice, ossequente all’autorità ecclesiastica, aveva animo profondamente cristiano: in moltissime circostanze fu benemerito della Chiesa e in più altre seppe moderare le pretese de’ suoi ministri, che non erano come lui delicati nel rispettarne i diritti. Contuttociò non fu costante nel mantenerne alcuni: la triplice immunità ecclesiastica era stata ristabilita nel 1814, ma, venuta in uggia ai novatori, poco durò nel suo pieno esercizio. Quindi, dietro istanza del Re, Roma nel 1823 diè licenza agli ecclesiastici di presentarsi, citati, come testimoni, innanzi ai tribunali laici, così nelle cause civili come nelle criminali; con certe limitazioni però che mettevano in salvo il decoro del prete. Ma il carattere sacerdotale, l’ufficio di pastore, di confessore, di consigliere, di confidente naturale del popolo, [92] non meritava forse egli un privilegio di pochi, pel bene che a tutti ne veniva coll’esimere il prete da ogni nota odiosa? I ministri vollero ancora nel 1824 sottomettere alla revisione civile le pastorali dei Vescovi, e pretendevano di modificarne le frasi che loro non garbavano, arbitrandosi di opporre un veto, se il Vescovo non si sottometteva. Il Re diede ragione ai Vescovi che a lui fecero ricorso; i ministri cedettero nei casi particolari, ma non mutarono gli ordini dati agli stampatori di non imprimere senza l’approvazione.
Lo stesso suo antecessore e fratello Vittorio Emanuele I, Sovrano pio, giusto e di cuore, rispettoso e obbediente verso la Chiesa, che aveva ristabiliti gli Ordini religiosi, ebbe intorno tali ministri che, come il Presidente Conte Peiretti, Ambasciatore a Roma, solevano dire: – Tutto quanto è oggetto di speranza in Roma, deve essere di timore a noi e dobbiamo astenerci dal concederlo. – Le tradizioni regaliste non erano spente nella Corte, e i Consiglieri della Corona si adoperavano a porre nell’animo del Sovrano il dubbio che certi privilegi del clero più non fossero compatibili colla mutata condizione dei tempi. E lo stesso Vittorio Emanuele nelle istruzioni date per iscritto al Conte Barbaroux, Inviato presso la S. Sede, gli aveva inculcato che diffidasse del Papa in quanto principe temporale. E si fidava delle altre Potenze d’Europa, mentre in Torino nei palazzi degli Ambasciatori di Francia e di Spagna e dell’Inviato di Baviera si raccoglievano le segrete riunioni dei settarii, che fecero scoppiare quella rivoluzione del 1821, dalla quale intimorito volontariamente abdicava al trono in favore di Carlo Felice!
Tutto ciò era effetto delle massime insegnate nell’Università di Torino e che si compendiavano in questo motto: – O il Papa acconsente a ciò che noi vogliamo, o ciò che vogliamo faremo egualmente! – Massima che in buona [93] sostanza spianava la strada a tutti i nemici della Chiesa. Il Conte La Margherita dichiarava poi essere stata una fortuna per lui aver studiato da sè il diritto ecclesiastico in autori non condannati dalla Chiesa, avendo presa la laurea in legge prima della restaurazione, quando non vi era in Torino la cattedra di diritto canonico.
Di questi ministri adunque, di questi dottori aggregati, quanto non era migliore un umile fanciullo, che altro non sapeva che il suo catechismo. “Sono più intelligente dei vegliardi, perchè osservo i tuoi comandamenti”: così poteva dir Giovanni col Salmista[33]. In fatti quelli prepararono rovine senza numero alla società, mentre il giovane pastorello ne preparava ampia ristorazione. Egli, che fu poi sempre così intrepido, fedele nel servir a Dio ed alla S. Chiesa, avrebbe eziandio potuto con verità far sue le parole dell’Ecclesiastico: “Quando io era tuttor giovanetto, prima d’inciampar in errori, feci professione di cercare la sapienza colla mia orazione. Io la domandai dinanzi al tempio, come fino all’estremo punto la cercherò; ed ella gettò il suo fiore come l’uva primaticcia. Il mio cuore trovò in essa il suo gaudio. Il mio piè battè la strada diritta, andai in cerca di lei fin dalla giovinezza. Chinai un poco le mie orecchie (con animo docile a’ suoi ammaestramenti) e l’ascoltai. E molta sapienza accolsi nella mia mente e molto in essa mi avanzai. A Lui che mi dà la sapienza, io darò gloria. Perocchè io mi sono risoluto di metterla in pratica! Ebbi zelo del bene e non avronne rossore. Per lei ha combattuto l’anima mia e mi tengo costante nel seguitarla[34]”.
CAPO XII.
I fratelli – Ritratto di Giovanni – Giovanni impara a leggere – La prima scuola a Capriglio – Il maestro D. Lacqua e progressi di Giovanni nella virtù – Giovanni perdona a chi lo insulta – Le prime sue prove in mezzo ai giovanetti.
I TRE figliuoli lasciati da Francesco Bosco a Margherita Occhiena, Antonio, Giuseppe e Giovanni, erano diversi per indole e per inclinazioni. Antonio, rozzo di modi, di poca o nessuna delicatezza di sentimento, millantatore, manesco, era il vero ritratto del me ne infischio! Messo a scuola, avea imparato a leggere e a scrivere; ma vantavasi di non avere mai studiato e di non essere mai andato a scuola. Di certo, egli non avea attitudine agli studi; si occupava nei lavori della campagna, e per robustezza sarebbe riuscito davvero un buon lavoratore.
Giuseppe, di un’indole dolce e tranquilla, tutto bontà, pazienza e oculatezza, seguiva volentieri la condizione paterna; ma avea un ingegno sottile per trarre vantaggio da ogni cosa, anche da quelle che poteano sembrare poco utili; cosicchè sarebbe riuscito un esperto negoziante, se non avesse amato la vita pacifica dei campi.
Giovanni invece aveva sortito un naturale facilmente accendibile ed insieme poco pieghevole e duro, sicchè di [95] grandi sforzi avea d’uopo per vincere se stesso. Di carattere piuttosto serio, parlava poco, osservava tutto, pesava le altrui parole, e cercava di conoscere le diverse indoli e indovinarne i pensieri per sapersi regolare con prudenza. Nelle cose ridicole che udiva, o che esso stesso faceva o pronunciava, non fu mai visto ridere sgangheratamente. “Il fatuo se ride alza la voce, dice l’Ecclesiastico, ma l’uomo saggio appena sorride senza rumore[35]”. Dotato di cuor grande e di vivace ingegno, egli imitava con facilità qualunque arte o mestiere avesse visto esercitare dagli altri. Tenace ne’ suoi propositi, colla pazienza seppe superare tutte le traversie della vita per arrivare al suo scopo. Certo Giovanni Becchis, abitante dei Becchi, che conobbe Giovanni Bosco bambino, aggiunge come egli fosse di un’obbedienza straordinaria, tantochè le madri lo portavano per esempio ai loro figliuoli.
In quanto al suo esterno, di statura media, agile di corpo, era di gradevole aspetto. Il suo viso paffutello, di forma ovale, con fronte spaziosa e serena: regolare il naso e le labbra, e queste sempre atteggiate a un calmo sorriso; mento ben torniato e grazioso; occhi piuttosto neri variegati, penetranti, secondo la luce dei quali mutava espressione la sua fisionomia; capo adorno di fitti e ricciuti capelli, di color biondo scuro come le sue sopracciglia: ecco il ritratto che di lui ci dánno i suoi coetanei.
Le relazioni tra Antonio e gli altri due fratelli erano sempre tese; Giuseppe e Giovanni invece si volevano un bene dell’anima: ciò che voleva uno era pur voluto dall’altro; fra loro non ci fu mai il minimo dissapore; anzi ciascuno [96] di essi andava sempre a gara per cercare di far ciò che sapeva tornar più gradito al fratello.
Era l’anno 1823, ottavo del terzogenito di Francesco. La buona madre intravedendo forse come la Provvidenza non destinasse Giovanni alla vita dei campi, desiderava di mandarlo alla pubblica scuola di Castelnuovo, nella quale l’insegnamento riducevasi alla lettura, scrittura, alle prime quattro operazioni di aritmetica, ai primi rudimenti della grammatica italiana ed al catechismo; ma trovavasi assai impacciata per essere la sua borgata distante da Castelnuovo cinque chilometri circa e perchè ciò importava qualche spesa in famiglia, sia per la debita pensione, sia per le necessarie provviste. Se ne aperse pertanto con Antonio, che aveva raggiunto il suo ventesimo anno di vita, il quale subito si oppose a questo giusto desiderio: – Perchè mandar Giovanni a scuola? andava brontolando. Prenda la zappa, come l’ho presa io!
– Mandando a scuola Giovanni, rispondeva Margherita, non fo una preferenza. Anche Giuseppe andò ad imparare a leggere ed a scrivere, e tuo padre ha pure usato questo riguardo con te.
– Ma voi avete parlato di collegio.
– Guarda: finora siamo andati avanti e bene nei nostri affari, e il Signore ci ha sempre aiutati. Persuaditi che nessuno consumerà la tua parte. Adesso è una necessità studiare: fino i calzolai e i calderai studiano: è venuta cosa comune andare a scuola. – Antonio rispondeva, che egli era cresciuto uomo grande e grosso, senza aver bisogno di scuola e di studio; e però si impuntava nel combattere il desiderio di Margherita.
Qui splende la prudenza di mamma Margherita. Quantunque Antonio fosse suo figliastro, tuttavia essendo primogenito avea per lui una deferenza unica piuttosto che rara, tanto più che nulla egli avea fatto per meritarsela. Ella non [97] intraprendeva cosa alcuna senza prima consigliarsi con lui, o persuaderlo qualora fosse di opinione contraria; e cedeva volentieri, allorchè si avvedeva che il partito da prendersi non gli andava a genio. Così conservava quella preziosa pace nella famiglia, che in terra è il primo tesoro dopo la grazia dì Dio. Pel momento adunque Margherita non credè d’insistere; ma, atteso tempo più opportuno, fece intendere ad Antonio come avesse deposta ogni idea di mandar Giovanni a Castelnuovo. Restava tuttavia ferma sul progetto di farlo studiare. Antonio ne fu contento.
Nell’agosto di quest’anno tutte le chiese si vestivano a lutto: il suono funebre delle campane annunziava la morte di Pio VII, accaduta il 20 del mese. Trascorse poche settimane, la novella dell’elezione di Leone XII, proclamato Papa il 28 settembre, ritornava la gioia e l’esultanza in tutti i cristiani. Quanto in quei giorni si parlò del Papa, al quale i piemontesi portavano un amore tenerissimo! Avevano visto tante volte Pio VII, avevano pianto al suo martirio, avevano giubilato a’ suoi trionfi. Il suo ritratto era tenuto esposto come in venerazione in tutte le famiglie: tutti ne conoscevano le amabili sembianze; e non sono molti anni che nelle case de’ benestanti si vedeva ancora ritratta in tela l’effigie di questo grande Pontefice. Le impressioni della fanciullezza non si cancellano mai, ed io non dubito asserire aver questi avvenimenti fatto scintillare nel cuore di Giovanni quell’affetto al Papa, che doveva un giorno informare tutte le splendide imprese della sua vita.
Margherita intanto, venuto l’autunno, col consenso d’Antonio prese un temperamento. Giovanni in tempo d’inverno avrebbe frequentato tutti i giorni la scuola pubblica del vicino paesello di Capriglio, per impararvi gli elementi di lettura e scrittura. Ne era maestro il cappellano D. Giuseppe [98] Lacqua, sacerdote di molta pietà; e Margherita andò a visitarlo, pregandolo ad accettare il figlio alle sue lezioni, poichè la tenera età non permettevagli di percorrere la via tra i Becchi e Castelnuovo. Il cappellano non volle accondiscendere, non essendo obbligato a ricevere in iscuola giovanetti di altri Comuni. Margherita, vivamente contrariata, non sapeva a qual partito appigliarsi, quando un buon contadino si offerse ad essere il primo maestro di Giovanni nel leggere. Fu accettata la sua caritatevole prestazione, e Giovanni imparò in quell’inverno 1823- 24 a compitare assai bene. Il bravo uomo gloriavasi or sono pochi anni con D. Michele Rua di aver avuta questa fortuna.
Frattanto il Signore disponeva gli avvenimenti in modo che Margherita fosse consolata. Nel 1824 moriva a Capriglio la fantesca di D. Lacqua, e prendeva il suo posto Marianna Occhiena, sorella di Margherita, la quale amava molto i suoi nipotini e di quando in quando veniva ai Becchi per trovarli. Marianna pregò subito il cappellano di voler far scuola a Giovanni, ed egli per riguardo alla nuova fantesca, che già conosceva come persona religiosissima e fedele, non potè rifiutarsi ed acconsentì a fargliela gratuitamente. La zia Marianna, che aprì la via agli studi elementari al piccolo Giovanni, dopo aver assistito quel venerando cappellano fino all’ultimo istante di sua vita, rimanendo celibe venne a finire i suoi giorni nell’Oratorio di S. Francesco di Sales, impiegando la sua caritatevole attività in pro dei giovani quivi ricoverati.
Trovandosi adunque la zia a Capriglio, per Giovanni era come recarsi in casa propria. Le scuole incominciavano poco dopo le feste d’Ognissanti, e duravano tutt’al più fino alla festa della SS. Annunziata. Giovanni in così tenera età, nella più rigida stagione dell’anno, incominciò a percorrere quasi ogni giorno per pioggia, neve, fango e freddo circa quattro [99] chilometri. D. Lacqua prese a volergli grandissimo bene e ad usargli molti riguardi, occupandosi assai volentieri della sua istruzione e più ancora della sua educazione cristiana. Sorpreso della speciale sua attitudine alla pietà e allo studio, aggiungevagli spiegazioni alle verità già apprese dalla madre, avvertivalo sui mezzi necessari per conservare nell’anima la grazia di Dio, istruivalo con precisione sul modo di accostarsi con frutto al Sacramento della Penitenza e sulla necessità della mortificazione cristiana, per praticare la quale fa d’uopo vegliare continuamente sulle proprie azioni anche minime, acciocchè non siano guaste dalla superbia. Era un passo avanti che Iddio faceva muovere a Giovanni. I suoi condiscepoli più giovani lo maltrattavano tenendolo per uno sciocco. È naturale che un giovanetto, vissuto nell’isolamento di una cascina, si senta sul principio impacciato in mezzo ad un numeroso stuolo di sconosciuti compagni. Ma Giovanni non cercò mai difendersi, come avrebbe facilmente potuto, anche quando non era più novizzo. E poi non aveva un sicuro appoggio nella zia e nel maestro? Eppure amò meglio sopportare con pazienza, senza fare le proprie ragioni. Ciò narrava il Sig. Antonio Occhiena di Francesco, che fu sindaco di Capriglio, il quale allora sedeva sugli stessi banchi con Giovanni Bosco. Pare anzi che Giovanni fino da questa sua prima età abbia preso amore ad alcune penitenze da lui segretamente praticate, come risulterà dal complesso di questa istoria, e che per i racconti del suo maestro siasi invogliato ad imitare la vita dei Santi.
Sebbene egli frequentasse regolarmente la scuola di Capriglio nel solo inverno 1824 e 1825, tuttavia potè fare molto progresso nel leggere e nello scrivere. Nel tempo libero dalle lezioni andava al pascolo, e nell’estate appagò suo fratello Antonio lavorando eziandio la campagna. Però, secondo che [100] affermano tutti quelli della borgata, appena fu capace di leggere, attese a questo esercizio con grande ardore, per potersi abilitare a farsi prete, come fin d’allora ne aveva manifestato il desiderio. Suo fratello Giuseppe narrava che anche in tempo di pranzo Giovanni teneva sempre in mano un libro e continuava a leggere. Ed il libro suo prediletto era il catechismo, che sempre portò seco finchè non ebbe incominciate regolarmente le scuole. Questo prezioso libretto fu per lui fonte di nuove grazie. Dicono i libri sacri: “I tuoi pensieri sieno fissi nei precetti di Dio, e medita di continuo i suoi comandamenti; ed egli ti darà un cuore, e la sapienza bramata da te ti sarà conceduta[36]”.
Venuto il novembre, quando incominciarono a cadere le prime nevi e si dovette cessare ogni lavoro all’aperta campagna, Giovanni parlò di ritornare a scuola. Antonio si fece serio, e Margherita credette bene non far valere la propria autorità. Non mancando pretesti o necessità per mandare Giovanni a Capriglio, o per visitare la zia, o per recare commissioni al nonno, egli potè intrattenersi, benchè non troppe volte, in quell’inverno 1825 e 1826, con D. Lacqua, esercitarsi nello scrivere ed aver anche qualche libro per leggere; ma non andò guari, che dovette interrompere ogni relazione con quel sacerdote. Duro martirio per chi sente in sè vivo il desiderio d’imparare!
Intanto venivano in lui svolgendosi e crescendo i germi delle virtù gettate nel suo cuore dalla madre e dal maestro. Il sullodato Secondo Matta rendeva un’altra onorevole testimonianza alla condotta di Giovanni suo compagno nella pastorizia. Quattro o cinque altri giovinetti conducevano le loro [101] mucche al pascolo nei dintorni del prato, ov’era Giovanni. Irriflessivi e negligenti, molte volte lasciavano le bestie senza custode, e si allontanavano correndo su e giù, o salendo sugli alberi o intrattenendosi in varii giuochi. Giovanni non prendeva mai parte in quel tempo ai loro divertimenti, ma stava isolato pregando o leggendo continuamente. Molte volte fecero le prove d’invitarlo ad andare con essi, ma ognora cortesemente si rifiutava. Un giorno finalmente quei birichini, risoluti di vincere a qualunque costo ed anche a viva forza la ritenutezza di Giovanni, gli si avvicinarono, e circondatolo gli dissero, senz’altro, con un fare insolente: – Questa volta verrai a giuocare con noi.
– Fatemi il piacere, rispose Giovanni; lasciatemi in pace: divertitevi fin che volete, non vi sarò di impedimento, ma io ho altro da fare.
– Non intendi che noi vogliamo che tu venga e tu devi venire?
– Scusatemi, io non m’intrigo dei vostri affari, e non so perchè voi vogliate intromettervi ne’ miei. Io non disturbo voi, e voi non dovete disturbar me.
– Non sai che questo tuo modo di diportarti è un vero disprezzo per noi? E chi sei tu che non ti degni di venire in nostra compagnia?
– Io disprezzarvi? anzi, quando voi vi sollazzate, non sono io che tengo d’occhio le vostre vacche e impedisco che vadano a recar danno su quel degli altri, risparmiandovi così rimproveri e castighi?
– Orsù, gridò allora il più audace, se noi veniamo a questione teco con parole, sei capace di metterci nel sacco colle tue ragioni. Ma noi siamo risoluti, che tu debba a tutti i costi prendere parte ai nostri giuochi. Non più tante parole; vieni! [102]
– Voi siete ragionevoli e non vorrete costringermi; giuocate pure, lasciate a me la cura del vostro armento, ma lasciatemi tranquillo.
– Assolutamente no! tu devi venire.
– Perdonatemi, ma io non vengo!
– E se non vieni, hai da far con noi!
– Vi ho detto che non verrò e non vengo.
– Non verrai? Ebbene!…..- Tutti si slanciarono su di lui, e coi pugni serrati incominciarono a tempestarlo con tante percosse, quante bastarono per dar sfogo alla loro bestiale irritazione. Giovanni, che in quell’età era già molto robusto, avrebbe potuto gettare a terra e lasciare malconci que’ suoi coetanei, ma al contrario senza difendersi, senza lamentarsi sopportò l’ingiuria e le percosse che non furono poche. Come i compagni ebbero compiuto quell’indegna vendetta, si allontanarono sghignazzando e minacciando, e andarono a riprendere i loro divertimenti. Giovanni ritornò a sedersi tranquillo all’ombra del suo albero e a guardare eziandio l’armento di quegli spensierati. Ai quali, venuti nuovamente a chiedergli se, dopo quella dura lezione, fosse disposto a giuocare, rispose: – Battetemi pure, ma io non giuocherò mai, perchè voglio studiare e farmi prete.
Questa risposta e la sua pazienza fece tale impressione sull’animo di quei ragazzi, che si misero d’accordo di custodirgli essi stessi la vacca. – Non pensarci più, gli dissero, a disturbarti per le bestie, chè ci penseremo noi, e tu continua a leggere.
Qui notiamo come Giovanni non abbia mai adoperata la forza per vendicarsi, ovvero per difendersi con violenza, ma sibbene l’usasse qualche volta per difendere i compagni più deboli quando erano oppressi da prepotenti. Eppure egli [103] era fornito eziandio di un ardimento e di una risolutezza non comune.
I compagni da quel punto divennero suoi amici; e quando cessava dal pregare o dal leggere, venivano a lui, ed egli, trattenendoli con incantevole dolcezza, prendeva a discorrere con tanta accuratezza che, affezionandoseli sempre più, esercitava sopra di loro una certa autorità. Loro ripeteva quanto aveva appreso nei catechismi o nelle prediche, li istruiva così nella religione il meglio che sapeva, e compieva questa missione con vantaggio morale e intellettuale dei medesimi. Talora li intratteneva nel canto di lodi sacre, alternandole col racconto di qualche favola amena; tal’altra insegnava loro a dire le orazioni del mattino e della sera. In casa si dilettava nel fare piccoli altarini coll’immagine di Maria SS., che ornava di frondi e di fiori campestri, e dinanzi ai quali attirava poi gli altri fanciulli. Ed era costante in queste sue sante industrie, per tenere quei giovanetti lontani dalle cattive compagnie; e ciò faceva anche per suggerimento della stessa sua madre. Egli aveva un vivo timore dei giusti giudizi di Dio e un grande orrore al peccato, come ci narrava suo fratello Giuseppe. E in casa e nei prati, prima e dopo i suoi racconti o i suoi catechismi, faceva fare a tutti i suoi piccoli amici il segno della santa croce. Ed è degno di nota che a questi suoi trattenimenti non partecipavano mai le fanciulle.
Tuttora è voce comune in quei paesi che per la sua pietà Giovanni era oggetto di ammirazione fin dai suoi primi anni.
CAPO XIII.
I saltimbanchi – Giovanni si esercita nei giuochi di ginnastica e di prestigio – Un cavadenti.
IN quel tempo nacque in Giovanni un vivo desiderio di andare sui mercati e sulle fiere dei paesi vicini, per assistere a quei giuochi di prestigio e di forza, che mai non mancano in simili occasioni. Istintivamente si sentiva portato a primeggiare fra i suoi conterranei per giovare alle anime loro. Ma egli non aveva nulla che potesse attirare a sè l’attenzione degli altri: non studi, non ricchezze, non posizione sociale. Per soprappiù la sua casa era isolata, e non si trovava neppur in un centro ove potesse trattare con molti. D’altronde per entrare nell’animo di gente rozza e che naturalmente non si sarebbe assoggettata ad ascoltare le lezioni di un bambino, ci voleva per allettarla qualche speciale industria. Giovanni vide che la novità di un piacevole divertimento lo avrebbe reso padrone degli animi; ed eccolo a studiare il modo di rendersi valente nei giuochi di destrezza. Ne chiese licenza alla madre, esponendole un certo suo disegno, che poi vedremo da lui eseguito. La madre, dopo aver pensato alquanto, accondiscese volentieri, ma siccome era necessario far qualche spesa: – Aggiústati come vuoi e come sai, gli disse, ma non chiedermi soldi perchè non ne ho! – Lasciate a me il pensiero di [105] questo; saprò io cavarmi dall’impiccio: rispose Giovanni. – Vedremo nei capitoli seguenti come seppe industriarsi per aver danaro.
Fa meravigliare che una madre così prudente desse simile licenza al figlio, ma bisogna sapere che quei tempi erano diversi dai nostri; nelle popolazioni regnava maggiore semplicità di costumi, e fra i ciarlatani ve n’erano di quelli che poteano passare per gente onesta e morigerata. Il famoso Orcorte, la cui abilità è ancor ricordata adesso fra la gente dopo tanti anni che è morto, era inappuntabile in quanto a castigatezza di modi e di parole. L’autorità civile vegliava eziandio con bastante premura a tutela della pubblica moralità, e prestava mano forte al parroci, quando eravi un disordine da togliere. Ei poi non andava solo, ma accompagnato dalla madre o da persone sicure, alle quali la mamma affidavalo.
Giovanni incominciò pertanto ad andare alle fiere che due volte all’anno si facevano a Castelnuovo, e si trovava spesso sui mercati pel solo fine di incontrarsi coi ciarlatani e coi saltimbanchi. Appena sapeva giunto in qualche borgata chi ballava sulla corda o faceva giuochi difficili, subito là correva. Non già che si dilettasse dello spettacolo: voleva imparare. Andava risoluto di osservare attentamente ogni loro più piccola prodezza. Colà pagava due soldi per vederli lavorare più da vicino. Era tutt’occhi per sorprendere ogni loro modo o gesto più impercettibile, onde portarsi via le loro astuzie ed apprendere la loro destrezza. Ritornato a casa, si industriava e si esercitava a ripetere quei giuochi, finchè non avesse imparato a fare altrettanto. Nessuno può immaginarsi le scosse, gli urti, le cadute, i capitomboli, cui ad ogni momento andava soggetto in questi esercizii. Ma nulla importavagli; incominciava a fare un salto [106] ed anche due, ma al terzo stramazzava per terra sì da perdere il fiato. Rialzavasi, riposava un momento e poi ritornava alle sue prove. S’accingeva a ballare sulla corda; stendeva questa a certa altezza, con un rozzo bilanciere da lui fabbricato vi saliva sopra e quindi tentava quell’aerea passeggiata. Talora sbatteva al suolo così pericolosamente, da dover rimaner morto; ma per fortuna non si fece mai alcun male notabile, nè mai si perdette di coraggio. Con questa costanza, chi il crederebbe? a undici anni erasi fatto abile in ogni specie di salti e di giuochi. Sapeva i giuochi dei bussolotti, il salto mortale, la rondinella, camminava sulle mani, saltava e danzava sulla corda come un saltimbanco di professione. Avea pure imparato molti di quei prestigii, che fanno meravigliare coloro che non conoscono simili segreti. Oltre a ciò, egli, che non si dava pace finchè di quanto gli veniva sott’occhio non avesse avuta l’intera spiegazione, aveva seguìto con insistente osservazione ogni atto di un certo saltimbanco nel cavare i denti, arte nella quale era quegli peritissimo; e colla sua investigazione era riuscito a conoscere il modo di maneggiare la chiave inglese, la conformazione del dente incastonato nella gengiva, e il movimento della mano per strapparlo in un sol colpo.
L’assiduità di Giovanni a tali spettacoli sulle fiere, la sua attenzione, certe osservazioni fatte, certe interrogazioni mosse, aveano fatto nascere sospetti e diffidenze nei soliti ciarlatani, i quali si mostravano infastiditi della sua presenza, perchè lo conoscevano omai per uno che tentava di rubare loro il mestiere. Più di una volta si avvidero che avea penetrati i loro segreti. Ciò loro dava molta noia. Per conseguenza cercavano ogni mezzo per eluderne con destrezza l’attenzione, o volgendogli le spalle, o collocando qualche persona in modo che gli rimanesse celato il tavolino. Ma [107] Giovanni cambiava posto, e si poneva sempre loro in faccia o di fianco, sicchè riuscivano inutili quelle precauzioni.
Fra i varii aneddoti, che gli accaddero in questi tempi, non passo sotto silenzio il seguente, che egli raccontava spesse volte a’ suoi figliuoli per ricrearli. Queste sono per noi così care rimembranze, che quasi ci fan risuonare all’orecchio l’amabile voce, che nella nostra giovinezza ci fece passare tante ore felici di ricreazione. Lo scherzo e l’ameno racconto fluiva continuamente dalle sue labbra. Questa giovialità fu il carattere di tutta la sua vita, anche in mezzo alle cure più spinose, ai dispiaceri più grandi.
Sulla piazza, adunque, di un paese vicino era venuto a far sue prove un cantambanco, con musica e gran cassa. Giovanni in mezzo alla folla si era spinto tanto innanzi, che era giunto presso la carrozza. Il ciarlatano di sua conoscenza voleva levarlo di là, ma non ci fu verso. – La piazza è pubblica – diceva Giovanni. Dall’alto della vettura il ciarlatano incominciò a raccontare le sue fanfaluche come fosse venuto dal Gran Mogol, avesse percorsa tutta la Cina, fosse amico intimo di tutti i principi della Persia, avesse miracolosamente guarito il gran Kan di Tartaria, il Michado del Giappone ecc. ecc. ecc. Continuava come pel bene dell’umanità avesse per lunghi anni fatti studii profondi sulle erbe al chiaro della luna, e avesse scoperto dei segreti di natura così benéfici da far trasecolare lo stesso Salomone, se fosse ancor stato a questo mondo. Rinforzando la voce, annunziava urbi et orbi come avesse trovato un mezzo miracoloso per cavare i denti al suo uditorio, o con una spada, o con un martello, o col dito, ma però senza che il paziente avesse a soffrire il minimo dolore. Ciò asseriva doversi attribuire ad una certa polvere, che egli era venuto a vendere in quel paese a prezzi modicissimi, polvere [108] che avea la portentosa virtù di guarire eziandio mille altri mali. Per provare la sua asserzione sfoderava pergamene, lettere, patenti, attestati di benemerenza e faceva ciondolare in aria i sigilli di tutte le teste coronate del mondo. Affermava essere venuto in quel paese solamente pel bene dell’umanità sofferente, e quindi annunziava che chiunque avesse bisogno di guarire dal mal di denti, oppure di farsi togliere denti guasti si facesse pure avanti, chè egli senza il minimo suo dolore lo avrebbe servito.
Finita la magniloquente sua orazione, durante la quale aveva lanciato di quando in quando occhiate poco benevoli, anzi dirò sospettose sopra di Giovanni, mentre si asciugava il sudore, fece dare per un breve istante fiato alle trombe. Cessata la musica, ecco presentarsi un contadino a pregarlo di cavargli un dente, causa di atroci dolori. Il ciurmatore, fatto salire il paziente in alto sul cassetto del cocchiere, lo invitò ad assidersi, comprimendo un atto d’impazienza, che chiaro gli si leggeva tra le rughe della fronte. Il contadino, confuso per essere così esposto al pubblico, interrogò il ciarlatano:
– Quanto volete per paga?
– Uomo senza riputazione: rispose il ciarlatano. Io non lavoro per paga. Nessun danaro può pagare la mia abilità. Se vorrete farmi un dono dopo l’operazione, mi degnerò d’accettarlo per farvi piacere.
– E… non mi farete proprio nessun male?
– Lo stesso male come se neppur vi toccassi; aprite la bocca. – E il paziente aperse la bocca che sembrava un forno.
– Qual è il dente che vi duole?
– Questo! – rispose il contadino; e gli mostrò col dito un dente mascellare. Il ciarlatano allora si volse alla moltitudine degli spettatori, e magnificò il miracolo che presto tutti [109] avrebbero visto della sua abilità. Il contadino replicò: – Ma non fatemi male neh!
– State tranquillo, e vedrete che cosa sono capace di fare io!
Intanto Giovanni, appoggiato alle ruote della carrozza, osservava la scena cogli occhi sbarrati, con sulle labbra un certo sorriso sardonico e rattenendo quasi il fiato. Il ciarlatano, che lo teneva d’occhio, crollò il capo. Era uno scrutatore importuno per un uomo, la cui fisonomia manifestava essere contrariato da qualche circostanza imprevista. Forse aspettava qualcuno indettato per fare il giuoco, e quel villanzone inatteso avea furate le mosse all’altro. Fosse caso o combinazione, un forestiero erasi avvicinato alla carrozza pochi istanti dopo la comparsa di quel baggeo e aveva ammiccato cogli occhi il ciarlatano. Comunque fosse la cosa, il fatto sta che il ciarlatano non si perdette di animo, e messo un po’ della sua polvere sul dente cariato: – Or su, chiese; a vostra scelta: volete che adoperi la spada, il martello o semplicemente le dita? – Naturalmente rispose l’altro: – Le dita! – Il ciarlatano si accinse all’operazione. Giovanni, che non perdeva un solo de’ suoi gesti, si accorse che dalla manica avea fatto correre nella mano una chiave inglese, e fece un atto che indicava di aver compresa la cosa. Il ciarlatano gli diede un’occhiata fulminante, e mise le dita in bocca al villano. Il dente saltò fuori con stento, ed un ahi! formidabile uscì da quella bocca, appena potè formare il grido. Quell’urlo fu coperto da un – benissimo! – prolungato e contemporaneamente ancor più poderoso dell’urlo. Giovanni non potè trattenere le risa. Il ciarlatano sembrò imbrogliato per un istante, ma si mantenne a sangue freddo. Il villano si alzò gridando: – Contacc, bugiardo, impostore, mi avete assassinato, mi avete sconquassato le gengive! – [110]
La voce però era fioca sia pel dolore, sia pel sangue che dovea sputare. Ed il ciarlatano coprendola ripeteva:
– Benissimo! signori! sentano cosa dice quest’uomo! Esso non ha sofferto verun dolore! – Il villano inviperito continuava a protestare, e il ciarlatano tenendolo per le braccia, perchè temeva una colluttazione, gridava più forte: – Grazie, grazie! non incomodatevi: l’ho fatto per carità. – E lo spingeva a scendere, mentre quel forestiero vicino alla carrozza lo tirava giù prendendolo a braccetto, conducendolo via, come se fosse suo amico, e facendogli splendere innanzi agli occhi una moneta d’argento perchè tacesse. Una fragorosa sinfonia soffocò le sue ultime voci, mentre i contadini, che di nulla si erano accorti, si accalcavano per comprare la polvere meravigliosa. Giovanni, che solo avea goduto quella scena per essere vicino alla carrozza, continuava a ridere, ma nulla disse ai circostanti. Fu questa una delle ultime volte che presenziò i giuochi dei ciarlatani.
Tornato a casa raccontò alla mamma il lepido fatto, e del terzetto eseguito dalle grida del ciarlatano e del contadino, accompagnate dal zunne e zunne della gran cassa. Rise la buona madre; e: – Vedi, gli disse, fuggi sempre dai luoghi ove si fa fracasso; è un minchione chi vi si lascia cogliere: gli cavano i denti. Sai per qual ragione dove si giuoca, dove si beve, si sente urlare e cantare? Perchè ai disgraziati, che si lasciano circondare dalle cattive compagnie, in mezzo al frastuono si possa più facilmente strappare danaro, onore, stima, e soprattutto la grazia di Dio. Quanti incauti fanno a questo mondo una figura ancor più ridicola di colui, che hai visto sulla carrozza del ciarlatano!
Ma ora che cosa diremo noi di questo modo e di questi esercizii di Giovanni? Questa è certamente una pagina che potrà sembrar strana nella vita di un servo di Dio, e pochi [111] riscontri si troveranno in altre biografie di Santi. Ma lo Spirito del Signore spira dove vuole e come vuole. Il ricreare i giovanetti per attirarli agli Oratorii festivi doveva essere una necessità per i tempi che si preparavano, e il Signore in Giovanni avea creato la necessaria inclinazione, che rende più facile ciò che per altri sarebbe una croce insopportabile. Che cosa poteva trovar di meglio un povero contadinello, isolato in una borgata, senza un consigliere od un appoggio? E poi il suo fine era santo. “E noi sappiamo, dice S. Paolo, che le cose tutte tornano a bene per coloro che amano Dio[37]”.
Un altro grande pensiero si affacciava inoltre allora alla mente di Giovanni, e che più tardi gli faceva parlare con gusto di queste geste ciarlatanesche. Se tutti i sacerdoti, se tutti i cristiani nel sostenere l’onore di Dio coll’esempio e colla parola, nel perorare la causa dell’orfano e del derelitto, nell’imporre silenzio a coloro, i quali con scandalosi discorsi attentano alla fede e alla morale, avessero la franchezza dei ciarlatani nel raccontare le loro storie, nel vendere i loro cerotti, quale bene immenso si farebbe! I ciarlatani non hanno rispetto umano, si espongono al pubblico franchi, liberi da ogni timore, e traggono così la gente dalla loro parte per fare i propri interessi. Se il coraggio inspirato dalla carità, unito alla prudenza cristiana, ovunque e sempre mettesse in pratica il praedicate super tecta del divin Salvatore, quanto se ne avvantaggerebbero gli interessi divini per la salute delle anime!
CAPO XIV.
Giovanni in cerca di nidiate – Avventure graziose e lezioni morali della madre – Giovanni cade da un albero con pericolo della vita – Suo dolore per la morte di un merlo e generosa risoluzione di staccare il cuore dalle creature.
ERA desiderio di Margherita, che i suoi figliuoli trovassero qualche oggetto di ricreazione che tutta preoccupasse la loro mente; e però, siccome vedeva Giovanni preso da vaghezza di possedere uccelli, così colle debite precauzioni gli permetteva di andare in cerca di nidiate; anzi essa stessa gli insegnava quale cibo si confacesse alle varie specie di uccelli e lo rese pure abile a costrurre gabbie per rinchiuderneli. E difatti Giovanni imparò ben presto a farne delle grandi, solide e graziose, che riempiva di canori prigionieri.
Un giorno avendo scoperto nel tronco di un albero un nido di cinciallegre, si arrampicò per impadronirsene. Il nido era molto addentro nella fessura, che stretta e profonda non lasciava penetrare lo sguardo, e Giovanni avea conosciuta la qualità degli augelletti dalla madre che n’era volata via. Ficcò dunque il braccio, e dovette spingerlo molto avanti con grande sforzo fino oltre il gomito per giungere al nido. Ma, quando volle ritrarnelo, più non potè: il braccio [113] era preso come da una morsa, e lo sforzo stesso che facea per liberarsi gonfiava le sue carni. Intanto la mamma, che era in mezzo al campo a lavorare, lo chiamò. Egli imbarazzato fece inutilmente nuovi sforzi, ma poi dovette confessare di non potere, per aver un braccio tenuto dentro un albero. La madre andò a vedere. – Buzaron! Ne fai sempre una nuova. E adesso? – E secondo il solito sorrideva, come pure sorrideva il figlio. Presa pertanto una scaletta e giunta a lui vicino, fece ogni prova; tentò di girare il braccio e di vedere se la camiciuola potea essere stirata; ma invano. Allora chiese l’aiuto di due uomini, che vennero coll’accetta. Margherita però non permise che si valessero di questo ferro, ma porse loro uno scalpello, col quale, dopo aver ella prima fasciato il braccio del figlio col suo grembiale, essi fecero saltare tante scheggie sì da liberare il povero Giovanni, non immune per altro da qualche scalfittura. Dopo di che la buona Margherita ebbe subito in sulle labbra la morale del fatto: – Allo stesso modo, disse, restano presi dalla giustizia di Dio e degli uomini coloro che vogliono prendere e portar via la roba degli altri!
Altra volta il giovanetto avea scoperto una bella nidiata di usignuoli tra i rami di un cespuglio di bossolo, e di quando in quando, mentre attendeva che i piccini mettessero le piume, andava a certa distanza dietro ad una siepe ad osservare la madre che loro recava da mangiare. Quel nido formava la sua delizia. Un giorno sul far della sera, essendo l’usignuolo- madre nel nido, ecco un cucco volare sopra di un albero vicino, e, vista la preda, piombare sul nido stesso, coprirlo colle sue ali, e ficcandovi dentro il becco fare strage orribile e divorarsi tutto, quindi adagiarsi vicino al nido e più non muoversi. Giovanni fu dolente di aver perduto quegli uccelli che già teneva come suoi; ma, scorta [114] l’immobilità del cucco, venne preso da curiosità di osservare ciò che facesse. All’indomani pertanto, sul far dell’alba, nuovamente colà si recò con grande precauzione; ed ecco il cucco risalire dal terreno ove era disceso e in quel nido da lui devastato porre un suo uovo. Ma pochi istanti dopo un gatto, che stava in agguato, preso lo slancio, gli fu sopra, e, con una zampata afferratolo per la testa, lo strappò di là e l’uccise.
– Ben gli sta! – avrà detto Giovanni, contento di quella giustizia. E mentre volea vedere che cosa ci fosse nel nido, fu spettatore di un nuovo e grazioso fenomeno. Un usignuolo, forse il maschio dell’ucciso, visto sgombro il nido, vi ritornò e si pose a covare l’uovo trovatovi, finchè ne venne fuori un piccolo mostro, che senza piume, con quegli occhi grifagni, con quel becco grosso era orribile a vedersi. Tuttavia l’usignuolo gli portava da mangiare, come se fosse suo proprio figlio, e Giovanni ogni giorno recavasi a godere di quella scena; e quando il cucco ebbe le piume, se lo tolse e lo chiuse in una gabbia. Per un po’ di tempo fu il suo divertimento. Se gli passava la mano sul dorso come per accarezzarlo, stava tranquillo; se invece gli metteva la mano sopra come per volerlo prendere, si metteva a gridare, a muoversi, a passeggiare, a far smorfie col grifo, sicchè era la cosa più lepida di questo mondo. Finalmente, distratto da altre occupazioni, erasi per due giorni dimenticato di dargli da mangiare. – E il tuo cucco? – gli chiese allora la madre. Giovanni andò a vederlo e lo trovò morto. Il poverino tentando uscire dalla gabbia, avea ficcato il capo tra due fili di ferro; spingendo la punta del becco a cono fra i due ferri pieghevoli, avea potuto allargarli alquanto, ma poi al finir del capo si eran ristretti, ed il povero uccello, strepitando per liberarsi, si era da se stesso strangolato. [115] Giovanni fe’ vedere la gabbia e l’uccello morto alla madre, la quale non lasciandosi sfuggire alcuna occasione per ribadire le sue lezioni in mente al figlio: – Vedi, disse; il prepotente ingiusto a sua volta è vinto da un altro più potente di lui e non può lungamente godere delle cose male acquistate. Il figlio del cucco ebbe una grama eredità coll’esser posto nel nido altrui; di qui vennero le sue sventure. Finiscono sempre miseramente quei figli, i cui padri lasciano un patrimonio accumulato col furto. Tu puoi benedire il Signore, poichè tuo padre non avea in casa neppure un centesimo che non fosse suo. Sii sempre un galantuomo, come lo fu tuo padre.
Un’altra volta Giovanni avea trovato un nido con una piccola gazza. La portò a casa, e voleva che sua madre la mettesse a cuocere. – Neppur per sogno, rispose la madre: chiudila in una gabbia e divertiti fin che ti piace. – Così fece Giovanni. L’augello crebbe; e formava davvero il suo divertimento con le mille smorfie e vezzi. Un giorno, entrato in casa con un canestro di ciliegie, gliene diede una. La gazza in un attimo la trangugiò coll’osso, e strepitando e col becco aperto ne voleva un’altra. Giovanni gli diè la seconda, la terza, e avanti. L’augello era gonfio; eppure appena trangugiato un frutto, era da capo colle sue strida. – Prendi! – diceva Giovanni ridendo. A un certo punto la gazza resta col becco aperto, dà un’occhiata compassionevole al suo piccolo padrone e stramazza morta! – La gazza è morta!- disse Giovanni alla madre, narrando il fatto. – Vedi, i golosi finiscono tutti così! sentenziò Margherita. Le intemperanze accorciano loro la vita!
Per la bramosia di nidiate accaddero a Giovanni tante avventure, che a descriverle tutte ci vorrebbe un grosso volume. Arrampicandosi egli sugli alberi colla sveltezza di un gatto, [116] corse più volte non leggieri pericoli, anzi in questo tempo poco mancò che una grave disgrazia non gli togliesse la vita. Un giorno, secondo il solito, andò con alcuni compagni per uccelli. Sopra una vecchia, alta e grossa quercia, in mezzo a un piccolo boschetto poco lontano dalla casa, stava una nidiata, che egli aveva già vista, ma non aveva presa per non essere ancora maturi i pulcini. Finalmente si era risoluto d’impadronirsene. Or l’uno ora l’altro dei compagni si provarono a salire, ma nessuno vi potè riuscire. Giovanni in un batter d’occhio fu in alto. Ma altro era salire sul tronco, e di qui guardar la nidiata, altro andarla a prendere su pei rami. Il nido si trovava appunto sopra l’estremità di un grosso e lungo ramo quasi parallelo al suolo e che ad un quarto della sua lunghezza si piegava in giù. Giovanni, avvezzo a passeggiare sulle corde, non si lasciò sgomentare, ma adagio adagio, piede innanzi piede, giunse ove era la nidiata, e chinatosi se la pose in seno. Ciò fatto, si trattava di rivolgersi indietro per ritornare al centro dell’albero nello stesso modo col quale era venuto; ma per quanto si sforzasse, non ci riusciva per la gibbosità del ramo. Si provò a far un passo indietro, ma gli scivolarono i piedi e si vide sospeso solo per le mani. Facendosi forza s’aggrappò pure coi piedi al disotto del ramo, e di qui cercava di rivolgersi colla faccia verso terra, stendendosi boccone sul ramo stesso; ma lo slancio che prendeva, invece di lasciarlo fermo sopra il ramo, lo facea girare dall’altra parte, sicchè ritornava sempre nella posizione primiera. In questo stato andava pensando come avrebbe potuto fare a cavarsi d’imbroglio, ma non ne trovava il modo, e, quel che è peggio, si sentiva mancare il vigore nelle braccia. I compagni al disotto temevano per lui, e gridavangli di farsi coraggio e gli consigliavano chi un modo e chi un altro di poter discendere. Giovanni [117] di quando in quando gettava un’occhiata abbasso, ma l’altezza compariva sempre spaventosa. Dopo aver lottato per un quarto d’ora circa, fatta un’ultima prova per mettersi sul ramo e non essendovi riuscito, sfinito di forze, si lasciò cadere. La sua posizione era tale da battere a capo fitto; ma per l’aria si mise le mani nei capelli e diede un forte impulso al capo, sicchè rivoltosi, cadde ritto, battè della punta dei piedi e poi della persona in modo da rimbalzare fortemente. I suoi compagni spaventati gli corsero subito attorno, credendolo morto o almeno sconquassato; ma trovandolo già seduto, gli chiesero affannosamente se si era fatto male.
– Spero di no, rispose Giovanni.
– E gli uccelli sono morti? Dobbiamo dividerli fra noi?
– Sono qui e vivi; e aprendo il giubbetto, sono qui…ma mi costano! mi costano troppo cari! – E si avviò verso casa; ma fatti alcuni passi, più non potè camminare. Lo stomaco e le viscere gli dolevano; le membra tutte gli tremavano. Presi perciò gli uccelli, li diede ai compagni e si congedò da loro, acciocchè la mamma non fosse istrutta dell’accaduto. Senonchè ad ogni momento gli veniva caldo, si sentiva svenire e a stento si trascinava. Incontrato pel primo il fratello Giuseppe, gli disse: – Parmi di non star bene! Ho male allo stomaco. – Finalmente giunse a casa, e si pose a letto. La madre corse subito, fece bruciare della camomilla, lo riscaldò e nello stesso tempo mandò pel medico. Alla prima visita che il dottore gli fece, Giovanni non volle palesargli la causa del male. Era presente la mamma. Alla seconda visita poi essendo solo con lui, gli narrò tutto il fatto per filo e per segno. – Ma perchè non dirmelo subito ieri! – esclamò il medico. – Ah mio caro dottore, rispose Giovanni, non mi conveniva: aveva paura che mia madre mi acconciasse per le feste! – L’affetto alla madre era unito ad un giusto timore [118] riverenziale. Il dottore allora gli applicò opportuni rimedii, perchè il male era nelle interiora. Contuttociò non fu del tutto guarito, se non dopo circa tre mesi; dopo cui ricominciò le sue valentie, come non avesse mai provato che cosa fosse paura; tuttavia da quel giorno ogni volta che passava vicino alla quercia sentiva ribrezzo e tremava.
Qualche tempo dopo, avendo Giovanni incominciato a frequentare la scuola di Morialdo, accadde un fatto, che, fra i molti che manifestano in lui una sensibilità non ordinaria di cuore, appalesa pure il proposito prematuro di consacrare a Dio tutti i suoi affetti, senza alcuna eccezione. Era in età di dieci anni o in quel torno, e, preso un bel merlo, lo chiuse in gabbia, lo allevò e lo addestrò al canto, zufolandogli egli all’orecchio per lunghe ore alcune note finchè non le avesse apprese. Quell’augello era la sua delizia; anzi talmente gli preoccupava il cuore, che egli quasi più non pensava ad altro che al suo merlo, nella ricreazione, nelle ore di studio, e fino nella scuola. Ma non vi è cosa quaggiù che possa durare lungamente. Un giorno, arrivato dalla scuola, corse subito a cercare il suo merlo per divertirsi. Ma, ahi dolore! trovò la gabbia spruzzata di sangue ed il povero augello giacente dentro sbranato e a metà divorato. Un gatto lo aveva afferrato per la coda, e tentando trarlo fuori della gabbia, avealo così malconcio ed ucciso. Il giovanetto si sentì tanto commosso a quello spettacolo, che si mise a singhiozzare, e il suo pianto durò più giorni, senza che nessuno valesse a consolarlo. Finalmente fermatosi a riflettere sul motivo del suo pianto, sulla frivolezza dell’oggetto, cui avea posto affezione, sulla nullità delle cose mondane, pigliò una risoluzione superiore all’età sua: propose di non attaccare mai più il cuore a cosa terrena. Tanto promise e tanto adempiè, finchè si incontrò in Chieri col giovane Luigi Comollo. A quel candore sì verginale, [119] a quella purezza e semplicità di costumi, Giovanni non seppe resistere ed entrò con lui in tenera ed intima amicizia. Quantunque quell’amore fosse tutt’altro che terreno e sensibile, ma anzi tutto santo ed unicamente diretto a vicendevole perfezionamento, tuttavia anche di questo ebbe a pentirsene. Il vivo dolore che provò alla morte dell’amico fu così grande, che fece nuovo proposito, per cui niuno da Dio in fuori avrebbe posseduto il suo cuore. E per mantenere questo generoso proponimento, da sua stessa confessione sappiamo che non ebbe a farsi poca violenza, anche più tardi, in mezzo ai buoni giovanetti che accoglieva nell’Oratorio. Di tutto questo egli, quasi rimproverandosi, scrisse in una memoria, della quale avremo presto a parlare, per istruire i Salesiani suoi figliuoli, acciocchè illudendosi non istringessero amicizie, le quali, incominciate con motivi spirituali, possono essere talora laccio fatale per le anime incaute.
Dalle parole di D. Bosco però scaturisce un lampo di luce bellissima, che illumina tutta la sua giovinezza e svela un mondo di virtù nascoste agli occhi degli uomini. Un cuore capace, negli anni suoi più bollenti, di distaccarsi dagli affetti terreni per darsi totalmente a Dio e che persevera nella sua risoluzione, non è credibile che sia stato contaminato dalla colpa.
Di lui si può affermare ciò che di sè dice l’Ecclesiastico: “Stesi in alto le mie mani. Verso la sapienza (divina) drizzai l’anima mia, e conosciuto (me stesso e la mia debolezza) la trovai. Con lei mi resi padrone del mio cuore fin dalla mia prima giovinezza: per questo non sarò abbandonato (dal Signore)[38]”.
CAPO XV.
Fonti di questa storia – Un prezioso manoscritto – Il primo sogno – La missione di Giovanni.
ENTRIAMO ora in un periodo solenne della vita del nostro Giovanni. Siamo al punto, nel quale il Signore si degna svelargli la sua vocazione. Prima però di proseguire il racconto, egli è d’uopo notare alcune cose necessarie a dimostrare come sia poggiato sulla verità quanto abbiamo scritto e quanto veniamo scrivendo. Per conoscere il meglio si potesse la vita di Giovanni Bosco prima che incominciasse gli studii, D. Secondo Marchisio, Salesiano, nativo di Castelnuovo d’Asti, nel 1888 si recò e stette in patria tre mesi: con agio visitò tutti i villaggi e le borgate, nelle quali il giovanetto Bosco aveva dimorato, interrogò i vecchi, che avevano con lui convissuto, e ne scrisse le risposte, dalle quali risulta un magnifico panegirico delle virtù del nostro amato Fondatore. D. Gioachino Berto, Don Giovambattista Francesia e D. Giovanni Bonetti nel 1889 andarono a Chieri, s’intrattennero con quanti trattarono con lui studente, e anche da questi si ebbero e si scrissero onorevolissime relazioni. Della dimora di Giovanni Bosco in Seminario molti suoi venerandi compagni ci dissero e ci esposero per iscritto cose proprie di un santo. E noi possediamo tutti questi documenti. Per ciò che riguarda mamma Margherita[121], lo scrivente seppe quanto qui descrive dalla bocca stessa di D. Bosco, avendo goduta la fortuna di avere con lui per sei e più anni giornalmente tutte le sere famigliari colloqui; e benchè rarissimamente si ritornasse sulle cose già, raccontate, pure interrogandolo talora di ciò che mi aveva detto anni precedenti e che fedelmente aveva messo in carta, stupiva nell’udirmi ripetere le stesse cose e le medesime parole di sua madre e con tale esattezza da sembrare le leggesse in un libro. Lo stesso posso assicurare di tanti altri fatti, che ebbe la bontà di confidarmi e dei quali io feci tesoro per i miei cari confratelli.
Altra fonte, da cui si ricavano queste notizie, è un prezioso manoscritto in pochi quaderni dello stesso D. Bosco, nel quale egli espone la sua biografia fino all’anno 1855. Aveva estrema ripugnanza a scrivere di sè, perchè ben conosceva l’avviso dello Spirito Santo: “La bocca altrui e non la tua dia lode a te[39]”. Ma nel 1858 il Sommo Pontefice Pio IX lo consigliava a stendere queste pagine, e nel 1869 gliene dava l’ordine, sicchè egli verso il 1870 dovette accingersi ad obbedire. Questi scritti, finchè visse, li tenne gelosamente nascosti, e solo alla sua morte si trovarono, facendo l’inventario delle sue carte. Sono un monumento mirabile di umiltà. Descrive con semplicità ciò che egli crede provare l’intervento divino nella sua missione e nelle sue opere; si estende a narrare le sue geste concisamente, prima in mezzo ai fanciulli di Castelnuovo e di Chieri, poi in Torino e nell’Oratorio; nulla dice che possa palesare i suoi atti di virtù, e come Mosè e S. Paolo dà giudizii severissimi di varie sue azioni, in modo da sorprendere il lettore che non lo avesse conosciuto [122] e al quale non fossero pervenute le testimonianze dei contemporanei.
Nelle prime pagine si legge un sogno, che noi riporteremo fedelmente, come nel progresso della storia ci serviremo eziandio letteralmente in molti luoghi della sua narrazione. Il manoscritto porta in testa il seguente titolo: Memorie dell’Oratorio dal 1835 al 1855. Esclusivamente pei Socii Salesiani. Per la Congregazione Salesiana. Egli stesso nella prefazione manifesta il motivo che lo indusse a scrivere queste memorie.
“Più volte fui esortato di mandare agli scritti le memorie concernenti l’Oratorio di S. Francesco di Sales, e sebbene non potessi rifiutarmi all’autorità di chi mi consigliava, tuttavia non ho mai potuto risolvermi ad occuparmene, specialmente perchè doveva troppo sovente parlare di me stesso. Ora si aggiunse il comando di persona di somma autorità, cui non è permesso porre indugio di sorta; perciò mi fo qui ad esporre le cose minute, confidenziali, che possono servir di lume o tornare di utilità a quella istituzione, che la divina Provvidenza si degnò affidare alla Società di S. Francesco di Sales. Debbo anzitutto premettere che io scrivo pei miei carissimi figli Salesiani, con proibizione di dare pubblicità a queste cose sia prima, sia dopo la mia morte. A che dunque potrà servire questo lavoro? Servirà di norma a superare le difficoltà future, prendendo lezioni dal passato; servirà a far conoscere come Dio abbia egli stesso guidato ogni cosa in ogni tempo; servirà ai miei figli di ameno trattenimento, quando potranno leggere le cose cui prese parte il loro padre, e le leggeranno assai più volentieri, quando, chiamato da Dio a rendere conto delle mie azioni, non sarò più tra loro.
Avvenendo di incontrare fatti esposti forse con troppa compiacenza e forse con apparenza di vanagloria, datemene [123] compatimento. È un padre che gode parlare delle cose sue ai suoi amati figli, i quali godon pure nel sapere le piccole avventure di chi li ha cotanto amati, e che nelle cose piccole e grandi ha sempre cercato di operare a loro vantaggio spirituale e temporale.
Io espongo queste memorie ripartite in decadi, ossia in periodi di dieci anni, perchè in ogni tale spazio di tempo succedette un notabile e sensibile sviluppo della nostra istituzione.
Quando poi, o figli miei, leggerete queste memorie dopo la mia morte, ricordatevi che avete avuto un padre affezionato, il quale, prima di abbandonare il mondo, ha lasciato queste memorie come pegno della paterna affezione, e ricordandovene pregate Dio per il riposo eterno dell’anima mia”.
Si noti come D. Bosco fa scomparire la propria personalità, dicendo che Dio non a lui, ma alla Pia Società di S. Francesco di Sales affidava una grande missione.
È costume di Dio, nella sua grande misericordia, palesare con qualche segno la vocazione di quegli uomini, che Egli destina a cose grandi per la salute delle anime. Così fece con Giovanni Bosco, che poi continuò a guidare colla sua mano onnipotente in ogni stadio della sua vita ed in ogni sua impresa. Sta scritto in Joele che, succeduta alla lunga sterilità della Sinagoga la prodigiosa fecondità della nuova Chiesa, Iddio spanderà il suo spirito sopra tutti gli uomini, e i vostri vecchi avranno dei sogni, e i vostri giovani avranno delle visioni[40]. E le ebbe Giovanni Bosco, ed ecco in qual modo egli stesso nelle sue memorie ci narra il suo primo sogno.
“All’età di nove anni circa ho fatto un sogno che mi rimase profondamente impresso per tutta la vita. Nel sonno [124] mi parve di essere vicino a casa, in un cortile assai spazioso, dove stava raccolta una moltitudine di fanciulli che si trastullavano. Alcuni ridevano, altri giuocavano, non pochi bestemmiavano. All’udire quelle bestemmie mi sono subito slanciato in mezzo di loro, adoperando pugni e parole per farli tacere. In quel momento apparve un Uomo venerando, in età virile, nobilmente vestito. Un manto bianco gli copriva tutta la persona; ma la sua faccia era così luminosa, che io non poteva rimirarla. Egli mi chiamò per nome, e mi ordinò di pormi alla testa di quei fanciulli, aggiungendo queste parole: – Non colle percosse, ma colta mansuetudine e colla carità dovrai guadagnare questi tuoi amici. Mettiti dunque immediatamente a far loro un’istruzione sulla bruttezza del peccato e sulla preziosità della virtù. – Confuso e spaventato soggiunsi che io era un povero ed ignorante fanciullo, incapace di parlare di religione a quei giovanetti. In quel momento quei ragazzi cessando dalle risse, dagli schiamazzi e dalle bestemmie, si raccolsero tutti intorno a colui che parlava. Quasi senza sapere che mi dicessi: – Chi siete voi, soggiunsi, che mi comandate cosa impossibile?
– Appunto perchè tali cose ti sembrano impossibili, devi renderle possibili coll’obbedienza e coll’acquisto della scienza.
– Dove, con quali mezzi potrò acquistare la scienza?
– Io ti darò la Maestra, sotto alla cui disciplina puoi diventare sapiente, e senza cui ogni sapienza diviene stoltezza.
– Ma chi siete voi che parlate in questo modo?
– Io sono il Figlio di Colei che tua madre ti ammaestrò di salutare tre volte al giorno.
– Mia madre mi dice di non associarmi con quelli che non conosco, senza suo permesso; perciò ditemi il vostro nome.
– Il mio nome domandalo a mia madre. [125]
In quel momento vidi accanto a lui una Donna di maestoso aspetto, vestita di un manto che risplendeva da tutte parti, come se ogni punto di quello fosse una fulgidissima stella. Scorgendomi ognor più confuso nelle mie domande e risposte, mi accennò di avvicinarmi a Lei, che presomi con bontà per mano: – Guarda! – mi disse. Guardando mi accorsi che quei fanciulli erano tutti fuggiti, ed in loro vece vidi una moltitudine di capretti, di cani, di gatti, di orsi e di parecchi altri animali. – Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare, continuò a dire quella Signora. Renditi umile, forte, robusto: e ciò che in questo momento vedi succedere di questi animali, tu dovrai farlo pei figli miei.
Volsi allora lo sguardo, ed ecco, invece di animali feroci, apparvero altrettanti mansueti agnelli, che tutti saltellando correvano attorno belando, come per far festa a quell’Uomo e a quella Signora.
A quel punto, sempre nel sonno, mi misi a piangere, e pregai quella Donna a voler parlare in modo da capire, perciocchè io non sapeva quale cosa si volesse significare. Allora Ella mi pose la mano sul capo dicendomi: – A suo tempo tutto comprenderai. – Ciò detto, un rumore mi svegliò, ed ogni cosa disparve. Io rimasi sbalordito. Sembravami di avere le mani che facessero male pei pugni che aveva dato, che la faccia mi dolesse per gli schiaffi ricevuti da que’ monelli; di poi quel Personaggio, quella Donna, le cose dette e quelle udite mi occuparono talmente la mente, che per quella notte non mi fu più possibile prendere sonno.
Al mattino ho tosto con premura raccontato quel sogno prima ai miei fratelli, che si misero a ridere, poi a mia madre ed alla nonna. Ognuno dava al medesimo la sua interpretazione. Il fratello Giuseppe diceva: – Tu diventerai [126] guardiano di capre, di pecore o di altri animali. – Mia madre: – Chi sa che non abbi a diventar prete. – Antonio con secco accento: – Forse sarai capo di briganti. – Ma la nonna, che sapeva assai di teologia ed era del tutto analfabeta, diede sentenza definitiva dicendo: – Non bisogna badare ai sogni. – Io era del parere di mia nonna, tuttavia non mi fu mai possibile di togliermi quel sogno dalla mente. Le cose che esporrò in appresso daranno a ciò qualche significato. Io ho sempre taciuto ogni cosa; i miei parenti non ne fecero caso. Ma quando, nel 1858, andai a Roma per trattare col Papa della Congregazione Salesiana, egli sì fece minutamente raccontare tutte le cose che avessero anche solo apparenza di soprannaturale. Raccontai allora la prima volta il sogno fatto in età di nove in dieci anni. Il Papa mi comandò di scriverlo nel suo senso letterale, minuto, e lasciarlo per incoraggiamento ai figli della Congregazione, che formava lo scopo di quella gita a Roma”.
Dopo questo sogno si aumentò in Giovanni il desiderio di studiare per giovare ai giovinetti e divenir sacerdote. Ma gravi difficoltà si opponevano per le strettezze della famiglia ed anche per l’opposizione che faceva il fratellastro Antonio, il quale avrebbe voluto che egli pure, come lui, attendesse ai lavori della campagna. Vedeva di mal occhio che il fratello più giovane si applicasse agli studi.
Di questo sogno, che gli si affacciava e gli si svolgeva innanzi alla mente più e più volte nello spazio di circa diciotto anni, D. Bosco non volle narrare che una minima parte. Affermava però, negli ultimi anni della sua vita, che quantunque il quadro generale di questa apparizione fosse sempre lo stesso, pure era accompagnato ogni volta da una svariata quantità di scene accessorie sempre nuove. [127]
Aggiungeva che da quel punto egli conobbe, e poi vide ancor più chiaramente non solo la fondazione dell’Oratorio e l’estensione della sua missione, ma eziandio tutti gli ostacoli che sarebbero sorti per impedirgliene i progressi, tutte le guerre che gli avrebbero mosse i suoi avversari e il modo di vincerle e superarle. E questa essere stata pure la cagione della sua tranquillità costante e della sicurezza di riuscire in quanto intraprendeva.
Non fu questo sogno adunque semplicemente una grazia, ma eziandio una vera missione, un’obbligazione stretta che Dio gli imponeva di obbedire. Ed io lo raffronterei colla visione del giovanetto profeta Geremia. Esso pure aveva risposto al Signore: “Ah, ah, ah, Signore Dio: tu vedi che io non so parlare, perchè sono fanciullo”. Ed il Signore gli replicò: “Non dire: io sono un fanciullo: perocchè tu anderai a fare tutte quelle cose, per le quali ti spedirò, e tutto quello che io ti ingiungerò, tu lo dirai. Non temere la faccia di coloro che sono potenti, conciossiachè sono io con te per trarti d’impaccio, dice il Signore…. Faranno a te guerra, ma non la vinceranno, perocchè sono io con te per tua sicurezza….[41]”.
E quale doveva essere la missione di Giovanni Bosco? La fondazione di nuovi sodalizi religiosi, la Pia Società di S. Francesco di Sales e l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice: la salvezza dei giovanetti in tutto il mondo cogli Oratorii Festivi, cogli Ospizi e Laboratori, coi Collegi, colle Colonie agricole: le vocazioni allo stato ecclesiastico, preparando al santuario il fiore della gioventù raccolto da molti paesi e provvedendo di clero le Diocesi che ne difettavano coll’Opera [128] dei figli di Maria Ausiliatrice per le vocazioni degli adulti: l’istituzione di scuole cattoliche senza numero da opporre come contravveleno ad un nugolo di empi maestri, che non avrebbero tardato ad erigere cattedre di errore e di corruzione: la propagazione della buona stampa con numerose tipografie, che diffondessero a milioni a milioni di libri di pietà, di storia, di lettura popolare, difensori delle verità cattoliche e volumi scolastici purgati dalle sconcezze per togliere i lacci tesi all’innocenza, scuotendo pure con tal mezzo potentissimo i cattolici dall’inerzia, in cui si giacevano, col Bollettino Salesiano, pubblicato in 200.000 fascicoli al mese e in varie lingue, facendo noto quanto il Signore e la Vergine Santissima andavano operando: l’Associazione dei Cooperatori Salesiani ormai numerosa di 200 000 membri, i quali, mentre lo dovevano coadiuvare con elemosine, preghiere ed appoggio morale in tutte le sue imprese, fossero vincolo di unione tra il Vescovo e i diocesani, tra il parroco e i parrocchiani in ogni opera di carità spirituale o temporale: stabilimento di Missioni evangeliche nelle diverse parti del mondo, America, Asia, Africa: difesa del Papato in varie e gloriose circostanze: sicchè di Giovanni si potesse dire: Constitui te super gentes et super regna… Dedi te in murum aeneum… regibus… principibus… sacerdotibus et populo terrae. Ecco in tutta l’estensione il significato di questo sogno.
CAPO XVI.
Effetti del primo sogno – Sviluppo dell’ingegno e della memoria di Giovanni – Sua robustezza e forza prodigiosa – Alcuni aneddoti.
UNA voce dolcissima aveva detto a Giovanni nel sogno: – Renditi umile, forte e robusto! – Era questa una benedizione, che comprendeva tutto l’uomo. Infatti “val più un povero sano e robusto di forze, che un ricco spossato e fiaccato dalle malattie. La salute dell’anima, consistente nella santità della giustizia, val più di tutto l’oro e l’argento; e un corpo ben disposto più vale che le immense ricchezze. Non v’ha tesoro che superi il tesoro della sanità del corpo; nè piacere maggiore del gaudio del cuore[42]”.
Giovanni adunque poteva e doveva acquistare l’umiltà, che dà la pace e la perseveranza nella virtù, coll’aiuto della grazia divina; ma non era certamente in suo potere conseguire la fortezza e robustezza della mente, ornata di ingegno e di felice memoria, ed il vigore della sanità e la forza delle membra. Eppure egli eziandio di ciò aveva bisogno, per essere capace di acquistare quelle svariatissime cognizioni che gli erano [130] necessarie e per poter resistere, senza logorarsi troppo presto, alle fatiche che per lui la divina Provvidenza aveva preparate. Perciò a noi sembra che quella voce non desse solamente un consiglio, ma donasse un favore segnalato. E riserbandoci a trattare in altri capitoli dell’ingegno e della memoria del nostro Giovanni, notiamo qui solamente come egli, andando con grande piacere alle prediche e panegirici a S. Pietro o in altre cappelle delle sue borgate, in parrocchia, a Buttigliera, a Capriglio, ritornato a casa ripeteva letteralmente a sua madre ed ai fratelli quanto aveva detto il sacro oratore; ed i vicini eziandio intorno a lui si raccoglievano, ammirandone la grande memoria ed intelligenza.
Per quanto riguarda il corpo, che quella fosse una grazia, s’intendeva al solo rimirare Giovanni. Le sue membra erano piuttosto esili: la statura comune; le spalle strette; piccole, delicate e morbidissime le mani. Eppure la sua forza muscolare non tardò ad apparire veramente prodigiosa, e si andava sviluppando vuoi per l’esercizio della ginnastica, vuoi per quello delle varie domestiche fatiche.
Sotto i suoi denti stritolati rimanevano i noccioli di pesche e di albicocchi per quanto duri. Semplicemente con due dita, sia della mano destra che della sinistra, premendo il pollice contro l’indice, rompeva noci, nocciuole e mandorle. Eziandio quelle verghe di ferro, che comunemente servono di ringhiera ai nostri balconi, senza gran sforzo nelle sue mani andavano in tanti piccoli pezzi. Quando poneva in fila i giovanetti per insegnar loro la ginnastica, se alcuno fosse uscito di posto, ei, sorridendo, con una mano sola lo prendeva per un braccio e lo gettava di sbalzo fino al fondo della squadra.
Non paia strano, se anticipiamo la narrazione di alcuni fatti posteriori; poichè, seguendo l’ordine cronologico, ci [131] sarebbero d’impaccio e interromperebbero il filo della storia ne’ suoi momenti più solenni. Di questa forza egli faceva uso a Chieri per togliersi d’attorno coloro, che lo volevano costringere ad un giuoco che non garbavagli. Frequentando il corso di retorica, un giorno mentre in iscuola andava al suo posto, eccoti quattro compagni un dopo l’altro saltargli sulle spalle. Giovanni li lasciò fare; ma quando li ebbe tutti e quattro accavalcati sul dosso, prese le braccia di colui che era al disopra di tutti, le serrò ben bene in modo da legare quei di sotto; poi s’alzò e li portò tutti nel cortile urlanti misericordia e pietà, alla presenza dei professori, che ne ridevano di piacere: quindi con tutta facilità li riportò nella scuola. Dopo d’allora più non osarono tentarlo. A quell’età egli non aveva difficoltà di portare venti rubbi.
Essendo già sacerdote e nei primi anni del suo domicilio in Torino, passando sotto i portici della fiera, s’imbattè in una folla di persone radunata innanzi alla porta di un fondaco. Di questa piazza egli conosceva i mercanti, i facchini, le turbe dei giovani monelli che vi si raccoglievano, sicchè poteva dirsi come in casa sua e nella famigliarità degli amici. E poi, fatta ragione dei tempi, non c’è da meravigliare di quanto stiamo per dire. D. Bosco adunque volle sapere che cosa si facesse, e vide due grossi mastini, che urlando rissavano e si mordevano furiosamente. La gente temeva di andare innanzi. D. Bosco s’inoltrò. In quel mentre uno dei cani rinculò verso la porta varcando la soglia, per prendere lo slancio sul competitore. D. Bosco disse allora ad un garzone: – Chiudete presto la porta, che quel cane non esca: dell’altro sono garante io.
– Le morderà, rispose il garzone.
– No, no; ripigliò D. Bosco; fate come vi dico. – E il garzone chiuse uno dei cani nel cortile, mentre D. Bosco, [132] preso l’altro pel groppone e pel collo, lo sollevò da terra, e così lo tenne per buona pezza onde sbalordirlo, mentre l’animale si dimenava e abbaiava rabbiosamente. Gli spettatori, meravigliati del suo ardire, temevano che il cane, lasciato in libertà, si avventasse furioso sulla moltitudine; ma D. Bosco lo abbassò a terra, lo condusse tenendolo pel collo fino a metà della piazza Milano verso il ponte, quindi, datagli una potentissima spalmata sulle lacche, lo lasciò libero. Quel povero cane mandò un forte guaito, e schivando per timore la gente, andò pei fatti suoi zoppicando e traendo a stento il fiato. Quel colpo gli aveva tolta ogni forza. Dietro a D. Bosco stava il canonico Zappata, il quale si avvicinò a lui e gli disse: – Non vi pare questo un atto indecoroso per un sacerdote?
– Caro lei, rispose umilmente D. Bosco, la necessità richiedeva che qualcuno ponesse fine a quell’alterco; nessuno si muoveva e feci io.
Era l’anno 1846, ovvero 1847, e D. Bosco andava a Biella per dettare i santi spirituali esercizi. In questi viaggi egli aveva fatto disegno di attrarre a sè i carrozzieri e i mozzi di stalla, per dar loro qualche sommaria nozione di catechismo e ricondurli a Dio col Sacramento della Penitenza. Ma, per entrare in famigliarità con essi, credette bene farsi conoscere valente in quella forza materiale, che, per la gente rozza ed ineducata, forma il primario pregio di una persona: la meraviglia gli avrebbe accaparrata la loro stima. Vedremo in seguito con qual frutto esercitò in mezzo a costoro la sua missione salvatrice. Mentre adunque a Santhià stava aspettando che si allestisse la diligenza, appoggiato al muro dell’albergo, presso i cavalli che venivano cambiati, il cocchiere lo avvertì più volte che si ritirasse, poichè fra i cavalli ve ne era uno che mordeva chiunque senza [133] precauzione gli fosse andato vicino. D. Bosco avea risposto: – Non temete; non mi morderà. – Quand’ecco il cavallo sopraddetto avanzarsi ed avvicinarsi a D. Bosco in modo da chiuderlo fra il muro. Il cavallo tentò di morderlo, ma non ebbe tempo ad allargar le mascelle; chè D. Bosco con una mano sola gli strinse le fauci con tale violenza, che il cavallo per quanto scuotesse la testa, non potè svincolarsene. S’inalberò, inferocì, sprangò calci, ma D. Bosco lo tenne stretto colla sua mano come fra una morsa. Tutta la gente accorsa era spaventata e maravigliata di tanta forza. D. Bosco intanto diceva tranquillamente al cocchiere e ad un altro garzone di stalla che, presa una corda, ne formassero un laccio e legassero le gambe posteriori del cavallo. Così fecero, e quando il cavallo fu ben legato, egli si ritirò pian piano e lasciò libere quelle fauci, quando si vide alla portata di non poter più essere morso. Mentre saliva in vettura tutti i presenti si domandavano: – Ma chi è questo prete che ha tanta forza?
Qualche anno dopo trovavasi in casa del Prof. D. Matteo Picco, mentre giunsero alcuni facchini, che portavano un pianoforte bene imballato in una cassa cerchiata da strette lastre di ferro. D. Picco, desiderando veder subito la sua compra, trovavasi imbrogliato, perchè invano cercava martello, tenaglie o altro strumento per aprire la cassa. D. Bosco allora, esaminate le fascie di ferro, incominciò a prenderne una colle dita ove le due estremità si congiungevano. Queste cedettero e si staccarono; così fece successivamente di tutti quei cerchi; ed allo stesso modo disgiunse pure le assi della cassa che erano congiunte con lunghi chiodi. A quello scricchiolio, a quello sfasciamento, a quella rapidità di operazione D. Picco sbalordito mirava D. Bosco senza dir parola.
Quando nel 1883 andò a Parigi, invitato a pranzo da un’illustre famiglia, furono portate in tavola delle noci dal [134] guscio durissimo. I convitati aspettavano che loro fosse recata la macchinetta per romperle. D. Bosco, avuto innanzi il piatto, continuando tuttavia a discorrere coi vicini, prese alcune di quelle noci e con due sole dita rompendole, incominciò a distribuirne ai commensali, che gioivano di essere serviti da un uomo, pel quale aveano tanta venerazione. Sul principio si credettero che avesse fra le mani lo schiacciatoio, ma accortisi che operava colle sole dita, sbalorditi uscivano in esclamazioni di meraviglia e dicevano: – È certo colla benedizione di Maria Ausiliatrice che può frangere involucri così duri!
Nell’anno 1884, contando egli omai 69 anni, mentre era infermo e teneva il letto, logoro per le tante fatiche sopportate, il dottore curante volle fare esperienza della sua forza. Pertanto, recato con sè un manometro, prima di presentarglielo gli disse: – D. Bosco, mi stringa qui il polso con tutta quella forza maggiore che può.
– Signor dottore, rispose D. Bosco; ella non conosce la mia forza.
– No, insistette il medico, non abbia timore di farmi male. Stringa pure. – D. Bosco accondiscese, e strinse la mano che gli porgeva il medico, il quale resse per un istante, guardando colte lagrime agli occhi il suo infermo, in cui sentiva esistere una vigoria non sospettata; ma finalmente mandò un grido: la stretta di D. Bosco gli aveva fatto quasi spicciare sangue dalle punte delle dita. Allora trasse fuori il manometro, circolo metallico graduato per misurare le forze dell’uomo, e lo porse a D. Bosco.
– Senta, dottore, disse D. Bosco; se io stringo quell’istrumento fra le mani, glielo riduco in frantumi.
– Per quanto sia forte, non riuscirà certamente a spezzare a questo modo un anello d’acciaio. [135]
– Or bene, faccia lei prima di me la prova delle sue forze. – Il medico strinse colla destra quell’istrumento con quanta maggior violenza poteva, e furono marcati 45 gradi. – Ora, disse D. Bosco, lo porga a quel prete che mi assiste. – D. G. B. prese in mano l’istrumento, lo strinse e segnò 43 gradi. – A lei! – concluse il medico. D. Bosco lo strinse e il manometro segnava 60 gradi, il massimo indicatore. D. Bosco sentiva che la sua forza superava i gradi che poteva marcare quel manometro. Il dottore assicurava di non ricordarsi d’aver mai assistito infermi che dopo lunghe malattie fossero così pieni di vigore.
Di tanta vigoria D. Bosco usò pochissime volte, talora per necessità o per fine buono, talora per compiacere gli amici in ricreazione, ma giammai per difendersi. Il mirabile si è che ciò egli faceva senza sforzi, colla solita calma, composto sempre nella persona, senza vanterie, come se fosse la cosa più naturale di questo mondo. E noi lo vedremo consumare a poco a poco la robustezza del suo corpo in olocausto continuo alla gloria di Dio e per il bene del suo prossimo.
CAPO XVII.
Trattenimenti di Giovanni coi fanciulli – I racconti – Le serate d’inverno Il piccolo saltimbanco e il suo primo Oratorio festivo – Col canto, coi giuochi e colle prove acrobatiche impedisce l’offesa di Dio.
NELL’’andare ai mercati colla madre, Giovanni aveva fatto conoscenza con alcuni giovanetti delle diverse borgate; molti più poi strinsero con lui relazione, quando incominciò a recarsi in parrocchia pel catechismo. Tutti erano attirati a lui, come da una specie di misteriosa calamita, da ogni parte dei dintorni. Ancor piccolino, quasi senza avvedersene, egli aveva già incominciato a studiare il carattere de’ singoli suoi compagni, e fissando taluno in faccia, di leggieri ne scorgeva i progetti del cuore. Fatto più grandicello, la riflessione e i confronti lo resero sempre più perspicace. Sapeva perciò, con infantile ingenuità, prevenire un’interrogazione, dare ciò che non era stato chiesto, fare un rimbrotto a tempo opportuno di una mancanza da altri non avvertita, approvare una deliberazione presa e non ancora manifestata. Per questo i suoi coetanei molto lo amavano e assai lo temevano. Era un altro dono che avevagli fatto il Signore: “Come [137] nelle acque risplendono le faccie di quelli che vi si mirano, così i cuori degli uomini sono manifesti ai sapienti[43]”.
Dal canto suo però Giovanni era sempre pronto a fare del bene a chi poteva, del male a nessuno. I compagni ne ambivano assai l’amicizia, affinchè in caso di rissa prendesse le loro difese; perciocchè, sebbene fosse più piccolo di statura, possedeva forza e coraggio da incutere rispetto a coloro che erano di lui per età maggiori. A segno che, nelle varie questioni o diverbi di qualunque genere, nascendo brighe o risse fra i compagni, Giovanni era sempre chiamato dai litiganti come giudice arbitro, e da tutti si protestava che avrebbero accettato di buon grado la sentenza che fosse per proferire. Eziandio coloro, che già avevano quindici o sedici anni, a lui accorrevano per esporre i loro dubbi, domandargli consiglio e chiederne il parere. Fra i compagni bastava che si dicesse: – Giovanni ha detto questo, Giovanni ha così deciso! – la parola di Giovanni faceva testo.
Ma ciò che raccoglieva i fanciulli attorno al piccolo Giovanni e li allettava fino alla follia, erano i fatterelli e le istorie che loro raccontava. Gli esempi uditi nelle prediche e nei catechismi, la lettura dei Reali di Francia, del Guerrin Meschino, di Bertoldo e Bertoldino gli somministravano molta materia. Egli infatti leggeva quanti libri gli capitavano fra le mani, e questi soli e non altri poteva trovare nelle case dei contadini. Talora si appigliava a leggende ancora più strane, come a quella di colui che udiva l’erba a nascere a dieci miglia di distanza. Dai fatti però e dalle favole sapea sempre trarre la morale conveniente. Appena i suoi compagni lo vedevano, correvano affollati per farsi narrare qualche cosa [138] da lui, che a stento cominciava a capire quello che leggeva. A costoro poco per volta s’aggiungevano degli adulti; sicchè sovente avveniva che nell’andare o venire da Castelnuovo, talora in un campo, tal’altra in un prato, Giovanni si vedeva circondare da centinaia di persone accorse per ascoltare un povero fanciullo che quantunque, fuori di un po’ di memoria, fosse digiuno nella scienza, tuttavia tra di loro compariva come un gran dottore. Egli stesso a questo punto nota nelle sue memorie: – In regno caecorum monoculus rex. – Talvolta, mentre stava in mezzo alla turba dei ragazzi come dominatore e capopopolo, la gente delle altre borgate, passando per la via, si fermava quasi estatica a contemplare quel giovanetto così sicuro di sè e al quale gli altri professavano tanta sottomissione, ed interrogava: – Ma chi è costui? – e sentivasi rispondere: – È il figlio di Margherita!
Nella stagione invernale si andava a gara per averlo nelle stalle e udirlo raccontare qualche storiella. Colà raccoglievasi gente di ogni età e condizione, e tutti godevano di poter passare le serate di cinque ed anche sei ore ascoltando immobili la lettura dei Reali di Francia, che il giovanetto esponeva ritto sopra una panca, affinchè fosse da tutti udito e veduto. Siccome però dicevano che venivano ad ascoltare la predica, così prima e dopo i suoi racconti facevano tutti il segno della santa Croce colla recita dell’Ave Maria. Eravamo nell’anno 1826. Una vicina, certa Catterina Agagliati, era talmente assidua nell’ascoltare il piccolo oratore, che in qualunque luogo e in qualunque tempo le fosse giunta notizia doversi tenere questo trattenimento, lasciava qualsiasi occupazione per accorrervi. Costei un giorno, fuori di sè per la meraviglia delle cose udite, diceva a mamma Margherita: – Il Signore aiuterà vostro figlio a divenire uomo di molta importanza. Sarebbe peccato che tanta scienza andasse [139] perduta. – E Margherita rispondeva – Sarà quello che il Signore vorrà!
Nella bella stagione poi, specialmente al dopo pranzo dei giorni festivi, si radunavano quelli del vicinato e non pochi forestieri. Non solo venivano i giovani, ma eziandio gli uomini fatti e quelli dai capelli bianchi. Qui la cosa prendeva aspetto assai più serio. Giovanni dava a tutti trattenimento con alcuni di quei giuochi, che aveva imparato dai ciarlatani sulle fiere.
Ai Becchi havvi un prato, dove esistevano diverse piante, fra le quali un pero martinello. A quest’albero Giovanni attaccava una fune, che andava a rannodarsi ad altro albero a qualche distanza: di poi preparava un tavolino colla bisaccia: in fine collocava una sedia e stendeva un tappeto a terra per farvi sopra i salti. Quando ogni cosa era preparata nel bel mezzo del circolo formato dalla moltitudine ed ognuno stava ansioso di ammirare novità, allora Giovanni li invitava tutti a recitare la terza parte del rosario, quindi faceva cantare una laude sacra, finita la quale, saliva sopra la sedia, e: – Adesso, diceva, sentite la predica che ha fatto stamattina il cappellano di Morialdo.
Alcuni facevano smorfie ed atti d’impazienza, altri brontolavano sottovoce dicendo che non volevano saperne di prediche, altri si disponevano ad allontanarsi per quel momento. Giovanni sopra la sua sedia era come un re sopra il suo trono, e comandava così risolutamente da costringere all’obbedienza eziandio i vecchi di sessant’anni. – Ah! è così? gridava a quegli impazienti; partite pure di qua, ma ricordatevi che, se ritornerete quando farò i giuochi, io vi scaccierò e vi assicuro che non porterete più i piedi nel mio cortile. – A questa minaccia tutti si acquetavano e immobili stavano attenti alle sue parole. Egli allora incominciava la predica, o meglio ripeteva quanto si ricordava [140] della spiegazione del Vangelo udita al mattino in chiesa, oppure raccontava fatti od esempi uditi o letti in qualche libro. Di tanto in tanto gli uditori uscivano in queste esclamazioni: – Dice bene; sa bene! – Ed erano tutti contenti. Terminata la predica, si faceva breve preghiera e tosto si dava principio ai divertimenti. L’oratore diveniva giuocoliere di professione. Fare la rondinella, il salto mortale, camminare sulle mani col corpo alto; poi cingersi la bisaccia; mangiare gli scudi per andarli a ripigliare sulla punta del naso dell’uno o dell’altro; poi moltiplicare le pallottole, le uova; cangiare l’acqua in vino, uccidere un pollo e poi farlo risuscitare e cantare meglio di prima, erano gli ordinarii trattenimenti. Sulla corda poi camminava come per un sentiero; saltava, danzava, si appendeva ora per un piede ora per due; talora con ambe le mani, talora con una sola. Anche il fratello Antonio andava a vedere i giuochi, ma non si metteva mai tra le prime file, sibbene si nascondeva per metà dietro ad un albero o a qualche pilastro, sicchè ora compariva ed ora scompariva la sua faccia beffarda, e rideva cogli altri o scherniva il piccolo giocatore: – Grande imbecille che sei; talora dicevagli, farti burlare da tutti in questa maniera! – Ma gli spettatori non gli badavano, e ridevano a crepapelle ai giuochi, ai frizzi, alle burle di Giovanni e gli battevano le mani. Talora mentre tutti stavano intenti a bocca aperta, in aspettativa di qualche nuovo strano prestigio, di un colpo Giovanni sospendeva i giuochi, e faceva loro cantare le litanie o dire il rosario, quando non si era recitato prima. Diceva loro: – Adesso vi sono ancora molte belle cose da vedere, ma prima di terminare, voglio che recitiamo – tutti insieme una preghiera. – Coglieva questo tempo intermedio; poichè se avesse aspettato a far l’invito al fine del trattenimento, sarebbero tutti fuggiti. [141]
Dopo alcune ore di questa ricreazione, in sul far della notte, allorchè il piccolo giuocatore era ben stanco, cessava ogni trastullo, facevasi altra breve preghiera, ed ognuno se ne andava pe’ fatti suoi. Da queste radunanze erano esclusi tutti quelli che avessero bestemmiato, fatti cattivi discorsi, o si fossero rifiutati di prendere parte alle pratiche religiose.
Qualcuno dei nostri lettori farà una domanda: – Per andare alle fiere ed ai mercati ad assistere ai ciarlatani, come si è esposto in un dei capi precedenti; per provvedere quanto occorreva per questi divertimenti, erano necessari danari; e questi dove si prendevano? – A ciò in più modi poteva provvedere Giovanni. Tutti i soldi che sua madre e gli altri parenti gli davano per i suoi minuti piaceri e per le ghiottonerie, le piccole mance, i regali, tutto era messo in serbo per questo bisogno. Di più egli, peritissimo ad uccellare colla trappola, colla gabbia, col vischio, coi lacci e praticissimo delle nidiate, fatta raccolta sufficiente di uccelli, sapeva venderli assai bene. Inoltre fabbricava cappelli di paglia, che vendeva ai contadini sui mercati; come pure gabbie di canna a modo di trappola, specialmente per i passeri, coi richiami addestrati. I funghi, l’erba tintoria, il treppio erano per lui fonte di guadagno. Aveva pure imparato ed era abilissimo nel filare stoppa, cotone, lino, fiorotto, fiorone di bozzoli di seta, sì da dare lezione di quest’arte ai vicini che a lui si raccomandavano. Riusciva anche molto bene a fare le calze a maglia sui ferri; sicchè, quando fu all’Oratorio, da per sè rinnovava talora gli scappini stracciati. Eziandio la caccia alle serpi gli era fonte di qualche lucro. Quando se ne scopriva qualcuna in un campo, si andava da lui, ed egli correva e con una pietra bene assestata colpiva il rettile; ma se mai questo fuggendo, riusciva a porre il capo in un foro [142] delle macerie o sotto qualche radice, allora egli afferravalo per la coda, e girandolo rapidamente per aria, così continuava finchè, venuto presso ad un albero, contro quello lo sbatteva, facendogli in un sol colpo saltare la testa.
Un’altra osservazione, alla quale risponderemo colle parole stesse di D. Bosco. “Voi qui, dice egli nel suo manoscritto, mi chiederete: – E la mia madre era contenta che tenessi una vita cotanto dissipata, e spendessi il tempo a fare il ciarlatano? – Vi dirò che mia madre mi voleva molto bene; ed io le aveva confidenza illimitata, e senza il suo consenso non avrei mosso un piede. Ella sapeva tutto, osservava tutto e mi lasciava fare. Anzi occorrendomi qualche cosa, me la somministrava assai volentieri. Gli stessi miei compagni e in generale tutti gli spettatori mi davano con piacere quanto mi fosse stato necessario per procacciare loro quegli ambiti passatempi”.
Così mamma Margherita, col suo buon senso e molto più con quell’intuito naturale in un’anima che vive dell’amor di Dio, senza sapere bene il perchè, coadiuvava nel suo Giovanni lo sviluppo della vocazione straordinaria, alla quale era chiamato per i tempi nuovi che andavano maturandosi. La virtù infatti non trovava ostacoli nella madre, la quale, sapendo quanto importasse che i fanciulli crescessero nell’umiltà, non smiracolava mai per le geste del figlio, non vantavalo mai in sua presenza, ma pregava il Signore per lui, come pure lo pregava per gli altri suoi figliuoli. Ella osservava, taceva e pensava. Infatti un ragazzetto, un contadinello che a dieci anni s’impone ai fanciulli maggiori di lui, che parla in pubblico con franchezza, che si addestra a far ciò che piace alla folla, per costringerla a pregare e ad udire la ripetizione di una predica, non è cosa che si veda con molta frequenza. [143]
Un giorno, mentre Giovanni avea teso la corda per giuocare innanzi alla folla radunata nel cortile di sua casa, la madre sopra pensieri lo contemplava quasi senza trarre respiro. A un tratto giunge la Catterina Agagliati e salutandola: – Ebbene, Margherita? – Margherita come scossa dal sonno si volse alla sua interlocutrice e sottovoce, ma con fuoco, le chiese: – Che cosa credete che ne verrà di mio figlio? – E l’altra: – È certamente destinato a fare qualche grande diavolío nel mondo!
Giovanni in quelle assemblee domenicali godeva mezzo mondo; il disegno di vivere sempre in mezzo ai giovani, radunarli, far loro il catechismo, gli era brillato nella mente fin dall’età di appena cinque anni. Ciò formava il suo più vivo desiderio, ciò sembravagli l’unica cosa che far dovesse su questa terra. Tale propensione era pure segnale della sua vocazione.
Nel 1825 adunque Giovanni incominciò quella specie di Oratorio festivo, facendo quanto era compatibile coll’età sua e colla sua istruzione; e lo continuò per parecchi anni, riuscendo sempre meglio fruttuose le sue parole, quanto più cresceva il suo corredo di cognizioni religiose. A tal uopo metteva un impegno singolare nel raccogliere dai catechismi, dalle prediche, dalle letture fatte, narrazioni edificanti, per istillare in quanti l’udivano l’amore alla virtù.
Ma non i soli racconti, i soli giuochi e le belle maniere erano l’incanto che legava a lui i cuori di tanti giovani. Dal suo sguardo, dal suo volto doveva allora trasparire la purezza dell’anima sua, come sempre trasparì fino agli ultimi suoi giorni. Incontrarlo, stargli vicino cagionava una gioia, una pace, un diletto, una brama di farsi migliore, che non può avere la sua sorgente in affezione puramente umana. Ciò provarono migliaia di fanciulli, ciò attestarono [144] migliaia de’ suoi cooperatori, che, conosciutolo, più da lui non sapevano distaccarsi, e mai più poterono dimenticare quel fascino di attraimento così sorprendente. La spiegazione di ciò viene pôrta dal libro della Sapienza: – “O quanto è bella la generazione casta con gloria (delle vinte tentazioni)! La memoria di lei è immortale, perchè ella è conosciuta dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. La imitano quand’ella è presente; e la desiderano quando ella è partita; e coronata trionfa nell’eternità, vinto il premio dei casti combattimenti[44]”.
Ma che il campo di azione, destinato dalla Provvidenza al piccolo figlio di Margherita, fosse più esteso di quello che parer potesse in principio, ben fu dimostrato fin d’allora da varie circostanze, nelle quali sembra impossibile che un fanciullo abbia avuto tanta sicurezza d’azione. Valgano, fra gli altri, i fatti seguenti.
Quando era sugli 11 o 12 anni, in occasione di una festa, ebbe luogo il ballo pubblico sulla piazza di Morialdo. Era il tempo delle sacre funzioni vespertine, e Giovanni, desiderando che cessasse quello scandalo, si portò sulla piazza, e mischiatosi tra la folla, composta in parte di suoi conoscenti, cercava di persuader la gente a desistere dal ballo e ad andare in chiesa ai vespri. – Guarda qui un fanciullo, quasi ancora a balia, che viene a darci legge! – diceva uno.
– Chi ti ha data questa graziosa missione di venirci a fare il predicatore, il padre spirituale? – replicava un altro.
– Ci vuole il tuo muso per venirci a disturbare nel più bello del nostro divertimento! – soggiungeva un terzo. [145]
– Va pei fatti tuoi, e non intrigarti in ciò che non ti spetta! – brontolava bruscamente un quarto. E gli ghignavano in faccia. Giovanni allora si mise a cantare una canzone religiosa, popolare, ma con una voce così bella e così armoniosa, che a poco a poco tutti corsero a lui d’attorno. Egli, dopo qualche istante, si mosse verso la chiesa: gli altri tutti lo seguirono come incantati dalla sua voce, finchè entrato egli in chiesa, vi entrarono essi pure.
Appressandosi la notte, Giovanni ritornò in mezzo al ballo, che era stato ripreso con pazza frenesia. L’aria si faceva sempre più scura, e Giovanni diceva alle persone che gli sembravano più assennate – È tempo d’andar via: il ballo diventa pericoloso. – Ma, badandogli nessuno, si mise a cantare come aveva fatto poche ore prima. Al suono dolce e direi magico della sua voce, cessarono le danze e rimase sgombero il luogo del ballo. Tutti corsero intorno a lui per udirlo, e quando ebbe finito gli offersero non pochi doni perchè ricominciasse. Riprese il suo canto, ma non volle accettare doni. I rettori del ballo, che vedevano col cessare delle danze cessare eziandio il loro guadagno, gli si avvicinarono e offrendogli del danaro gli dissero: – Ecco; o tu accetti questo danaro e te ne vai, o sono busse che ti prendi, quali non hai mai sentite.
– Oeh! rispose Giovanni, che parlare è il vostro? Qui son forse in vostra casa per obbedirvi? Non sono libero di fare ciò che più mi talenta? Io ho qui parenti, che sono attesi alle loro case: se vengo a chiamarli, vi faccio torto? Le famiglie temono che succeda qualche disgrazia, qualche rissa, qualche ferimento: non è giusto che siano tolte dall’ansietà? A quest’ora specialmente, voi che avete giudizio, e siete brave persone, dovete intendere che non è impossibile che succedano disordini, dei quali poi vi resterebbe rimorso. Se io desidero [146] l’ordine, gli è che la nostra borgata ebbe sempre un nome onorato presso gli altri paesi. Con questo forse vi manco di rispetto? – Queste ed altre simili ragioni, dette da un fanciullo, fecero stupire, e convinsero molti ad abbandonare il ballo. I più fanatici per le danze stettero ancora qualche istante; ma, essendo più in pochi, si determinarono essi pure di ritirarsi.
Si narra che in questa stagione gli sia accaduto un fatto singolare, che per altro si ripetè poi ancora in varie occasioni: sfidare cioè con giuochi di destrezza que’ ciarlatani, che disturbavano le funzioni di chiesa.
Nella cappella di una borgata vicina ai Becchi una sera vi doveva essere predica. La casa di Dio era mediocremente piena, ma la piazza innanzi a questa era tutta ingombra di uomini, che facevano udire a coloro, che già erano dove il dovere religioso li chiamava, il loro confuso mormorio. Quand’ecco all’improvviso s’aggiunge sulla piazza il suono della tromba. Nessuno più potè rattenere i ragazzi, i quali scattarono dai banchi e si precipitarono alla porta della chiesa. Le ragazze tenner dietro ai giovani; e dopo queste anche le donne spinte da curiosità si mossero. Il piccolo Bosco a tal vista corse egli pure sulla piazza, e fattosi largo tra la folla, si presentò in prima linea. Il comparire del giovanetto, noto per i suoi divertimenti così abilmente condotti, fece volgere a lui gli sguardi di tutti. Col capo e colle mani gli accennavano il cerretano, quasi per dirgli che avea trovato un competitore. Giovanni, che era uscito di chiesa, non per curiosità, ma per effettuare un suo disegno, si avanzò nel mezzo del circolo e sfidò il ciarlatano a far prova chi meglio fra loro due sapesse dar saggio di destrezza. Il ciarlatano guardò dall’alto in basso il fanciullo con aria di scherno, ma gli applausi del popolo alla proposta [147] del giovanetto gli fecero capire che non era suo onore rifiutare la sfida. Da tutte parti si gridava: – Bravo, bene; sì, fa vedere la tua abilità! – Venne di comune accordo proposto non so quale giuoco. – Accettato, concluse Giovanni, ed ora veniamo alle condizioni: queste le propongo io: se voi vincete, io vi darò uno scudo: se vinco io, voi uscirete immediatamente dal territorio di questo paese, e non ci riporterete mai più piede in tempo delle sacre funzioni. – Tutta la gente avida di quel nuovo spettacolo: – Sì, sì – gridava. – Accetto – rispose il ciarlatano, sicuro della sua vittoria. Ma questa all’atto pratico fu di Giovanni, e il ciarlatano, raccolti i suoi arnesi, dovette mantenere la parola, e partire all’istante. Allora Giovanni disse alla turba: – E noi in chiesa! – e precedendola entrava nella casa di Dio.
Altra volta una persona straniera alla borgata, con lazzi poco verecondi, discorreva in mezzo a un numeroso crocchio di uomini e fanciulli, infiorando eziandio i suoi ragionamenti con motti che sapevano di bestemmia. Giovanni, addolorato per quello scandalo, e vedendo che non era possibile impor silenzio all’uno e troncare le risa sguaiate degli altri, che cosa pensò di fare? In quel luogo vi erano due alberi poco distanti uno dall’altro: egli, presa una corda e fattole un nodo alle estremità, queste una dopo l’altra lanciò ad un ramo di ciascun dei due alberi, sì da rimanere strettamente allacciate e che la corda stesa fosse fortemente assicurata da non cedere. In due colpi l’operazione fu eseguita. La folla, accortasi di quella così abile manovra, lasciò il maldicente e venne a fargli corona. Giovanni allora spiccò un salto tanto alto da aggrapparsi alla corda; vi si assise sopra; quindi lasciò penzolare la testa, rimanendo attaccato solo pei piedi, poi si rizzò e prese a camminare su e giù, come se [148] fosse in solido sentiero. Il giuoco durò fino a tanto che, venuta la sera, tutti si dispersero per ritornare ai propri casolari.
Così il giovanetto Bosco incominciava le prime prove della sua missione con quei mezzi che la divina Provvidenza aveagli forniti. E quel Dio, che secondo l’espressione del libro dei Proverbi scherza continuamente nell’universo colla sua onnipotenza creatrice e conservatrice, e pone le sue delizie nello stare coi figliuoli degli uomini, in certo modo cominciava a presentare al mondo l’istrumento, del quale voleva servirsi per la sua gloria. “Le cose stolte del mondo elesse Dio per confondere i sapienti; e le cose deboli per confondere le forti; e le ignobili e le spregevoli e quelle che non sono per distruggere quelle che sono; affinchè nessun uomo si dia vanto dinanzi a lui e chi si gloria, si glorii nel Signore[45]”.
CAPO XVIII.
Mamma Margherita scuola di carità per Giovanni verso i poveri, i banditi, i pellegrini, gli infermi – La Provvidenza divina soccorre Margherita nella sua povertà – Santo fine col quale ospita i bisognosi.
GIOVANNI, cresciuto alla scuola della sua buona madre, ben poteva ripetere le parole di Giobbe: “Dall’infanzia meco crebbe la misericordia e meco uscì dal seno di mia madre[46]”. Infatti massima costante di Margherita era di far sempre del bene a chi poteva, e guardarsi dal far del male ad alcuno, fosse pure con una parola meno riverente o poco amorevole. Il suo animo era sempre tranquillo, nè mai fu che nutrisse risentimento verso alcuno. Non ebbe mai occasione di perdonare, perchè non si reputò mai offesa. Eppure era di carattere sensibilissimo; ma questa sua sensibilità era talmente trasnaturata in carità, che a buon diritto potea chiamarsi la mamma di coloro che si trovavano nel bisogno.
Ella non seppe mai dare a nessuno un rifiuto, e nulla mai negò di quanto gli altri la richiedevano, come se avesse possedute ricchezze sfondolate. I vicini venivano a lei ora [150] per fuoco, ora per acqua, ora per legna. Agli infermi che bisognassero di vino, ne donava generosamente, rifiutando ogni compenso. Dava ad imprestito olio, pane, farina di grano, farina di meliga, sempre che ne fosse richiesta e senza mai dare a vedere che le pesasse simile importunità. Talora chi si era fatto imprestare del pane, trovandosi nella strettezze, veniva a lei peritoso, dicendole: – Margherita; avrei bisogno di pane, ma ho ancora da restituirvi quello che mi avete dato nella settimana scorsa. – Non pensateci più al pane che avete preso nell’altra settimana: vi proibisco di farmene più parola: penserete solamente a restituirmi quello che vi do oggi. – E assolutamente così voleva.
La sua casa era tra i boschi, e più d’una volta dopo cena, a notte inoltrata, sopraggiungevano i banditi, i quali al di là della siepe, che circondava l’aia, chiamavano a voce bassa la padrona della cascina. Usavano questa precauzione per timore d’imbattersi nei gendarmi. Margherita veniva fuori, e quei poveretti, spossati, affamati le chiedevano qualche cosa da mangiare. E Margherita: – Venite pure avanti con sicurezza; per ora non entrate in casa: ho nulla di preparato per ristorarvi, ma non importa: ci aggiusteremo, povera gente! – E chiamava Giovanni e dicevagli: – Va a prendere legna, riempi d’acqua la pentola e falla bollire. Prepareremo la minestra, e la daremo a questi amici. Guárdati però bene dal dire a nessuno ciò che si è fatto stasera. – Giovanni eseguiva tosto gli ordini ricevuti e quindi avvertiva la mamma che la pentola bolliva.
– Getta le paste.
– Mamma, non ne trovo.
– Guarda se c’è della farina.
– Non ce n’è.
– Ebbene, prendi dei pezzi di pane e fa la zuppa. [151]
Talora in casa non vi era più altro da mangiare che croste o pezzi di pane secco. Versata in una scodella la minestra bollente, Margherita chiamava dentro il bandito o i banditi, e li conduceva in un angolo oscuro della stanza, ove la fiammella proiettava l’ombra dell’asta della lucerna. I poveretti divoravano quel cibo, e ristoratisi dicevano: – Grazie, mamma… e da dormire?
– Là v’è un solaio, vi è della paglia. Io non ho altro letto da potervi offrire. Abbiate pazienza.
– Anzi, contentoni; ma… e i carabinieri?
Nella stalla eravi un lucernaio, che sembrava destinato al solo uso di finestra, ma dal quale si passava nel fienile. Nessuno però, che non avesse pratica del luogo, potea immaginarsi che ivi fosse un’uscita. Margherita con brevi parole indicava agli ospiti la topografia della casa e dava loro la buona notte. I banditi, prima di andare a dormire, commossi voleano baciare la mano a mamma Margherita; ma essa: – No, non è questo che io desidero; voglio che andiate a recitar le preghiere. – Sì, sì, lo faremo! statene certa! – E salivano nel luogo indicato, ove passavano la notte tranquilli e con un silenzio rispettoso, come se fossero stati agnellini, nè mai in tanti anni le recarono la menoma noia.
Ma il bello sta qui, che sovente, e talora pochi istanti dopo essersi ritirati i banditi per prender sonno, bussavano alla porta nuovi ospiti. Erano niente meno che i reali carabinieri, i quali avevano l’usanza d’incontrarsi nella casa di Margherita per la corrispondenza, ed ivi si fermavano un tempo abbastanza notevole per riposarsi della marcia. Appena giunti, dati i primi saluti, subito chiedevano a Margherita notizia dei figli. – Giuseppe, Giovanni stanno bene? – E quindi chiamavano Giuseppe, pel quale avevano singolare simpatia. Giuseppe infatti tosto correva a dar loro il [152] benvenuto, avea mille interrogazioni da fare, volea sapere tutte le loro notizie della giornata, le avventure che aveano incontrate e tutte le circostanze degli arresti operati. Ed i carabinieri, vedendolo così vivace, di così facile parola e nello stesso tempo così contento di trovarsi in loro compagnia, s’intrattenevano con molto piacere a parlargli. Con Giovanni però non aveano troppa famigliarità, perchè sdegnava le carezze, parlava poco, non interrogava mai, e stava attentamente ad udire, senza fare osservazioni.
Ma ciò che accadeva non poche volte di singolare in quell’istante era, che i banditi stavano divisi dai carabinieri da una sola porta od assito, e talora da una finestra che in luogo di vetri avea fogli di carta, ed ascoltavano tutti i ragionamenti di coloro che aveano l’ordine di trarli in carcere. Si diede perfino il caso di un bandito sorpreso all’improvviso in quella stanza, sì da non poter rifugiarsi altrove. I carabinieri alle volte sedevansi intorno alla tavola, sulla quale già erano stati posti il sottocoppa ed i bicchieri, ed aspettavano che Margherita li regalasse di una bottiglia di vino, mentre il bandito in un angolo si trangugiava gli ultimi cucchiai di minestra; tuttavia, benchè molte volte sapessero chi stava in quel momento nascosto in casa, dissimulavano e non tentarono mai un imprigionamento, sia perchè ben conoscevano come Margherita nella sua carità soccorresse la sventura indistintamente senza alcun fine secondario, sia per non compromettere quella buona famiglia in intrighi coi tribunali; d’altra parte non era cosa tanto facile metter le mani addosso ad uomini disperati, armati fino ai denti, e prevenuti: prima di perdere la libertà, avrebbero certamente ingaggiata una lotta terribile e forse anche micidiale: era quindi eziandio nel loro interesse di attendere un momento più opportuno e favorevole. Per circostanze impreviste avvenne [153] talora che, mentre i carabinieri entravano da una porta, dall’altra entrassero pure i banditi, i quali si ritraevano precipitosamente. Era impossibile che gli uomini d’arme non si accorgessero allora come in casa vi fossero persone non appartenenti alla famiglia e che erano corse a nascondersi; per lo più toccava al fratello Giuseppe accomodare la faccenda, mentre il cacciatore e la selvaggina erano distanti fra di loro appena di pochi palmi.
Un giorno un brigadiere appena entrato si fermò, e guardando attorno come chi sta in ascolto, disse ad alta voce: – Là c’è qualcheduno. – Giuseppe si fece innanzi: – Chi volete che ci sia?
– Qualcuno nascosto.
– V’ingannate. Non vedete che noi della famiglia siamo tutti qui?
– Eppure vi dico che vi è qualcuno!
– Ed io vi ripeto che non vedo persona. – E frenava a stento le risa. Il brigadiere non proseguì oltre le sue indagini; avea voluto solamente dar prova di accortezza.
Altra classe di persone facea capo alla casa di Margherita: erano i merciaiuoli ambulanti. Non essendovi allora tanta comodità di strade e di osterie, chi si metteva in viaggio pe’ suoi negozi, era obbligato a passare più notti fuori della propria abitazione, e quindi doveva chiedere ospitalità in qualche famiglia che volesse assoggettarsi a simile incomodo. Essendo nota pertanto la bontà di Margherita dalle parti di Morialdo, la sua casa era il convegno di tutti coloro che cercavano un tetto ospitale.
– Mamma Margherita, avete un po’ di alloggio?
– E perchè no!
– E anche un po’ di cena?
– Lasciate fare a me: qualche cosa troveremo. [154]
Quando la dispensa era provvista del necessario, la cena era prestamente all’ordine; ma più d’una volta Margherita dovea porre il cervello a tortura per non lasciare l’ospite a stomaco vuoto. Giovanni era sempre il cuciniere ufficiale in queste occorrenze. Una volta fra le altre, che dovette annunziare alla madre esservi più nulla per la cena dell’ospite, Margherita sorridendo si diede a cercare e finalmente trovò un pane di miglio. Spezzatolo, lo mise nella pentola; ma bollendo divenne una poltiglia talmente insipida, da non potersi mangiare. Giovanni la fece gustare alla mamma, la quale continuando il suo ridere affettuoso andò alla stalla, munse un po’ di latte, lo gettò nella pentola e con questo fece un condimento che rese saporita quella farina di miglio. Ma quello che condiva più di tutto la caritatevole ospitalità era la sua cortesia ed amorevolezza. Al mattino in sul partire l’ospite non avea parole bastanti per ringraziare colei, che costantemente rifiutava ogni offerto compenso col dire: – Io tratto gli amici e non faccio la locandiera.
Se Margherita così agiva con chi non versava che in una necessità momentanea, si può arguire con quale tenerezza accoglieva coloro che erano veramente poveri. Suo figlio Giovanni ricordava sovente come in una notte invernale venisse un miserabile chiedendo d’essere ricoverato. La campagna era coperta di neve e di ghiaccio; ed il poveretto avea le scarpe così sdruscite, che gli scappavano dai piedi. Margherita non avea calzari da donargli; ma al mattino, mentre era per partire, fattolo sedere, gli involse i piedi in un panno; quindi, con alcune cordicelle gli legò sotto le piante la suola delle ciabatte, e facendogli girar le stesse cordicelle attorno alle gambe, lo aggiustò a modo degli antichi romani. E ciò eseguì con tanta maestria, che il poverello potè camminare speditamente, senza il tormento del freddo. Con ragione [155] adunque questa santa donna potè dire al Signore: “Non istette il pellegrino allo scoperto: la mia porta fu aperta al passeggiero[47]”.
In una casetta non lungi da quella di mamma Margherita abitava un certo Cecco, il quale, amante della buona tavola e del lavorar poco, erasi ridotto all’estrema miseria. Viveva quindi a stecchetto, soffrendo molte volte la fame; ma non osava chiedere elemosina, sia per vergogna, sia perchè temeva ricevere ripulse e rimproveri per aver consumato il suo patrimonio. L’infelice dimorava solitario, e di rado usciva di casa. Margherita, compassionando la sua condizione, di quando in quando recavasi sotto la loggia di quella casa, e dalle finestre a pian terreno, senza essere veduta da alcuno, per non umiliare quel miserello, gli gettava nella stanza una quantità di pane sufficiente per qualche giorno. Dopo varii mesi, incontrato per caso Cecco, che ringraziavala colle lacrime agli occhi, gli si offerse di provvederlo di quando in, quando anche di minestra, e restarono d’accordo sul modo: cioè, essa sul far della notte avrebbe dato il segnale, rimproverando ad alta voce qualcuno de’ suoi figli. Portava infatti cautamente sulla piccola loggia del vicino una pignatta di minestra calda, e, ritornata a casa, come se fosse in collera incominciava a gridare a Giovanni o a Giuseppe. A quelle grida il vicino apriva la porta, sporgeva la mano e ritirava in casa la minestra.
Per dir che facciamo, non potremo mai celebrare abbastanza la generosità di questa donna, la cui vita fu un’opera continua di carità. Tuttavia per quanto ella desse agli altri, sempre ebbe di che far elemosina: sembrava che la Provvidenza [156] si prendesse cura essa stessa di non lasciarle mancare il necessario, specialmente quando erasi privata di tutto.
Un giorno Margherita non avea più pane in casa e mancava assolutamente di farina. Mentre studiava il modo di provvedere, ecco venire a caso un suo vicino, certo Luigi Veglio, per salutarla. Accortosi dell’impiccio della buona donna, uscì subito senza dir parola, e ritornato alla sua abitazione, posta a Filippelli, frazione della borgata, chiamò un servo e gli disse: – Vieni qui, e prendi questo sacco di farina. – Il servo fece la prova di sollevare quel sacco: – È troppo pesante! – esclamò. – Se non puoi portarlo tutto in una volta, dimezzalo e portalo in due volte – disse il padrone. – E dove debbo portarlo? – Vieni con me! – E condusse il servo poco lungi dalla casa di Margherita: – Vedi, portalo e lascialo in quella casa, ma non dire essere io che l’ho mandato. – Il servo salì, depose il sacco e consegnandolo a Margherita: – È per voi! – disse. – E chi vi ha dato ordine di portare questa farina? – interrogò Margherita. – Mi fu vietato di dirvelo. – Margherita insisteva; il servo si inviluppava in risposte evasive, misteriose. Margherita però ben indovinava chi ne fosse il donatore, conoscendo presso di chi era a servizio quell’uomo. Finalmente entrò Luigi Veglio, il quale, stando nascosto a piccola distanza, avea udito quel dialogo, e francamente le disse: – Ascoltatemi, Margherita: sono io davvero; avrei amato meglio rimaner sconosciuto, ma poichè vedo che il mio servo non è capace di custodire un segreto, non voglio farvi misteri. Ciò che ho fatto è un mio dovere. Voi avete dato tutto ai poveri, ed è ben giusto che altri venga in vostro soccorso, trovandovi voi nella necessità.
Da quel punto la moglie di Veglio, di nome Maria, vedendo Margherita consumare in quel modo il fatto suo, [157] non meno generosa del marito, prese a mandarle ora una mezza emina di frumento, ora un sacco di meliga, ed ora anche provviste di vino. Spesse volte le diceva: – Quando non avete più nulla da dare in elemosina, venite pure a casa mia e prendetevi ciò che vi farà di bisogno. E specialmente quando andate a visitare gli ammalati, se li trovate mancanti del necessario, fatemi subito avvertita ed io provvederò. – Infatti Margherita era l’angelo consolatore di tutti gli infermi e di tutti i moribondi della borgata; ed a’ suoi fianchi stava sempre Giovanni, pronto a qualunque servizio ed assistenza, e a correre ove il comando della madre mandavalo, o per chiamare qualche vicino o parente, o per provvedere medicine di erbe, delle quali aveva imparato a manipolare un certo numero. Essa li visitava, li soccorreva, li assisteva, li serviva, passava a canto del loro letto le notti intere, li preparava a ricevere i santi Sacramenti, e, avvicinandosi l’agonia, più non li abbandonava finchè fossero spirati. Essendo la parrocchia lontana, e però difficile che potesse giungere il prete in tempo per leggere le preghiere degli agonizzanti, Margherita stessa raccomandavane l’anima al Signore e suggeriva loro sentimenti così cristiani, così opportuni e con termini così propri, che le sue parole faceano profonda impressione eziandio in tutti gli astanti.
Tanta generosità di cuore in Margherita non deve far meraviglia, poichè essa era donna di continua preghiera. Nell’uscire di casa per andare al lavoro, nel ritornare dalla campagna, in mezzo alle sue faticose occupazioni, recitava e ripeteva il santo rosario. Era bello in sulla sera vederla avviarsi verso casa, tenendo sulla spalla colla mano sinistra la zappa od il sarchiello, conducendo colla destra i suoi due fanciulli, e recitare l’Angelus Domini al suono della campana [158] che lontana risuonava in fondo alle valli. In casa poi non vi era mai motivo sufficiente per farle ommettere le preghiere in comune del mattino e della sera; anzi invitava sempre i suoi ospiti a pregare con lei per tutta ricompensa dell’ospitalità loro accordata. Erano banditi, carabinieri, negozianti, poverelli, viaggiatori smarriti; ma nessuno osava rifiutarsi. Ella avea loro posto innanzi, come a fratelli, quanto possedeva: pane, polenta, minestra, vino; sarebbe stata certo una villania non accettare un invito, del quale tutti sentivano la ragionevolezza, eziandio coloro che solevano trascurare il dovere dell’orazione. Era veramente una scena sorprendente vedere i carabinieri togliersi il cappello e piegar le ginocchia; ovvero i banditi chinar la fronte velata da folti capelli e pronunciare quelle parole del Pater o dell’Ave, che da tanto tempo non avevano più recitate. Margherita in quel momento giubilava nel suo cuore, poichè il fine principale della sua ospitalità era precisamente questo di trarre dalle labbra de’ suoi ospiti un inno di lode al Signore. E questo inno ritornava sopra di lei e sopra la sua famigliuola come rugiada di grazie feconde; perocchè quanti erano da lei beneficati, passando innanzi alla sua casa o ricordandola, doveano ripetere le parole del Salmo: “La benedizione del Signore sopra di voi: noi vi abbiamo benedetti nel nome del Signore[48]”.
CAPO XIX.
Dalla mamma Giovanni apprende l’amore alla virtù e lo zelo per impedire l’offesa di Dio e procurare la salute delle anime.
LA fermezza di carattere di Margherita non si può comprendere, nè degnamente descrivere, se non da chi la conobbe davvicino. Ella aveva dichiarato guerra perpetua ed implacabile contro il peccato. Nè solo aborriva essa ciò che era male, ma studiavasi di impedire l’offesa del Signore eziandio presso coloro che non le appartenevano. Quindi era sempre all’erta contro lo scandalo, prudente e risoluta a costo di qualunque sacrifizio.
Alcune volte i contadini di qualche frazione di quella borgata, desiderosi di darsi un po’ di spasso e far quattro salti, mandavano in cerca di un organino. Come lampo si spargeva la notizia di masseria in masseria, e la gente uscita di casa gridavasi da una collina all’altra: – Andiamo al ballo, andiamo al ballo! – A quell’allegro vociare, al suono dell’organino, che si spandeva per l’aria sopraggiungendo la sera, i figli di Margherita correvano a lei: – Mamma, andiamo anche noi. – Essi non pensavano ad altro che al chiasso ed alla musica. Margherita però, accogliendoli col suo sorriso consueto, diceva loro: – State qui fermi ed aspettatemi; vado io a vedere che cosa c’è di nuovo. – Se vedeva [160] un’accolta di oneste persone e che trattavasi di una ricreazione alla buona, senza ombra di male, ritornava dicendo ai figli: – Andate pure! – Ma se avea osservato una sconvenienza, fosse pure minima, la risposta era perentoria: – Questo divertimento non fa per voi.
– Ma… ma… ma…
– Non c’è ma che tenga. In nessun modo io voglio che sdruccioliate all’inferno. Avete capito? – I figli contrariati per un istante restavano silenziosi; ma la buona mamma, chiamatili intorno a sè, incominciava a raccontare qualche istoria così sorprendente e ben intrecciata di guerrieri e di castelli, da vincere in fantasia lo stesso Ariosto. Esponeva così bene quelle strane avventure, che i figli si dichiaravano più contenti di trovarsi lì ad udir lei, che se fossero stati soddisfatti nella loro domanda. Inoltratasi la sera, Margherita concludeva: – Su, andiamo a dormire; ma prima recitiamo una preghiera per chi morrà questa notte, acciocchè non vada perduto. – Queste parole faceano un effetto magico e salutare sull’animo di quei fanciulli.
Ella poi prendevasi tale cura delle ragazze, da parere ne avesse fatto generoso proponimento. Se incontrava per via certe poverelle colle vesti a brani e non sufficienti, loro si avvicinava, e: – Non arrossite del vostro angelo custode che vi sta al fianco? Non sapete che egli si copre il volto colle mani e si vergogna di avervi in custodia?
– Ma noi siam povere, e nessuno si prende cura di darci o mutarci i vestiti.
– Or bene, venite con me – e le conduceva a casa sua, si metteva loro dattorno, rappezzava quelle vesticiuole, vi aggiungeva qualche pezzo di tela o di panno tanto che bastasse, e le rimandava con Dio, non essendo più le ributtanti persone di prima. Benchè costretta a lavorare da mane a sera per [161] provvedere la famiglia del necessario, non avea timore di perdere un tempo assai notabile in quest’opera di carità.
In modo particolare cercava di fare del bene a quelle povere creature, che sospettava trovarsi in qualche pericolo. Ora dava loro del pane, ora preparava per esse la polenta, ora le regalava di qualche frutto, ora metteva in serbo per affezionarsele quel companatico, del quale sapeva essere ghiotte. Le invitava a venire in casa sua tutte le volte si fossero trovate in bisogno, le accoglieva come una madre accoglie le proprie figliuole, le soccorreva generosamente in quel miglior modo che le era possibile, e non le congedava mai senza qualche opportuno consiglio. Soprattutto vegliava che non frequentassero la compagnia di persone di altro sesso, e per separarle usava tante arti così fine e delicate, che sarebbe cosa troppo lunga discorrerne. Era tutt’occhio, specialmente nelle veglie invernali. Non precipitava però mai nel dare un avviso, ma attendeva l’opportunità per poter parlare da sola a sola. Allora insegnava, a chi ne avea di bisogno, il modo di stare composta quando assidevasi in mezzo alla compagnia, facea notare la sconvenienza di porsi vicino a certuni, ed indicava la maniera di regolarsi quando s’intratteneva col tale o col tale altro e come dovesse modificare il suo parlare e correggere i gesti e le risa sguaiate.
Con queste sue maniere, Margherita si era talmente imposta a tutte le ragazze de’ dintorni, che era una meraviglia il vedere quanta riverenza le portassero. D’estate, pel caldo soffocante si usa nelle famiglie una certa libertà di vestire, che non è certamente ispirata dall’austerità del Vangelo. Or bene, entrando Margherita nelle altrui case, le ragazze al solo udirne la voce, se non erano in istato da potersi presentare, scappavano a nascondersi, ovvero correvano a mettersi in un abbigliamento più decente, e ricomparivano solo quando fossero [162] sicure di meritarsi una parola di lode dalla buona Margherita. Qualcuna però sorpresa talvolta senza aver tempo a fuggire, trovava il suo rifugio al fianco di lei, se altre persone erano pure sopraggiunte; e Margherita allora quasi per vezzo le metteva sulle spalle un lembo del proprio grembiale e curvandosi diceale all’orecchio: – Come puoi aver l’ardire di farti vedere così dal Signore?
Abbiam notato più sopra come Margherita ospitasse volentieri eziandio i merciaiuoli ambulanti. Nella sua carità essa aveva un fine speciale. Costoro più d’una volta recavano nelle loro ceste immagini indecenti, o libri poco morali da vendere sulle fiere. Margherita, accorgendosene, pregavali a voler donare a lei quei libri o quelle immagini, che talora di presente dava alle fiamme, oppure riponevali per consegnarli poi immancabilmente al cappellano di Morialdo. Soventi volte i negozianti stessi per compiacerla distruggevano sul fuoco quegli oggetti sotto i suoi occhi. Ella non sapeva leggere; eppure vegliava attentamente sui libri che giravano attorno, e argomentava della bontà o della malvagità loro dalle poche parole, che sapeva trarre destramente di bocca ai possessori. Essa poi in ricompensa non li trattava come forestieri, sibbene come amici: li facea sedere seco a mensa e loro poneva innanzi quanto avea riposto di meglio per la cena della propria famiglia. Nel congedarli poi non tralasciava mai di farsi promettere che non avrebbero più venduto stampe o figure, che potessero riuscirò nocevoli alle anime, promessa che facilmente otteneva da persone guadagnate dalla sua carità.
Accadde più di una volta che le toccasse essere testimone di qualche grave scandalo, ed allora la sua energia e franchezza spiccava in modo meraviglioso. Una domenica, mentre andava alla S. Messa tenendo per mano Giuseppe e Giovanni, tra la folla ognora crescente precedevala un gruppo [163] di quindici o venti giovinastri. Fra costoro compariva capo brigata un uomo sui sessant’anni, già stato condannato per furto a varii anni di carcere. Costui parlava cogli altri ad alta voce di cose oscene, e gettando a dritta e a sinistra frizzi indecenti, dava noia alle persone che passavano. Margherita non potè tenersi e avvicinatasi lo chiamò per nome. – Che cosa volete? – rispose colui volgendosi indietro e arrestando il passo. E Margherita sottovoce: – Sareste voi contento che le vostre figliuole udissero i discorsi che voi fate in questo momento?
– Eh là! Che cosa volete farci! Si sa! bisogna stare allegri! Si parla per ridere! Non è più permesso ridere? Si reca danno a qualcuno ridendo? Bisognerebbe uscir dal mondo per non udire certi discorsi.
– Ma quelle cose che voi dite sono cattive o no? E se sono cattive, perchè le dite?
– Oh quanti scrupoli! Siete ben noiosa, sapete! Sono cose che si dicono da tutti, e non potrò dirle io?
– E fosse anche vero che si dicono da tutti, è forse men vero che sieno peccati? E se voi andrete all’inferno, che cosa vi gioverà che altri pure abbiano tenuti quei propositi che tenete voi? – A quest’apostrofe dell’imperterrita donna, il villanzone si mise a ridere sgangheratamente, ed i suoi compagni – che aveano pure fermato il passo, gli fecero eco. Margherita allora con voce commossa: – E voi alla vostra età, coi capelli bianchi, invece di dare buon esempio, siete a questo modo lo scandalo dei poveri giovani? Vergognatevi! – E traendosi dietro i figli, lasciò la via maestra per giungere alla chiesa per un sentiero in mezzo ai prati. Quando fu sola, la santa donna si fermò e disse ai figli: – Sapete quanto amore io vi porti; eppure, piuttosto che voi diveniate malvagi come quel lurido vecchione, non solo preferisco che il Signore vi [164] faccia morire qui sull’istante, ma mi sentirei il coraggio di strangolarvi io stessa colle mie mani! – Parole troppo energiche, si dirà: ma chi ama l’innocenza e il candore dei propri figli, troverà in esse l’espressione di un sentimento profondo, l’importanza cioè di conservare la grazia di Dio.
Una sera, mentre Margherita era in casa, udì due giovinastri, che, fermatisi in mezzo all’aia, parlavano ad alta voce di cose sconvenienti. Ambedue erano conosciuti per la cattiva condotta e per l’insolenza dei loro modi. Margherita uscì fuori e incominciò a pregarli che volessero cessare da quei motti. I due sfacciati risero villanamente. Essa allora con tono risoluto loro intimò: – Qui non vi voglio assolutamente! – E i due mascalzoni, senza muoversi, intonarono una canzonaccia. – Siete in casa mia, ripetè Margherita; siete sul mio terreno; qui comando io; ritiratevi! – Ma quei provocatori, invece di partirsene, andarono dietro ad un pilastro del fienile e continuarono a vociare e a cantare frasi indegne. Margherita non si diede per vinta. Chiamato uno de’ suoi figli, gli ordinò di recarsi subito a chiamare qualcuno delle famiglie dei due insolenti. Venne la madre dell’uno e il fratello dell’altro: vi fu un po’ di scena; ma finalmente furono costretti ad andarsene; e Margherita loro mai più permise di prendere parte alle veglie della sua stalla.
Un giorno una donna, che abitava poco distante dai Becchi, aveva accolto in casa un forestiero. Tutti quei dei dintorni ne mormoravano ad alta voce. Lo scandalo era certo. Margherita prese sopra di sè l’incarico di farlo cessare, e in sul far della sera andò a quella casa, mentre Giovanni la seguiva e si nascondeva poco lontano dietro di un albero. Battè all’uscio e chiamò: – Marta, Marta!
Dopo qualche istante Marta comparve sulla porta, cui però tenea semichiusa occupando il vano colla persona. [165]
– Siete voi, Margherita?
– Sì, Marta! posso parlarvi un momento?
– Parlate pure! – E continuava a stare fra l’uscio e lo stipite.
– Vi prego; fate un passo più avanti, che nessuno possa udirci. Se siete contenta, debbo dirvi cosa di grande importanza.
– Volentieri, parlate! – rispose Marta dopo un po’ di esitazione; e, chiusa la porta, seguì Margherita fino all’angolo della casa. Margherita l’interrogò sottovoce: – Voi siete Marta?
– E sì.
– Voi siete la figlia del tale?
– Sì; precisamente.
– Voi la sorella del tale altro?
– Sì; dovete conoscermi.
– Voi siete cristiana?
– Quale domanda!
– Voi siete battezzata?
– Ma perchè una simile interrogazione?
– Voi siete quella che andate in chiesa e fate la Pasqua? Ma sì, ma sì. – E Margherita marcando le parole: – Voi? Voi? Voi? Capite ciò che voglio dire quando dico voi? Volete che io stessa condanni all’inferno voi, che finora siete stata la mia amica? – Marta, che aveva benissimo inteso il perchè di quelle interrogazioni, rispose balbettando: – Ma sapete bene la mia posizione, quanto sia miserabile; a nessuno deve far meraviglia, se io do alloggio….
– La vostra posizione si è di non andare all’inferno – l’interruppe Margherita.
– Ma io non so come fare! [166]
– Mandate via quell’intruso.
– Ma è già notte e non è civiltà congedare la gente a questo modo.
– Via, via di casa, continuava Margherita. Se voi non sapete come fare, io lo so quel che fare si debba. – E avvicinatasi alla porta, alzando alquanto la voce in modo da essere intesa da chi era dentro: – Via, via di qua, servitore del diavolo; fuori di qua; via, via. – Intanto la gente, che avea visto Margherita avviarsi a quella volta, indovinandone il pensiero, aveala seguita facendo crocchio ad una certa distanza. Al mormorio della folla che si era avvicinata, alla voce di Margherita, quel galantuomo avrebbe desiderato essere lontano le mille miglia; e però, cercata un’uscita per sgattaiolarsela, si allontanò a precipizio e mai più comparve in quella regione.
Ancora un fatto. Da quelle parti abitava un uomo che teneva in casa una persona, della quale la fama era tutt’altro, che buona. Essendosi costui gravemente infermato, Margherita si presentò per fargli visita; e, avuta a sè quella persona, cercò colle maniere più amorevoli e prudenti di persuaderla ad uscire da quel luogo e ritornare alla sua abitazione, che era poco lontana; ma colei ostinata rispose che non si sarebbe mossa, e non ci fu verso di farle intendere ragione. Intanto l’infermo era venuto agli estremi e fu chiamato il viceparroco, certo D. Campora, il quale, per la lontananza di quella casa dalla parrocchia, vi si recò col SS. Viatico, per amministrare il Sacramento senza dover rifare la strada. Margherita, all’udire che si appressava il Santo Viatico, e angosciata per lo stato di quell’anima, che stava per presentarsi al tribunale di Dio, e per lo scandalo che avrebbe cagionato il non veder rimossa un’occasione prossima, ritornò alla casa dell’infermo. Come il sacerdote, che di nulla sospettava, ebbe deposto sul [167] tavolino la sacra pisside, ella rispettosamente gli si avvicinò e trattolo a parte gli disse: – L’avverto che in questa casa vi è una persona, la cui presenza cagiona scandalo.
– E voi chi siete? interrogò il sacerdote.
– Mi perdoni; ch’io mi sia non importa saperlo. L’avviso perchè non mi sembra conveniente amministrare il Viatico, se prima quella persona non esce da questa casa. Io più volte ho cercato di trarla fuori di qui, ma disgraziatamente non ci sono riuscita.
– Siete sicura di quanto asserite?
– Chiami a sè quella persona, l’interroghi e dalle sue parole potrà argomentare se io dico la verità. – Il prete mandò subito a chiamare l’interessata, che si presentò con una franchezza sconveniente al luogo e a colui che aveala chiamata. Il sacerdote l’interrogò che cosa vi fosse di vero in quelle dicerie che si erano sparse nel paese sul conto suo. – Sono le male lingue, rispose la donna, che cercano sempre d’intromettersi nei fatti altrui: farebbero meglio a pensare a sè: io non vado a cercare ciò che altri fa o non fa; sono persona onorata ed ho i miei motivi per stare dove sono.
– Non è questo che vi si domanda: rispondete a tono; – e le mosse precisa e formale interrogazione. Colei prima negò, poi s’inviluppò nelle risposte, e il prete finì per intendere come Margherita avesse pienamente ragione. Allora invitolla ad uscire da quella casa. La briccona rispose villanamente di no. Il prete risoluto intimolle di obbedire immediatamente: – Come! Siete stata la rovina della sua anima in vita, e volete esserlo eziandio in punto di morte? Volete che per colpa vostra egli vada eternamente perduto? – A quel comando la disgraziata si trovò negli imbarazzi. La gente, che aveva accompagnato il Santissimo, non intendeva il dialogo fatto sotto voce, ma capiva benissimo di [168] che si trattasse; d’altra parte il prete avea detto chiaramente che, se non era obbedito, sarebbe ritornato in parrocchia senza comunicare l’infermo: il che in quei tempi sarebbe stato lo stesso che trarre sopra alla colpevole l’avversione di tutto il paese. Quindi decise di ritirarsi e se ne andò subito a casa sua. Il sacerdote allora entrò nella camera dell’infermo, il quale confessato, comunicato e munito dell’Olio Santo, spirò da buon cristiano dando segni di vero pentimento. Era un’anima salvata da Margherita. Il viceparroco, prima di partire, volle sapere chi fosse colei, che aveagli dato un ammonimento così provvidenziale e che non avea voluto palesare il suo nome. Di ciò Margherita si ebbe lode da tutti i suoi conterranei, i quali d’altronde già sapeano come fosse sua regola costante di operare quella di cercare, in tutti i modi e con tutti i mezzi a lei possibili, la salute delle anime.
Vi fu in una certa circostanza chi osò esternare innanzi a lei qualche proposizione indegna di un cristiano. Vivono ancora alcuni testimoni, che videro Margherita levarsi da sedere, quasi poggiare sulla punta dei piedi, e, colla sinistra sul petto e la destra tesa, prendere un aspetto così tremendo e dagli occhi sprigionare tale espressione di sdegno, da annichilire in certo modo quello sciagurato. Tale doveva essere l’aspetto dell’Arcangelo Michele quando intimava al principe delle tenebre: imperet tibi Dominus.
Il nostro caro Giovanni, testimonio di questi fatti, li raccontava un giorno nella sua già tarda età a chi verga queste pagine, dichiarando che alla scuola di sua madre egli imparò ad avere stima altissima e vivissimo amore per la virtù della purità, e, custodendola gelosamente, a fare ogni sforzo perchè anche gli altri la praticassero.
Da ciò possiamo argomentare quanto fosse bella l’anima di mamma Margherita. La sua nobile figura ci ricorda le [169] parole dell’Ecclesiastico: “Grazia sopra grazia, ella è una donna santa e vereconda. Non v’ha cosa di tanto valore, che possa eguagliarsi a quest’anima casta. Quello che il sole nascente dall’altissima abitazione di Dio è pel mondo, lo è la donna virtuosa per l’ornamento di sua casa. Lucerna, che splende sul candelabro santo nel santuario, è l’avvenenza del volto in ferma età (che dà splendore di virtù alle persone domestiche ed amiche)[49]”.
CAPO XX.
La morte della nonna – Giovanni è ammesso alla prima Comunione – Suoi propositi – Le prediche della missione – Incontro con D. Calosso – Memoria portentosa di Giovanni – Sue liete speranze per gli studi.
STA scritto nel libro dell’Ecclesiastico, al capo III commentato da Mons. Martini: “Figliuolo, prendi cura della vecchiezza del padre tuo e nol contristare nella sua vita; e se egli rimbambisce, compatiscilo e nol disprezzare, perchè tu sei più valente: perocchè la benevolenza usata al padre non sarà posta in oblio (dal Signore). Pei mancamenti poi della madre (le debolezze, le miserie della sua cadente età da te sopportate con pazienza ed amore) avrai tu del bene per mercede. E la giustizia (da te usata verso i tuoi parenti) sarà il fondamento dell’edifizio tuo (della tua famiglia), e nel giorno della tribolazione si avrà memoria di te, e i tuoi peccati si discioglieranno come fa il ghiaccio ai dì sereni”. Tale fu la condotta tenuta da Margherita inverso della vecchia suocera; tali io penso siano state pure le benedizioni piovute sopra di lei e dell’avventurata sua famiglia.
Siamo all’anno 1826. Margherita Bosco, la madre di Francesco, la nonna di Antonio, di Giuseppe e di Giovanni, aveva oltrepassati gli ottant’anni di sua vita, e aggravandosi [171] le sue abituali infermità, vide appressarsi con occhio sereno il termine de’ suoi giorni. Mamma Margherita, quando intese che la suocera non si sarebbe più alzata dal letto, non distaccossi più dal suo fianco. Di giorno e di notte la serviva con tale attenzione e premura, quale maggiore non avrebbe potuto esercitare una suora di carità. Non guardò a spese in medici, medicine e comodità, sicchè coloro, che abitavano nei dintorni, presero a mormorarne e finirono con rimproverarla più di una volta di tanto spreco: – Se spendete tutto il fatto vostro per quella vecchia, che cosa rimarrà per voi e per i vostri figliuoli? Non vedete che sono tutte cure inutili, perchè è impossibile che sopravviva? A quell’età è bella e spedita. – Ma la buona Margherita rispondeva sempre: – È la madre di mio marito e perciò madre mia. Io debbo rispettarla e servirla. L’ho promesso al mio povero Francesco, prima che morisse. Se tutte le spese che io faccio, bastassero a prolungarle la vita anche di un solo minuto, io ne sarei troppo contenta. – E Giovanni coadiuvava del continuo la madre il meglio che poteva, sia nell’assistenza, sia negli apprestamenti necessari, in modo da non essere da meno di qualsivoglia più diligente infermiere.
Intanto il parroco avea amministrato alla buona vecchia gli ultimi Sacramenti. Essa ripetutamente avea detto ai nipotini nei giorni precedenti: – Ricordatevi che la vostra felicità e tutte le benedizioni del Signore dipenderanno dal rispetto e dalla benevolenza che userete a vostra madre. – Ma un giorno li volle avere tutti e tre insieme per dar loro gli estremi avvisi. Loro raccomandò che fossero obbedienti alla madre e che ne imitassero l’esempio, trattandola sempre come essa avea trattato la loro povera nonna, alla quale in tanti anni non avea dato il più piccolo dispiacere: la loro madre, per assistere ed aiutare lei, non aveva voluto [172] uscir di casa e cambiar stato, malgrado gli inviti e le proposte di vita comoda ed agiata: per amor della nonna si era condannata ad una vita di grande sacrifizio, conoscendo ella stessa di averle fatto sopportare molte sofferenze ed esercitare in sommo grado la pazienza; perciò si adoperassero tutti quanti nel dare alla loro mamma quelle consolazioni, onde essa aveva con tanto impegno cercato d’infiorare tutto il corso della vita della nonna.
Il giorno 11 febbraio fu l’ultimo di sua esistenza. Intorno al suo letto stavano Margherita ed i nipoti. La nonna, facendo uno sforzo, loro disse queste parole: – Io parto per la mia eternità; raccomando l’anima mia alle vostre preghiere. Perdonatemi se qualche volta mi sono mostrata severa verso di voi, ma ciò fu tutto pel vostro bene. Ringrazio poi voi, o Margherita, di quanto avete fatto per me. – Così dicendo, la strinse al seno e la baciò con queste parole: – Vi bacio nel tempo per l’ultima volta, ma spero di vedervi tutti assai più felici nella beata eternità. – I nipoti, che piangevano dirottamente, furono condotti nella casa di un vicino e, dopo un’ora circa di penosa agonia, la buona vecchia rendeva l’anima sua al Creatore.
Giovanni intanto, raggiunta l’età di anni dieci, desiderava fare la prima Comunione. Egli però non era conosciuto dal parroco, per la lontananza della borgata. Per ascoltare una predica, o per assistere al catechismo quadragesimale, doveasi percorrere circa dieci chilometri tra andata e ritorno, o a Castelnuovo, o a Buttigliera. La cappella di S. Pietro a Morialdo era pure alquanto lontana dai Becchi, e allora mancava da parecchio tempo di cappellano. Questo difetto di chiesa o cappella, ove recarsi a pregare o a cantare coi compagni, dava grave pensiero al piccolo Giovanni, ed era pure il motivo per cui si veniva volentieri [173] ad ascoltare le prediche del piccolo giocoliere. Quindi Giovanni dovea quasi esclusivamente limitarsi all’istruzione religiosa che impartivagli la buona genitrice, dalla quale però aveva appreso tutto il piccolo catechismo.
Per lo più nessun fanciullo era promosso alla Comunione, se non ai dodici o quattordici anni. Il prevosto D. Sismondo, sebbene ottimo e zelante pastore, imbevuto anch’egli di massime piuttosto rigide riguardo ai Sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia, non s’allontanava da questa usanza seguita generalmente dagli altri parroci. Lo stesso giovane Giuseppe Cafasso, del quale avremo a parlare più innanzi, a tredici anni non era ancora ammesso alla Comunione, non ostante la sua vita angelica e la non comune religiosa istruzione. La madre di Giovanni tuttavia, desiderando di non lasciar andare più avanti nell’età suo figlio senza fargli praticare questo grande atto di nostra santa Religione, si adoperò ella stessa a prepararlo il meglio che poteva e sapeva; come già aveva fatto cogli altri due fratelli Antonio e Giuseppe. Lungo la quaresima poi di quell’anno lo inviò ogni giorno al catechismo in parrocchia, ove fu il modello di tutti col suo buon esempio. Assiduo alle lezioni, udita una o due volte dal curato una risposta anche lunga del catechismo, la riteneva a memoria e la recitava in tutta fretta. Ciò destava meraviglia nei compagni, i quali sempre più a lui si affezionavano, e fu pel curato una buona raccomandazione per l’esame che si diede in sul finir della quaresima.
La Pasqua di Risurrezione in quell’anno 1826 cadeva ai 26 di marzo. Per le lodevoli referenze avute e per il modo, col quale Giovanni aveva risposto all’esame, il prevosto si decise a fare per lui un’eccezione alla regola generale, e lo promosse alla S. Comunione, da farsi nel giorno fissato per la Pasqua di tutti i fanciulli. [174]
In mezzo alla moltitudine era impossibile evitare la dissipazione. E però Margherita volle assistere ella stessa ed apparecchiare con ogni diligenza al grande atto il suo caro Giovanni. Tre volte lo condusse a confessarsi. Lungo la quaresima gli aveva ripetutamente detto: – Giovanni mio, Dio ti appresta un gran dono; ma procura di prepararti bene, di confessarti devotamente, di non tacere cosa alcuna in confessione. Confessa tutto, sii pentito di tutto e prometti a Dio di farti più buono in avvenire. – “Tutto promisi, nota D. Bosco nelle sue memorie: se poi sia stato fedele, Dio lo sa”. A casa lo faceva pregare, gli dava a leggere un buon libro e gli suggeriva quei consigli, che una madre industriosa sa trovare opportuni per i suoi figliuoli.
Al mattino della prima Comunione non lo lasciò parlare con nessuno, lo accompagnò alla chiesa ed alla sacra Mensa, e fece con lui la preparazione ed il ringraziamento, che il vicario foraneo D. Sismondo con molto zelo faceva a tutti con voce alta ed alternata. In quel giorno non volle che si occupasse in nessun lavoro materiale, ma tutto l’adoperasse a leggere e a pregare. E fra le molte cose dettegli sono memorabili queste, che la pia genitrice gli ripetè più volte: – O caro figlio, fu questo per te un gran giorno. Sono persuasa che Dio ha veramente preso possesso del tuo cuore. Ora promettigli di fare quanto puoi per conservarti buono fino alla fine della tua vita. Per l’avvenire va sovente a comunicarti, ma guárdati bene dal fare dei sacrilegi. Di’ sempre tutto in confessione; sii sempre obbediente; va volontieri al catechismo ed alle prediche; ma, per amor dei Signore, fuggi come la peste coloro che fanno cattivi discorsi. – E D. Bosco lasciò scritto: “Ritenni e procurai di praticare gli avvisi della pia genitrice, e mi pare che da quel giorno vi sia stato qualche miglioramento nella mia vita, specialmente nell’obbedienza [175] e nella sottomissione agli altri, al che provava prima grande ripugnanza, volendo sempre fare i miei fanciulleschi riflessi a chi mi comandava o mi dava buoni consigli”.
La buona mamma Margherita non poteva frattanto togliersi dal cuore il vivo desiderio di accontentare Giovanni e metterlo agli studi. L’inclinazione del figlio a questi era ben spiegata; d’altronde egli aveale più volte confidato come si sentisse grande volontà di abbracciare lo stato ecclesiastico. Ella adunque pregava il Signore, acciocchè le mostrasse il modo di vincere le ripugnanze di Antonio, che per altro non volea disgustare maggiormente. Non andò molto che fu consolata da un avvenimento inaspettato.
Il Santo Padre Leone XII, nel 1825, aveva pubblicato in Roma il gran giubileo e ben 400.000 pellegrini erano andati a far le loro divozioni nell’eterna città. Nel 1826 lo estendeva anche alle chiese fuori di Roma. Mons. Colombano Chiaverotti decretava che per l’archidiocesi Torinese dovesse aver luogo dal 12 marzo al 12 settembre. Mirabile fu il concorso dei fedeli a compiere le opere stabilite per l’acquisto dell’indulgenza plenaria, non solo nelle piccole borgate, ma in tutte le città più popolose e anche in Torino. Quivi il Vescovo di Pinerolo predicò gli esercizi spirituali al Re, alla sua Corte e ai Nobili; e si vide la Casa Reale e l’Accademia militare, accompagnata dal Genio e dal fiore dei cittadini, procedere in processione per la città alla visita delle quattro chiese, cantando divotamente le Litanie dei Santi, come gli altri del popolo.
Gli stessi spettacoli di fede si videro nelle provincie. Alcune settimane dopo la prima Comunione di Giovanni, una solenne missione ebbe luogo nel paese di Buttigliera, limitrofo alla borgata di Morialdo. La rinomanza dei predicatori traeva gente da tutte parti, e Giovanni vi andava con molti altri [176] della sua borgata. Fatta un’istruzione ed una meditazione al mattino prima di giorno e in sulla sera, lasciavansi liberi gli uditori di recarsi alle case loro. Una di quelle sere di aprile, Giovanni ritornava a casa in mezzo alla moltitudine. Fra quella eravi un certo D. Giuseppe Calosso di Chieri, uomo assai pio, il quale, sebbene curvo per gli anni, faceva quel lungo tratto di via di circa quattro chilometri, per recarsi ad ascoltare i missionari. Egli era dottore in teologia, già prevosto di Bruino, ed allora erasi ritirato a fare da cappellano a Morialdo. Il vedere un fanciullo di piccola statura, col capo scoperto, coi capelli irti e inanellati, camminare in gran silenzio in mezzo agli altri, trasse il suo sguardo sopra Giovanni. Si conoscea chiaramente che quel contegno era volontario e non naturale, e che in altri momenti non vi sarebbe stato albero per quanto alto, del quale l’arditello non tentasse raggiungere la cima, nè fosso per quanto profondo, nel quale non fosse pronto a gettarsi entro. Il prete lo chiamò a sè e prese a così parlargli: – Figlio mio, di che borgata sei?
– Sono dei Becchi!
– Donde vieni? Sei forse andato anche tu alla missione?
– Sì, signore, sono andato alla predica dei missionari.
– Che cosa avrai tu mai potuto capire? Forse tua mamma ti avrebbe fatto qualche predica più opportuna, non è vero?
– È vero; mia madre mi fa sovente delle buone prediche, ma vado anche assai volentieri ad ascoltare quelle dei missionari, e mi sembra di averle capite.
– Ne hai inteso proprio molto?
– Ho inteso tutto! [177]
– Su! se tu sai dirmi quattro parole delle prediche di quest’oggi, io ti do quattro soldi. Eccoli qui! – E glieli mostrò.
– Mi dica soltanto se desidera che io le parli della prima o della seconda predica!
– Come più ti piace, purchè tu mi dica quattro parole. Ti ricordi di che cosa si trattò nella prima predica?
– Nella prima predica si parlò della necessità di darsi a Dio per tempo e non differire la conversione.
– E che cosa fu detto in quella predica? – soggiunse il venerando vecchio alquanto meravigliato.
– Vuole che le reciti la prima parte, la seconda, ovvero la terza?
– Quel che tu vuoi!
– Me ne ricordo assai bene, e se vuole gliela recito tutta. – E senz’altro attendere, cominciò ad esporre l’esordio, poi i tre punti, cioè che colui, il quale differisce la sua conversione, corre gran pericolo che gli manchi il tempo, la grazia, o la volontà. Il buon prete lasciollo continuare per oltre mezz’ora. Tutta la gente si era fatta intorno al prete per udire, mentre si continuava la strada.
– Ora dimmi della seconda predica.
– Tutta o in parte?
– Due parole solo.
– Se ne vuole qualche brano glielo dirò subito. Ecco: mi fece molto colpo quel tratto, quando il predicatore descrisse l’incontro dell’anima del dannato col suo corpo al suono dell’angelica tromba, quando staranno per unirsi ed andare al giudizio, l’orrore che proverà l’anima nel congiungersi a quel corpo così schifoso e sì brutto che le fu strumento d’iniquità. – E recitò tutto un lungo dialogo dell’anima col corpo come lo aveva esposto il predicatore, continuando così a discorrere [178] ancora per dieci minuti. Dipoi quel buon sacerdote, sempre più stupito e colle lagrime agli occhi per la commozione, si fece ad interrogarlo: – Come è il tuo nome? I tuoi parenti? Hai fatte molte scuole?
– Il mio nome è Giovanni Bosco, mio padre morì quando io era ancor bambino. Mia madre è vedova con cinque creature da mantenere. Ho imparato a leggere e un poco a scrivere.
– Non hai studiato il Donato o la grammatica?
– Non so che cosa siano.
– Ameresti di studiare?
– Assai, assai.
– Che cosa t’’impedisce?
– Mio fratello Antonio.
– Perchè Antonio non vuole lasciarti studiare?
– Dice che a studiare si perde il tempo e vuole che io lavori alla campagna. Ma se io potessi andare a scuola, sì che studierei e non perderei tempo.
– Per qual motivo desidereresti di studiare?
– Per abbracciare lo stato ecclesiastico.
– E per qual motivo vorresti abbracciare questo stato? – Per avvicinarmi, parlare, istruire nella religione tanti miei compagni, che non sono cattivi, ma diventano tali perchè niuno ha cura di loro. – Questo schietto e risoluto parlare del fanciullo fece grande impressione sovra di quel santo sacerdote, che, mentre Giovanni parlava, non gli tolse mai di dosso lo sguardo. Venuti intanto ad un punto di strada, dove era mestieri separarsi, lo lasciò con queste parole: – Sai tu servire la santa Messa?
– Sì, un poco.
– Vieni domani a trovarmi in casa mia. Ho qualche cosa a dirti. – E così lo lasciò. [179]
Giovanni puntualmente si recò a S. Pietro, a casa del cappellano, e gli servì Messa. D. Calosso poi lo condusse in sua camera, ove appena giunto gli disse: – Oh! bene! adesso ho bisogno di scrivere la predica fatta dal missionario. Ti sentiresti di dettarmela?
– Sì, senza difficoltà; ma io non so le parole italiane.
– Non importa, detta come sai.
– Se è così, si metta pure a scrivere, disse Giovanni. – Il cappellano sedette al tavolino, e Giovanni gli dettò una predica intiera dall’esordio alla perorazione, sì da far maggiormente stupire il buon prete di così sorprendente memoria. Giovanni divenuto poi sacerdote fece più volte questa medesima predica e la ricordò interamente fino agli ultimi suoi giorni. In fine il cappellano gli disse: – Sta di buon animo, io penserò a te ed al tuo studio. Di’ a tua madre che domenica sera venga qui un momento con te a parlarmi, e conchiuderemo tutto.
Si può immaginare quale contentezza provò Margherita a questa notizia! La domenica seguente andò col figlio a visitare D. Calosso. Quando il cappellano la vide: – E non sapete, le disse, che vostro figlio è un portento di memoria? Bisogna farlo studiare.
– Avrei bensì piacere che studiasse, rispose Margherita, ma trovo molte e gravi difficoltà. Deve sapere che sono tre fratelli ed egli è il minore. Il più vecchio assolutamente non vuole e metterebbe sossopra la casa.
– Ciò non importa! concluse il buon prete; accomoderemo ogni cosa. Fate quel che potete e sapete, ma mettete questo giovinetto agli studi, perchè tale è il volere di Dio.
– Ed io l’assicuro che farò il mio possibile per appagare questo suo e mio vivo desiderio – concluse ringraziando Margherita. E si convenne che egli stesso, D. Calosso, farebbe [180] scuola una volta al giorno a Giovanni, il quale avrebbe impiegato il rimanente della giornata a lavorare in campagna per accontentare il fratello Antonio. Ma questi, appena seppe che la madre aveva presa una simile deliberazione, sdegnossi fortemente e solo si acchetò quando venne assicurato che la scuola si sarebbe incominciata dopo l’estate, allorchè i lavori campestri non dánno più gran pensiero.
CAPO XXI.
La scuola di Morialdo – Il chierico Giuseppe Cafasso – Suo abboccamento con Giovanni – Il fratello Antonio proibisce a Giovanni di continuare negli studi.
GIUNSE l’autunno, ma la scuola per Giovanni non era tuttavia incominciata. D. Calosso era impaziente; ed un giorno incontrando il giovanetto: – Sicchè, gli chiese, tua madre non ti mette ancora a studiare?
– Ah! vi sono sempre le difficoltà: mio fratello maggiore non vuole.
– Che? voglia o non voglia egli, lo voglio io che tu intraprenda gli studi. Domani co’ tuoi libri vieni a casa mia: io ti farò scuola.
Giovanni si mise tosto nelle mani di D. Calosso, il quale, come già vedemmo, era solamente da alcuni mesi venuto alla Cappellania di Morialdo, e prese a portargli tanta affezione, che gli fece conoscere tutto se stesso. Da quell’istante incominciò a manifestargli prontamente ogni parola, ogni pensiero, ogni azione. Ciò piacque assai al buon prete, perchè in simile guisa poteva con sicurezza regolarlo nello spirituale e nel temporale. Ecco in qual maniera D. Bosco ricorda il vantaggio provenutogli da questa direzione: “Conobbi allora che voglia dire avere la guida stabile di un fedele amico [182] dell’anima, di cui fino a quel tempo era stato privo. Fra le altre cose mi proibì tosto una penitenza, che io era solito fare, non adattata alla mia età e condizione, mi incoraggiò a frequentare la Confessione e la Comunione, e mi ammaestrò intorno al modo di fare ogni giorno una breve meditazione, o meglio un po’ di lettura spirituale. Nei giorni festivi tutto il tempo che poteva lo passava con lui. Nei giorni feriali, per quanto mi era possibile, andava a servirgli la santa Messa. Da quell’epoca ho incominciato a gustare che cosa sia vita spirituale, giacchè prima agiva piuttosto materialmente e come macchina, che fa una cosa senza saperne la ragione”.
In questi giorni però un doloroso avvenimento riempiva di lutto i Castelnovesi. Il 3 ottobre 1826, in età di 54 anni, moriva il vicario foraneo D. Giuseppe Sismondo. Giovanni dolentissimo si accompagnò al funebre corteggio, che recava alla tomba la salma di colui, che aveagli concesso il dono inestimabile della prima Comunione.
Alla metà di ottobre egli aveva incominciato regolarmente lo studio della grammatica italiana, che in breve potè compiere e praticare con opportune composizioni. A Natale diè mano al Donato. Sul principio trovò qualche difficoltà nelle prime declinazioni e nel primo verbo, ma poi quello studio divenne per lui facilissimo. Leggere era quanto ritenere, perchè ogni cosa restavagli scolpita ed indelebile nella mente: tanto che in un mese apprese il Donato a menadito. A Pasqua cominciò a tradurre qualche proposizione dal latino in italiano e dall’italiano in latino. Il maestro dicevagli scherzando: – Se fai così, non andrà molto tempo che saprai quanto vi è nel mondo da imparare. – E tutte le volte che incontrava mamma Margherita le ripeteva: – Vostro figlio è un portento di memoria. – In tutto quel tempo Giovanni [183] non cessò mai dai soliti trattenimenti festivi, d’inverno nella stalla, d’estate nel prato. Ogni fatto, ogni detto, e direi quasi ogni parola del venerato maestro serviva a trattenere i suoi uditori. Antonio per altro brontolava continuamente.
Margherita si reputava felice nel vedere Giovanni giunto al compimento de’ suoi desideri. Ma le tribolazioni non dovevano mancare. Fino a tanto che durò l’inverno ed i lavori di campagna non richiedevano alcuna premura, Antonio lasciò tempo al fratello di applicarsi alle cose di scuola; ma, venuta la primavera, incominciò a lagnarsi fortemente, dicendo, perchè mai egli solo dovesse logorarsi la vita in pesanti fatiche, mentre Giovanni perdeva il tempo facendo il signorino. Ci furono vive discussioni con Giovanni e colla madre, la quale, per mantenere la pace in famiglia, conchiuse che Giovanni sarebbe andato al mattino per tempo a scuola ed avrebbe impiegato il rimanente del giorno in lavori materiali. Ma come avrebbe potuto studiare le lezioni? Come fare i suoi compiti?
Chi ha volontà risoluta, trova i mezzi per giungere al suo fine. L’andata ed il ritorno dalla scuola porgevagli un po’ di tempo a studiare. Giunto poi a casa, prendeva la zappa da una mano e dall’altra la grammatica e s’avviava al campo: durante la strada continuava a studiare fino al luogo del lavoro. Quivi, dando uno sguardo compassionevole alla grammatica, mettevala sopra una zolla, e si accingeva a zappare, a sarchiare o raccogliere erba cogli altri, secondo il bisogno. L’ora poi in cui tutti solevano fare merenda, egli si ritirava in disparte, e con una mano teneva la pagnottella mangiando e nell’altra il libro studiando. Come nel venire, così faceva ritornando a casa. L’ora del desinare e della cena e qualche furterello al riposo era l’unico tempo che gli rimanesse pe’ suoi doveri in iscritto. [184]
Malgrado tanto lavoro e tanta buona volontà, il fratello Antonio non era soddisfatto e ripeteva che di quella scuola non voleva più saperne: – Che bisogno c’è di tanto latino in casa? Che latino? Lavorare, lavorare! – Mamma Margherita aveva un bel mostrargli che non c’era necessità dell’opera di Giovanni, per tener ben coltivato il proprio podere; e come essa stessa non si risparmiasse in tutto ciò che occorreva per la seminagione, la coltivazione ed i raccolti. Gli prometteva eziandio che avrebbe sacrificato la sua stessa dote per compensarlo di quel meno di lavoro che sembravagli facesse Giovanni. Il fratellastro non si potè risolvere a cedere delle sue pretensioni. Finalmente accadde una scena disgustosa, che così ci è narrata dallo stesso D. Bosco: “Un giorno Antonio con mia madre, e poi con mio fratello Giuseppe, in un tono imperativo disse: – È abbastanza fatto; voglio finirla con questa grammatica. Io sono venuto grande e grosso e non ho mai veduto questi libri. – Io, dominato in quel momento e dall’afflizione e dallo sdegno, risposi quello che non avrei dovuto: – Tu parli male; gli dissi; non sai che il nostro asino è più grosso di te e non andò mai a scuola? Vuoi tu venire simile a lui? – A quelle parole Antonio saltò sulle furie ed io soltanto colle gambe, che mi servivano assai bene, potei fuggire e scapparmene da una pioggia di busse e di scappellotti”.
Ma la gioia dell’intero paese venne a dar sollievo alle angustie private. Il nuovo prevosto D. Bartolomeo Dassano, uomo di gran pietà e dottrina, prendeva possesso di Castelnuovo nel mese di luglio 1827; mentre otto giorni prima un giovane Castelnovese, Giuseppe Cafasso, per le mani dell’economo D. Emanuele Virano aveva indossato la divisa chiericale.
Chi era mai questo giovane che già più volte ci venne e più altre ci verrà di nominare in questo racconto? D. Bosco [185] così lo descrive: “Era un modello di virtù, nato da onesti e agiati contadini nel gennaio 1811. La docilità, l’obbedienza, la ritiratezza, l’amore allo studio e alla pietà di questo giovanetto, aveanlo fatto divenire l’oggetto della compiacenza dei genitori e de’ suoi maestri. In esso era qualità caratteristica un grande amore alla ritiratezza, congiunto ad una propensione quasi irresistibile a fare del bene al prossimo. Egli stimava giorno per lui il più felice quando poteva dare un buon consiglio, quando riusciva a promuovere un bene o ad impedire un male. All’età di dieci anni la faceva già da piccolo apostolo in sua patria. Fu spesso visto uscire di casa, andare in cerca di compagni, di parenti e di amici. Grandi e piccoli, giovani e vecchi, tutti invitavali a venire in casa sua: di poi accennava loro di inginocchiarsi e fare con lui una breve preghiera: poscia montava sopra una sedia, che per lui diveniva un pulpito, e da questa faceva la predica, cioè andava ripetendo le prediche udite in chiesa o raccontando esempi edificanti. Egli era di piccola corporatura, ed il suo corpo era quasi tutto nella voce; perciò ognuno nel rimirare quel volto angelico, quella bocca, da cui uscivano parole e discorsi cotanto superiori all età sua, andava pieno di meraviglia esclamando colle parole proferite da quelli che rimiravano il fanciulletto Giovanni Battista: Chi mai sarà questo fanciullo? Quis putas puer iste erit?”.
La fama della straordinaria bontà di questo giovane si era sparsa in tutte le borgate della parrocchia di Castelnuovo. Giovanni, il quale avea tanto simili a lui le inclinazioni ed i desideri, avrebbe voluto conoscerlo, avvicinarlo, farselo amico; ma varie circostanze sembravano opporgli ostacolo non leggiero. Cafasso da qualche anno era andato a Chieri per gli studi, e la borgata di Morialdo era distante da Castelnuovo. La differenza di età e d’istruzione rendeva più [186] difficile un avvicinamento. La Provvidenza però prendeasi la cura di stringere più tardi fra loro una santa amicizia. Sentiamo come Giovanni stesso narra il suo primo incontro col Cafasso: “Era la seconda domenica di ottobre dell’anno 1827, e gli abitanti di Morialdo festeggiavano la Maternità di Maria Santissima, la solennità principale di quel borgo. Ognuno era in faccende per le cose di casa o di chiesa, mentre altri erano spettatori o prendevano parte a giuochi o a trastulli diversi. Uno solo vidi lungi da ogni spettacolo, ed era un chierico, piccolo nella persona, occhi scintillanti, aria affabile, volto angelico. Egli stava appoggiato alla porta della chiesa, che era stata chiusa per breve ora. Io ne fui come rapito dal suo sembiante, e sebbene toccassi soltanto l’età di dodici anni, tuttavia mosso dal desiderio di parlargli mi avvicinai e gli indirizzai queste parole: – Signor Abate, desiderate di vedere qualche spettacolo della nostra festa? Io vi condurrò di buon grado ove desiderate. – Il chierico fe’ grazioso cenno di avvicinarmi e prese ad interrogarmi sulla età, sullo studio, se fossi stato già promosso alla santa Comunione, con che frequenza andassi a confessarmi, ove andassi al catechismo e simili. Io rimasi come incantato a quelle edificanti maniere di parlare; risposi volentieri ad ogni domanda: di poi quasi per ringraziarlo della sua affabilità, ripetei l’offerta di accompagnarlo a visitare qualche spettacolo o novità. – Mio caro amico, ripigliò il buon chierico, gli spettacoli dei preti sono le funzioni di chiesa; quanto più esse sono devotamente celebrate, tanto più grati ci riescono i nostri spettacoli. Le nostre novità sono le pratiche della religione, che sono sempre nuove e perciò da frequentarsi con assiduità; io attendo solo che si apra la chiesa per poter entrare. – Mi feci animo a continuare il discorso e soggiunsi – È vero quanto mi dite; ma v’è tempo per tutto: tempo di [187] andare in chiesa e tempo per ricrearci. – Il chierico si pose a ridere, e conchiuse con queste memorande parole, che erano come il programma delle azioni di tutta la sua vita: – Colui che abbraccia lo stato ecclesiastico si vende al Signore, e di quanto havvi nel mondo nulla più deve stargli a cuore, se non quello che può tornare a maggior gloria di Dio ed a vantaggio delle anime. – In questo mentre si apersero le porte della chiesa, e il chierico, salutato il suo piccolo interlocutore, entrò. Allora, tutto meravigliato, volli sapere il nome di quel chierico, le cui parole e il cui contegno cotanto manifestavano lo spirito del Signore. Seppi che egli era il chierico Giuseppe Cafasso, studente del 2° anno di filosofia”.
Giovanni tornò a casa come se in quel giorno avesse guadagnato una gran fortuna, e corse dalla madre.
– L’ho visto, gli ho parlato.
– Chi mai?
– Giuseppe Cafasso. È proprio vero che è un santo
– Dunque cerca di imitarlo. Il cuore mi dice che un giorno potrà giovarti molto!
Giovanni narrò allora alla madre il dialogo accaduto tra lui e Cafasso. Margherita era donna capace di comprendere la nobiltà e giustezza di quelle parole e concluse: – Vedi, Giovanni, un chierico che manifesta tali sentimenti, riuscirà un santo prete. Sarà il padre dei poveri, ricondurrà tanti cattivi sulla via del bene, confermerà tanti buoni nella via della virtù, guadagnerà molte anime al cielo. – Tale infatti riuscì Giuseppe Cafasso, e per Giovanni Bosco fu non solo, come vedremo, modello di vita chiericale e sacerdotale, ma eziandio primo ed insigne benefattore.
Intanto sopravvenne l’inverno, e cessati i lavori di campagna, Giovanni intendeva riprendere gli studi presso il [188] suo carissimo D. Calosso, che lo attendeva a Morialdo. Ma potè andarvi per poche settimane, poichè la madre lo consigliò a restarsene in casa. Antonio non aveva cessato di muovergli guerra. – Il signorino vuole studiare! dicevagli. Tu andrai a star comodo, e noi qui a mangiar polenta! Credi tu forse che noi abbiamo voglia di morirci di fame per pagarti la pensione? Te lo darò io lo studio! Lévati dal capo questa pazzia. Non abbiamo bisogno di dottori noi. Va a zappare! – E andava sovente saettandolo con simili rimproveri. Se tal fiata lo incontrava nell’atto di leggere qualche libro, glielo strappava di mano; se tal’ altra vedealo senza parole, concentrato ne’ suoi pensieri: – A che cosa pensi, dicevagli: a’ tuoi sogni forse? Tu devi fare il contadino, come lo faccio io! – E non lo chiamava più con altro nome, fuorchè con quello di studente, dottorino e simili. Giovanni soffriva, talora piangeva e sopportava tutto con pazienza. Ma sopra di lui vegliava quegli al quale Davidde nelle sue afflizioni esclamava: “Alla tua cura è rimesso il povero; aiuto dell’orfano sarai tu”[50].
CAPO XXII.
La virtù messa alla prova – Giovanni è mandato dalla madre a Moncucco – Per due anni è servitore di campagna – Ubbidienza ai padroni, diligenza nel lavoro, frequenza ai Sacramenti, perseveranza nella preghiera, buon esempio a tutti – Giovanni istruisce i fanciulli nelle verità della fede e nelle pratiche di pietà – Asserisce che un giorno sarà sacerdote – Oratorio festivo a Moncucco.
GRANDE era la missione che il Signore voleva affidare a Giovanni Bosco: e però la Madonna aveagli detto: “Renditi umile”; imperocchè Iddio ai superbi resiste e agli umili dà la grazia: “alla gloria va sempre innanzi l’umiltà[51]; la saviezza dell’umile lo innalzerà e lo farà sedere nel consesso de’ magnati”[52].
Sino a questo momento Giovanni dagli uomini, dalla madre, dal curato e dai cappellani di Capriglio e Morialdo aveva ricevute le norme per vivere da cristiano; ora però il Signore vuole chiamarlo alla stessa sua scuola per renderlo santo. E in che modo? “Da principio lo prova, al dir della Sapienza: manda sopra di lui timori e paure per esercitarlo, e lo affligge colla sferza di sua dottrina, fino a tanto che abbia [190] fatto sperimento de’ suoi pensieri, onde potersi fidare del cuore di lui. Poi gli darà fermo stato e appianerà a lui la strada e darágli allegrezza. E svelerà a lui i suoi arcani e lo arricchirà di un tesoro di scienza e di cognizione della giustizia”[53].
Giovanni aveva mente e cuore grande: era obbediente per virtù, ma non sottomesso per inclinazione. In casa propria il più povero del mondo si sente padrone, come un re nel suo regno. E Dio farà con lui come fece con Mosè, il quale, principe nella reggia d’Egitto, costretto a fuggire presso Jetro nel deserto del Sinai, ridotto a custodire un gregge, divenne il più mansueto di quanti uomini vivevano sopra la terra. Giovanni pure sarà preparato da Dio con un lungo esercizio di umiltà eroica; dovrà uscire dalla propria casa e ridursi a fare il servitore in casa altrui per circa due anni: ed egli era tale da sentire tutto il peso di questa umiliazione. Desiderava egli ardentemente lo studio; e per quattro anni non solo si vedrà chiusa ogni via, ma quando gli sorriderà qualche speranza, questa gli verrà bruscamente tolta per inaspettati avvenimenti. Che cosa sarà di lui? Ecco i timori e le paure! Come acquisterà la scienza, secondo il comando ricevuto da Gesù Cristo nel sogno? “Questa, come si legge nell’Ecclesiastico[54], si acquista nel tempo di libertà dagli affari, e il contadino e gli artigiani, benchè siano necessari alla costruzione di una città, pure non entreranno nelle adunanze dei sacerdoti e dei dottori della legge, non si assideranno tra i giudici, non intenderanno le leggi giudiziali, non insegneranno le regole della vita e della giustizia, [191] e non si metteranno ad esporre parabole. Eppure, contro ogni previsione umana, questa era proprio la via che Giovanni doveva battere per addestrarsi alla sua futura molteplice missione.
Margherita, vedendo che le opposizioni di Antonio divenivano sempre più continue ed insistenti, risolse di mandare per qualche tempo chi era causa innocente di quella scissura presso alcune sue persone conoscenti; e se in casa di costoro non avesse trovato accoglienza, designava il suo rifugio alla Moglia di Moncucco, regione distante due miglia da Chieri.
Questa masseria apparteneva a certi signori Moglia, i quali non conoscevano mamma Margherita se non per fama. I Moglia erano ricchi, i Bosco invece poveri. Incoraggiata tuttavia Margherita dallo spirito cristiano, che informava tutti i personaggi di quella casa, e dall’essere la padrona della famiglia dei Filippelli di Castelnuovo, non esitò. Chiamato Giovanni, gli diede le istruzioni necessarie con quello stesso affetto, col quale Rebecca congedava Giacobbe sul punto di partire per la Caldea. Margherita inviò il figlio senz’altra raccomandazione che quella di affidarlo al suo angiolo custode.
Era il mese di febbraio del 1828. Giovanni si allontanava dalla casa materna con un involto sotto il braccio, contenente alcune camicie e qualche libro di religione, che gli aveva donato D. Calosso. L’aria fredda, il suolo coperto di neve accresceva la mestizia de’ suoi pensieri. Da casa sua più nulla poteva sperare per l’ostinazione del fratellastro, il quale avea proibito a Margherita di spedirgli cosa alcuna. Bisognava che andasse in cerca di lavoro per procacciarsi il vitto col sudore della sua fronte, senza più avere il conforto di vedersi vicina la madre che amava svisceratamente. [192]
Pare che egli già avesse prima volto il passo alla borgata Serra in quel di Buttigliera d’Asti, e che ivi sia stato accolto ed ospitato con molta cordialità dagli amici di sua madre; ma che poi, accortosi come fosse di peso, non essendo quella una stagione da poter recare qualche utile colle sue fatiche, abbia fatto ritorno a Morialdo. Comunque sia, egli ora s’avviò al paese di Morialdo, ove abitava altra famiglia di conoscenti. Qui eziandio egli supplicò per avere un posto nel quale guadagnarsi il pane; ma inutilmente. Udirono le strettezze, nelle quali si trovava, compatirono le sue peripezie, che lo costringevano a cercarsi un ricovero, e lo congedarono.
Non gli restava altra speranza che la Moglia. Vi giunse in sul far della sera. Il suo primo incontro fu collo zio paterno del padrone, per nome Giuseppe Moglia, il quale lo interpellò: – Oh! dove vai?,
– Vado cercando un padrone, affine di prestargli l’opera mia! rispose Giovanni.
– Bravo! lavora! addio! – replicò Giuseppe in atto di licenziarlo. Giovanni rimase alcuni istanti confuso, perplesso; e poi fattosi animo si avanzò nell’aia, ove trovavasi tutta la famiglia Moglia, intenta a preparare i vimini necessari per le vigne. Ed il padrone appena lo vide: – Chi cerchi, ragazzo? gli chiese.
– Cerco Luigi Moglia.
– Son io, e che cosa desideri?
– Mia madre mi disse che venissi con voi a fare il vaccaro.
– Chi è tua madre? E perchè ti manda via da casa piccolo come sei?
– Mia madre si chiama Margherita Bosco: vedendo essa che mio fratello Antonio mi maltratta e batte sempre, ieri mi disse: Prenditi queste due camicie e questi due moccichini, [193] va al Bausone (borgata vicino a Chieri), e chiama qualche posto da servo; se non ne trovi, va alla cascina Moglia posta tra Mombello e Moncucco: là chiamerai del padrone, e gli dirai che sono io tua madre che ti mando, e spero che ti accoglierà.
– Povero ragazzo, rispose il Moglia; io non posso prenderti al mio servizio; siamo d’inverno, e chi ha vaccari in casa, li licenzia; non siamo soliti a prenderne fino a che sia passata la festa della SS. Annunziata. Abbi pazienza e ritorna a casa tua.
– Accettatemi per carità, esclamò il giovanetto Bosco. Non datemi paga alcuna, ma tenetemi con voi.
– Ma non ti voglio in casa mia; sarai capace a far nulla!
Il giovanetto ruppe in pianto e: – Prendetemi, continuava a dire, prendetemi. Io mi seggo qui per terra e non mi muoverò più… No, non vado via! – E così dicendo, si mise a raccogliere cogli altri i vimini sparsi per l’aia. La signora Dorotea Moglia, commossa a quelle lagrime, persuase il marito a tenere in casa almeno per pochi giorni quel povero fanciullo, e Luigi non resistè alle preghiere della brava sua donna.
Allora una sorella del padrone, di nome Teresa, di quindici anni, che mai volentieri adempieva l’ufficio affidatole di governare l’armento, disse loro: – Ponete a custodia delle vacche e dei buoi questo fanciullo; io ho gli anni e la robustezza per lavorare la campagna e lavorerò con voi e quanto voi. – I parenti accondiscesero. Giovanni diè subito mano con zelo a quei lavori, che in campagna sono propri di un servitore, e a tenere in ordine la stalla.
Benchè egli più tardi accennasse sovente al tempo che passò alla Moglia e dicesse essere stata questa l’epoca più [194] bella e più romantica della sua vita, nella quale tutto solo era andato pel mondo in cerca di fortuna, tuttavia si rifiutò di dirne d’avvantaggio a chi ne lo interrogava, e nelle sue memorie nulla lasciò scritto di questa sua dimora. E questo fu il tempo, nel quale egli si esercitò nelle più sode virtù, appoggiate alla santa umiltà. Una volta sola fu udito esclamare: – Fin d’allora, appena aperti gli occhi al mattino, incominciava subito qualche cosa e questo qualche cosa lo continuava fino all’ora di andare a dormire. – Ma se egli tacque, a suo tempo parlarono i coniugi Moglia, i loro figliuoli, i vicini, il parroco di Moncucco, D. Francesco Martina, successore di D. Cottino, dai quali abbiamo le notizie che stiamo per riferire. In Giovanni si avverò appieno il detto dei Proverbi: “Chi custodisce il suo padrone, servendolo con amore e con diligenza, sarà onorato”[55].
I padroni, vedendo l’obbedienza esatta di Giovanni ai loro comandi, la sua spigliatezza e perseveranza nel lavoro, la sua modestia e spirito di preghiera, si accorsero quale tesoro possedessero, ed ogni giorno più s’innamoravano di lui e delle sue virtù. Perciò una settimana dopo che egli era entrato in servizio, il padrone lo mandò ai Becchi, perchè invitasse mamma Margherita a recarsi a Castelnuovo nel prossimo giovedì, ove esso sarebbesi trasferito, per trattare con lei del salario da darsi a Giovanni. La madre si affrettò alla Borgata della Moglia, per dire al signor Luigi essergli dessa troppo riconoscente per aver accolto il figliuol suo e nulla pretendere di salario. Ma il padrone volle convenire che Giovanni, oltre al vitto necessario, avrebbe toccata la paga di 15 lire annue per le vestimenta. Si noti che in quel tempo [195] tale mercede era piuttosto generosa per un vaccaro di quattordici anni. Da questo momento Giovanni fu membro di quella caritatevole famiglia.
Fin dal principio incominciò ad essere di grande edificazione a tutti per la sua inappuntabile condotta. Nelle prime settimane, inginocchiato presso il suo letticciuolo o in un angolo della stalla, labbreggiava per lunga ora le sue preci del mattino e della sera. Ma la signora Dorotea, che non vista avea più volte osservato la sua compostezza nella preghiera, edificata dalla sua schietta pietà, dopo avergli insegnato le invocazioni delle Litanie della Madonna che recitava con qualche errore, lo incaricò di guidare ogni sera le orazioni di tutta la famiglia radunata dinanzi ad un’immagine di Maria SS, che ancora al presente si conserva religiosamente in quella casa. Col santo Rosario si finivano le operose giornate, e da quello si prendeva incitamento e grazia celeste per l’adempimento esatto dei doveri del proprio stato.
Alla sera di ogni sabato, Giovanni si presentava ai padroni chiedendo licenza di andare all’indomani a Moncucco, per ascoltare la prima Messa che ivi celebravasi assai di buon’ora. Non conoscendo essi il motivo di questa sua gita così mattutina, mentre più tardi non mancava mai alla Messa parrocchiale e a tutte le altre funzioni, una domenica la Dorotea Moglia volle coi propri occhi osservare che cosa andasse a fare a Moncucco il suo servitorello. Essa giunse prima di lui, e si appostò in modo da poter spiare tutti i suoi passi E lo vide che, entrato in chiesa tutto raccolto in sè, si portò al confessionale del parroco, che allora era il teol. Francesco Cottino, si confessò, fece la Comunione, ascoltò la santa Messa e quindi se ne tornò tutto allegro a casa. Quivi la padrona, che avevalo preceduto, interrogollo se il motivo, pel quale voleva sempre andare alla prima Messa, fosse quello di accostarsi [196] ai Sacramenti; ma vedendolo turbarsi alquanto, quasi gli rincrescesse di essere stato scoperto, e non volendolo importunare di più, senza lasciargli tempo di soggiungere parola, gli disse: – Sia adunque inteso; d’ora innanzi hai sempre licenza d’andare alla prima Messa. – Giovanni non mancò mai di giovarsi di questa licenza e di accostarsi alla Mensa Eucaristica ogni domenica e in tutte le altre feste dell’anno. A quei tempi non era troppo in uso la Comunione frequente e settimanale, e di più dalla cascina Moglia a Moncucco ci vuole un’ora di cammino e in mezzo ad oscuri sentieri.
Questo amore a Gesù Sacramentato era un segno del suo spirito di preghiera. Soventi volte infatti fu sorpreso in casa e fuori assorto nell’orazione. Un giorno pascolava le vacche poco distante dalla cascina. Ad un tratto la padrona Dorotea Moglia, col cognato Giovanni Moglia, lo videro nel mezzo del prato giacente immobile e che appariva per le ondulazioni del suolo come disteso per terra. Credendo dormisse al sole, lo chiamarono per nome; ma, accortisi che non si muoveva, Giovanni Moglia s’incamminò per andargli vicino, continuando a chiamarlo di tratto in tratto ad alta voce. Bosco non rispondeva. Arrivato a breve distanza, vide che il giovanetto era inginocchiato e che teneva un libro penzoloni fra le mani: gli occhi aveva chiusi: la faccia teneva rivolta al cielo e con tale grazia da far stupire l’osservatore. Giovanni Moglia lo toccò leggermente sovra la spalla e gli disse: – Perchè dormi così al sole? – Bosco si scosse e rispose: – No, no; io non dormiva. – E così dicendo si alzò tutto confuso per essere stato scoperto nell’atto di meditare.
Il giovinetto non dimenticava mai di farsi il segno della croce avanti e dopo il cibo, e questa usanza coll’aggiunta di una breve orazione l’introdusse in quella generosa famiglia, la quale, prima che egli venisse, trascurava talvolta questa [197] pia pratica: d’inverno non la si tralasciava mai, non così però d’estate, quando si era stanchi dal lavoro. Curò allo stesso modo che fosse recitata tre volte al giorno la salutazione dell’Angelo al suonare della campana. Un giorno d’estate, il vecchio Giuseppe tornava a casa tutto sudato e colla zappa sulle spalle. Erano le 12 ore; suonava in lontananza la campana, ma egli non pensava a dire l’Angelus, chè, oppresso dalla stanchezza, gettatosi a sdraio, riposava. Quand’ecco vide in cima ad una scala il giovinetto Bosco, rientrato poco prima, che in ginocchio recitava l’Angelus, e ridendo esclamò: – Guarda là: noi che siamo i padroni, dobbiam logorarci la vita dal mattino alla sera e non ne possiamo più, e lui tutto tranquillo sta lassù pregando in santa pace. È così che si fanno i meriti pel paradiso con tutta facilità! – Bosco finì la sua prece, scese la scala e rivolto al vecchio: – Sentite, gli disse, voi siete testimonio che io non mi sono risparmiato sul lavoro: è certo però che io ho più guadagnato a pregare che voi a lavorare. Se pregate, da due grani che voi seminate ne nasceranno quattro spighe; se non pregate, seminando quattro grani raccoglierete due sole spighe. Pregate adunque anche voi, e invece di due spighe ne raccoglierete voi pure quattro. Che cosa vi costava fermarvi un istante, deporre la zappa e dire la preghiera? E così avreste acquistato lo stesso merito che acquisto io. – Quel bravo uomo oltremodo meravigliato esclamò: – Oh poffarbacco! che io abbia da prender lezione da un giovanetto? Eppure io sento di non poter più mettermi a tavola, se prima non dico l’Angelus. – E d’allora in poi non dimenticò più questa preghiera. Il rispetto, l’amore, l’affabilità di maniere, colle quali Giovanni trattava quelli che erano per lui i rappresentanti di sua madre, rendevano loro gradite tutte le sue osservazioni. Spesso nasceva qualche [198] disparere di vario genere tra lui ed i vecchi; si veniva a tranquilla discussione; e Bosco, rispondendo con calma, finiva sempre per aver ragione. E i suoi ospiti e i loro amici andavano ripetendo: – Si vede che questo fanciullo è destinato ad insegnare agli altri, eziandio ai vecchi!
Affermavano i signori Moglia che giammai videro in lui la menoma mancanza puerile, di che grandemente si meravigliavano: non una delle tante ragazzate solite a farsi da’ suoi coetanei: non un urtone ai compagni, non una parola irosa o di scherno: non impadronirsi di frutta, anche in piccola quantità: non il minimo sguardo e gesto che potesse anche dai più critici essere giudicato meno riguardoso: il suo contegno era quello di un uomo maturo e assennato. – Egli era diverso dagli altri fanciulli e insegnava a noi! – asserivano quelli che abitavano allora in quella borgata.
Tuttavia nei primi tempi non era mancata a lui la puntura di qualche lingua maldicente, quando condotto l’armento ai pascoli, per stare più vicino ad esso, o per difendersi dai raggi del sole in mezzo al prato, inginocchiavasi accanto alle vacche. Alcuni contadini, vedendolo in quella postura, credettero mungesse le vacche per berne il latte, come costumano fare i servitori ghiottoni ed infedeli; e però lo accusarono di furto presso i padroni, i quali, essendo persone prudenti, vollero assicurarsi più volte coi propri occhi e lo sorpresero sempre nell’atto di leggere il suo catechismo. Del continuo egli studiava questo prezioso libretto, benchè già fosse molto istrutto nella dottrina cristiana, ed alternavane la lettura con qualche preghiera.
Essendo così pieno dello spirito di Dio, si può argomentare con quanto abborrimento fuggisse non solo ciò che potesse appannare il candore della sua anima, ma eziandio quanto solamente sembrasse sconveniente ad un giovanetto. Dorotea [199] Moglia affermava che Bosco custodiva volontieri un suo bambino di tre anni, chiamato Giorgio, il quale eragli continuamente ai panni sia in campagna sia in casa; e che non si stancava di udirne i fanciulleschi discorsi e d’interessarsi con ogni amorevolezza dei fatti di quel bambolo. Ma, invitato più volte dalla medesima a governare eziandio una sua bambina di cinque anni, in bel modo le rispondeva: – Datemi dei ragazzi, e ne governo fin che volete, anche dieci; ma bambine non debbo governarne. – E questa fu l’unica volta che parve schermirsi dall’obbedienza. Tuttavia la padrona deponeva talvolta la figlietta sopra una zolla e si ritirava per andare altrove, costringendolo così a quella custodia; ma egli, appena supponeva di non essere visto, si allontanava ad una certa distanza. E ritornando la Dorotea e sgridandolo: – Ah, birichino! E perchè non vuoi? – Io non sono destinato a questo! – rispondeva pacatamente Giovanni.
Alla Moglia egli continuò lo stesso tenore di vita incominciato ai Becchi. Colle sue belle maniere e co’ suoi giuochi, incominciò ad attirare a sè i pochi fanciulli della borgata, i quali gli divennero tosto amicissimi. Nell’inverno, quando non si poteva lavorare in campagna, nelle giornate piovose, ogni domenica e festa, alla sera li radunava tutti. Salivano sul fienile, si ordinavano in semicerchio, e Giovanni, seduto sopra un mucchio di fieno più alto, loro faceva il catechismo, e ripeteva le cose udite dal pulpito della chiesa parrocchiale, raccontava qualche buon esempio, insegnava il modo di recitare il Rosario, le Litanie della Madonna e il canto di qualche laude sacra: comunicava insomma a’ suoi compagni quanto egli sapeva. Interrogato dalla padrona perchè scegliesse quel luogo per le sue conferenze rispondeva: – Non ci disturbate, noi non vi disturbiamo! – Non voleva però in nessun modo che intervenissero le ragazze. Nella bella [200] stagione e nelle giornate serene si raccoglievano tutti all’ombra di un gelso. E le madri di famiglia si dicevano fortunate di poter affidare a lui i propri fanciulli, sia quando erano costrette ad allontanarsi da casa, sia quando non potevano accompagnarli alla parrocchia. Egli accondiscendeva volonterosamente a questo invito, e prodigava a’ suoi protetti tutti i segni di benevolenza con carezze e piccoli regalucci, appropriati alla loro tenera età, mostrandosi grandemente alieno dal fare simili doni alle fanciulle.
Viva intanto continuava ad arderlo la sete di studiare e non poteva estinguerla. Ovunque andasse, portava sempre seco un fascio di libri che trattavano di religione e la grammatica datagli da D. Calosso. In casa, ogni momento libero dalle occupazioni riprendeva senza indugio la lettura. Quando precedeva l’aratro, colla destra stringeva la corda dei buoi aggiogati e colla sinistra teneva un libro aperto, dando di quando in quando un’occhiata a quelle pagine. Un giorno il padrone lo interrogò perchè amasse tanto i libri: – Perchè io debbo essere prete! rispose Giovanni.
– Tu prete!? gli dicevano allora quei di casa a questa sua affermazione spesse volte ripetuta. E non sai tu che per studiare ci vogliono nove o dieci mila lire? E dove le prenderai? Eh! là, replicavano mettendogli le mani sulle spalle e scuotendolo carezzevolmente, se non sarai Don Bosco, sarai Don Bocc!
– Vedrete! replicava Giovanni.
Anna Moglia, altra sorella del signor Luigi, in sui diciotto anni, scorgendolo sempre fisso in questo pensiero, più volte gli disse: – Ma tu sei povero, come vuoi fare a dedicarti agli studi senza danari?
– La povertà non mi mette in angustie, rispondeva tosto Giovanni, perchè vi saranno persone che pagheranno per [201] me! – E ammirabile questa sua fortezza d’animo in mezzo a tanti ostacoli, e la sua speranza contro ogni umana speranza.
Tuttavia i suoi buoni padroni, benchè giudicassero ineffettuabile la sua aspirazione, in nessun modo lo contrariarono. Il signor Luigi un giorno gli disse: – Studia tanto che basti, purchè tu sia soddisfatto. – E quando non erano necessari i suoi servizi, per questo fine lo dispensava dal lavoro; Giovanni lo ringraziava, e per essere più tranquillo ritiravasi sul fienile. Lo zio Giovanni un giorno, mentre era fra i solchi che arava: – Sia inteso, disse al giovane all’improvviso e spontaneamente, quando non avrò stretto bisogno che tu guidi i buoi, ti ritirerai a studiare all’ombra. – Con tutto ciò Giovanni non poteva e non voleva abusare della bontà dei padroni, essendo d’urgenza molti lavori e stando egli ai dettami del dovere del suo stato e di una fine prudenza, colla quale regolava tutte le sue azioni. D’altra parte, senza una guida come poteva proseguire con sicurezza negli studi?
Una speranza gli brillò in quel frattempo. Nel mese di settembre, venne ad abitare in quella cascina il sacerdote Moglia, zio del signor Luigi, fratello di Giuseppe e maestro comunale, il quale, osservata con vivo interesse la condotta del giovanetto servitore, si profferse di fargli scuola per un’ora al giorno. Giovanni gliene fu riconoscente; tuttavia potè fare poco profitto, perchè il buon prete passava in quella borgata solo alcun tempo delle vacanze autunnali, precisamente la stagione in cui più fervono i lavori per le vendemmie e per le seminagioni. E fu questa un’altra disillusione Ciò però non impediva che egli tenesse sempre fisso lo sguardo alla sua vocazione. E come in questa estate, lo dimostrò eziandio nel nuovo anno 1829.
Quanto più cresceva in età, veniva a conoscere sempre meglio il bisogno di curare i fanciulli, e si faceva sentire in lui [202] sempre più vivo il desiderio di occuparsi di essi. Dovendo alla domenica recarsi alla parrocchia di Moncucco per assistere alle funzioni religiose, non tardò ad avere attorno a sè tutta la gioventù, e non solo quella della campagna, ma eziandio quella che si dava agli studi. Il parroco teologo Cottino, uomo dottissimo e zelantissimo, fin dai primi giorni che s’incontrò con Giovanni, vide splendere in lui una divozione sincera, speciale; conobbe il buono spirito che animavalo e il bene che potevasi fare ai giovanetti per mezzo di ricreazioni ed istruzioni; quindi non solo lo appoggiò il meglio che seppe, ma quando il pastorello dovette trasferirsi altrove, egli stesso continuò per molti anni quelle prime radunanze da lui iniziate e mutate poi in vero Oratorio festivo.
Intanto Giovanni, avendo fatte molte insistenze per poter avere la sala della scuola comunale a sua disposizione nelle domeniche, riuscì nel suo intento. Quivi nei giorni festivi, presiedendo il povero servitorello di campagna, si radunavano i giovanetti del paese e si incominciavano i trattenimenti colla lettura di un libro di divozione. Ma ciò non era tutto. Dopo la Messa grande, tutti i giovanetti si fermavano nella chiesa parrocchiale e facevano solennemente la Via Crucis, cantando i versetti e le strofe dello Stabat Mater. Il parroco era commosso fino alle lagrime, nel vedere tanta pietà rifiorire nella parte più eletta delle sue pecorelle. Gli adulti eziandio erano attirati in chiesa dalla novità della cosa, e il buon esempio produceva i suoi frutti. Giovanni passava in Moncucco tutti interi i giorni di festa, e alla sera, circondato dai ragazzi della sua borgata, tornava a casa dai padroni cantando allegramente per via.
Al teologo Cottino, attento osservatore di ogni passo e di ogni parola di Giovanni, non potè rimanere ascoso l’ingegno la memoria, il discernimento di questo giovanetto, e quindi [203] l’attitudine a riuscire nelle lettere. Avendolo talora in casa a famigliare colloquio e conoscendone ogni più segreto pensiero, si disse pronto, se fosse stato possibile, ad insegnargli le regole della sintassi latina. Dietro sue vive istanze e proteste di essere pronto a lasciar volontieri il suo piccolo salario, i padroni gli concessero licenza di andare qualche volta alla casa parrocchiale in quelle ore, nelle quali meno urgevano i lavori. I giorni però di scuola dovettero essere ben rari. La distanza era di oltre un miglio, e come poteva assentarsi dalla Moglia per più di tre ore, senza che ne scapitassero i doveri del suo stato? E in quali ore e con quale calma avrebbe potuto occuparsi regolarmente dei compiti in iscritto e delle lezioni da mandare a memoria?
Era un altro tentativo fallito per la riuscita negli studi ma non era tempo perduto, perchè così il Signore andava disponendo le cose in modo da potersi poi dire di lui: “Ma la Sapienza condusse per istrade diritte il giusto che fuggiva dall’ira di suo fratello, e gli diede a vedere il regno di Dio, e delle cose sante gli diede la scienza; lo arricchì negli affanni e ampia mercede rendette alle sue fatiche”[56].
Intanto in questo stesso anno 1829 avvenimenti solenni avevano prestato certamente singolar fomento alla sua pietà. Il 10 febbraio moriva Leone XII in età di 68 anni compiuti, e il 31 marzo gli succedeva nel Soglio Pontificio Pio VIII, il quale concedeva a tutti i fedeli un nuovo giubileo; e il 20 giugno in Torino s’incoronava l’immagine di Maria SS. e del suo Celeste Bambino con due auree corone nel santuario della Consolata. Pochi mesi prima, il 13 aprile, per l’ammirabile costanza di O’ Connel, dopo circa trecento anni di [204] spaventosa persecuzione, si proclamava dal parlamento inglese l’emancipazione dei cattolici, i quali si potevano ben paragonare ai cristiani di Roma, quando uscirono dalle catacombe per il decreto di Costantino. Il Papa! Maria Santissima! la Fede! Avrà pensato allora Giovanni che nella sua biografia sarebbe stato scritto un capitolo intitolato “D. Bosco e l’Inghilterra”?
CAPO XXIII.
Giovanni ritorna ai Becchi – Care memorie che lascia di sè alla Moglia Nuovi tentativi infruttuosi per ripigliare gli studi – Vita edificante in mezzo ai compagni – Le madri lo propongono come modello di virtù ai loro figliuoli.
DA QUASI due anni Giovanni si trovava alla Moglia. La più viva riconoscenza legavalo a quella onorevole famiglia. Il signor Luigi, in segno della propria soddisfazione, aveva donato 30 lire a Margherita sul finire del 1828 e 50 nell’autunno del 1829. Si era verso il fine del mese di dicembre, quando un giorno, verso le ore otto del mattino, passò di là il fratello di mamma Margherita, Michele Occhiena, che andava al mercato di Chieri, e vedendo il nipote che spingeva l’armento fuori della stalla: – Ebbene, Giovanni, gli chiese, sei contento?
– Non posso essere contento, perchè mi continua vivo il desiderio di studiare; vedo che gli anni passano e sono sempre allo stesso punto.
– Là, poveretto; sta allegro, lascia fare a me, ci penserò io; conduci la mandra ai loro padroni, e poi ritorna presso tua madre e dille che fra poco passerò a parlarle.
– Ma, mia madre mi sgriderà, se mi vede tornare a casa.
– Fa come ti dico io: sta tranquillo, aggiusterò tutto, fidati di tuo zio. Ora vado al mercato, e ritornando andrò a [206] parlare con tua madre, e vedrai che il tuo desiderio sarà soddisfatto. Se fa di bisogno, per mandarti a scuola, ci metterò del mio. Sei contento? Giovanni obbedì. Fecero le meraviglie i padroni nel vedersi così presto ricondurre a casa le vacche; ma accettarono le scuse e lo lasciarono andare, augurandogli che, secondo il suo desiderio, riuscisse prete. Giovanni si allontanava profondamente commosso da quella cascina così ospitale. Di quando in quando volgevasi indietro per salutare i suoi amici e benefattori, i quali sulla porta della loro abitazione lo osservavano cogli sguardi lagrimosi. Quanto era da essi amato non si può dire a parole! Finchè vissero, lo tennero sempre in conto di figlio, e mai non cessarono di far di lui onorevolissima menzione, manifestando in mille modi l’alta stima che ne avevano e ringraziando Iddio di averlo loro concesso per tanto tempo. Sentirono un gran vuoto intorno a sè per la sua dipartita, ma le durature memorie ch’egli lasciava in quei luoghi erano per essi di soave conforto.
Giovanni Moglia nel 1828 lo aveva condotto seco a piantare quattro filari di viti novelle. Bosco legava con vimini, vicino a terra, uno di questi filari. Stanco del faticoso lavoro, incominciò a dire come si sentisse male alle ginocchia ed alla schiena. – Va avanti, gli rispose lo zio Moglia; se non vuoi aver male alla schiena quando sarai vecchio, bisogna che sopporti questo incomodo adesso che sei giovane. – Bosco continuò a lavorare, e dopo qualche istante, esclamò: – Ebbene; queste viti ch’io ora lego faranno l’uva più bella, daranno miglior vino e in maggior quantità e dureranno più delle altre. – Avvenne infatti come aveva predetto: quel filare produceva ogni anno frutto doppio degli altri di quella regione, che coll’andar del tempo perirono e più volte furono [207] rinnovati, mentre le viti legate da Giovanni prosperarono con ammirazione di tutti fino al 1890. Di questo fenomeno Don Bosco conservava sempre cara ricordanza nella sua tarda età, e ogni qualvolta Giorgio Moglia o suo figlio Giovanni venivano all’Oratorio, dimandava notizia di quella vigna e manifestava desiderio di aver di quell’uva.
La figlia Anna, passata in matrimonio con certo Giuseppe Zucca della Borgata Bausone di Moriondo Torinese, parlando di Giovanni Bosco, raccontava con soddisfazione e compiacenza ai vicini, ai conoscenti ed in famiglia ai propri figli, come egli per due anni in sua casa paterna menasse una vita da angelo e da apostolo: che sovente si ritirava in luoghi solitari a leggere, studiare e pregare: e che non solo ai giovanetti della borgata, ma eziandio alle persone della famiglia esponeva il catechismo e narrava fatti edificanti e con tali maniere, da farsi ascoltare con avidità e vivo piacere. Affermava ancora che sovente, trovandosi insieme con lui nei lavori della campagna, egli più volte con tono profetico e con serietà le aveva detto: – Io sarò prete, ed in allora sì che voglio predicare e confessare. – La ragazza nell’udir queste parole, mettevale in derisione e disprezzava il buon Giovannino con dirgli che con queste sue idee e col continuo suo leggere avrebbe finito per riuscire a nulla. E Giovanni una volta fra le altre le diede questa risposta. – Voi che parlate così e sempre mi schernite, sappiate che un giorno verrete a confessarvi da me. – E così fu. Divenuto infatti Giovanni sacerdote e Fondatore dell’Oratorio, la buona Anna, condotta da circostanze allora imprevedibili, partiva sovente dalla borgata Bausone e si portava all’Oratorio in Torino per visitare D. Bosco, confessarsi da lui nella piccola chiesa di S. Francesco e quivi fare le sue devozioni. E D. Bosco l’accoglieva [208] sempre quale sorella e persona di casa. Queste cose riferiva il Rev. D. Giuseppe Mellica, Beneficiato in Buttigliera d’Asti, il quale aveale udite dal figlio e dalla figlia della sullodata signora Anna.
Ma un ricordo ancor più splendido lasciava Giovanni alla Moglia: quello del buon esempio. La signora Dorotea, per esortare suo figlio Giorgio già grandicello ad accostarsi ai Sacramenti, gli rammentava continuamente la pietà insigne di Giovanni. Avendo un giorno un giovanetto nominato con poco rispetto il nome di Dio, narra Giorgio Moglia, sua madre lo castigò, e raccomandandogli di non più mancare in tal modo nell’avvenire: – Dipòrtati, gli diceva, come si diportava Giovanni Bosco, che, rispettoso verso Dio e verso i suoi superiori, pregava molto di cuore e si raccomandava sempre al Signore prima di andare a riposo. – E ad ogni tratto glielo proponeva a modello. E così facevano le altre madri coi loro figliuoli.
Fortunati quei giovani, la cui vita è in benedizione nei luoghi da essi abitati!
Giovanni, nel suo lungo tragitto dalla Moglia ai Becchi, pensava che finalmente gli sarebbe aperta la strada, che doveva condurlo al compimento della sua vocazione. Ei non si era ancora accorto di quanto già per essa fosse inoltrato. Iddio lo aveva prima addestrato alla palestra degli Oratori festivi, e poi gli aveva fatto percorrere i varii stadi della condizione di contadino, ortolano, pastore, vignaiuolo, agricoltore; di qui doveva accendersi il suo amore per le Colonie agricole. Siano dunque benedette le ammirabili disposizioni dell’amabilissima Provvidenza divina!
Pieno di gioia compariva adunque sulla soglia della casetta paterna. Senonchè la madre, appena l’ebbe veduto, prese tosto a rimproverarlo di aver abbandonata la Moglia: [209] non volle udir ragioni, e gli comandò di ritornare donde era venuto per continuarvi la prestazione dell’opera sua. Giovanni, sorpreso e confuso, rimase un istante perplesso: ma parendogli di leggere in volto alla madre un nascosto pensiero, senza lagnarsi, uscì di casa e andò a celarsi in un fosso, dietro ad una siepe, aspettando l’arrivo dello zio. Margherita aveva fatto il viso brusco per non dar pretesto ad Antonio di crederla complice in quel ritorno. Essa aveva due fratelli. Michele era abbastanza istruito; benchè coltivasse la terra, sapeva alquanto di latino: l’altro, di nome Francesco, era eziandio uomo di senno e sapeva farsi rispettare. Di ambedue si era Giovanni guadagnato la simpatia. L’intromissione loro negli affari della famiglia Bosco era indizio certo che Giovanni aveva acquistati due protettori.
Michele, ritornato da Chieri, fu di parola e passò a visitare la sorella. Antonio mantenne un prudente silenzio. Giovanni, che tenevasi ancora nascosto, fu chiamato, ed ogni difficoltà parve felicemente dissipata. Così raccontò il signor Gamba di Buttigliera, che, giovanetto in quei giorni, era andato co’ suoi parenti ai Becchi e che poi fu ammaestrato da Giovanni nei primi rudimenti del leggere e dello scrivere. Michele si recò subito con Margherita dal parroco di Castelnuovo, D. Bartolomeo Dassano, e lo supplicò di voler fare scuola a Giovanni due o tre volte per settimana. Ma D. Dassano rispose che non poteva accontentarlo pel molto da fare che gli dava la parrocchia. Teneva, è vero, con sè due viceparroci, ma anch’essi, diceva, erano sovraccarichi di lavoro, ed egli non osava dar loro simile incombenza. Lo consigliò pertanto a recarsi a Buttigliera d’Asti dal prevosto di quella chiesa, che forse l’avrebbe esaudito: andò Michele, ma ne ebbe lo stesso rifiuto per le medesime ragioni. Non si sa perchè Margherita non abbia fin dalle prime supplicato [210] il caro D. Calosso ad incaricarsi nuovamente dell’istruzione del figlio. Forse non aveva intieramente dismessa l’idea di tenerlo lontano da casa; forse gli acciacchi della vecchiaia avevano allora obbligato il buon prete a tener il letto; o forse anche era stato costretto da affari urgenti ad allontanarsi dalla sua cappella ed avea incaricato qualche altro sacerdote di supplirlo nelle proprie funzioni. Comunque sia andata la cosa, il fatto è che per qualche tempo ancora Giovanni non potè studiare e si diede ad aiutare la famiglia nei lavori del campo e dell’orto.
Egli intanto continuava costante a frequentare le pratiche di pietà, malgrado la non poca distanza dalla cappella della borgata, edificando tutti col suo buon esempio. Alla domenica, si recava volentieri alla parrocchia, come aveva già fatto negli anni antecedenti, per udire la santa Messa, la spiegazione del Vangelo, la predica e la istruzione ed assistere a tutti gli esercizi spirituali, anche straordinari che vi si facevano. Narra Giovanni Filippello che andava con lui al catechismo: “Il parroco D. Dassano ci interrogava, ed io e i miei compagni sapevamo poco, mentre invece il giovane Bosco sapeva molto. Per il che il parroco ci diceva: – Voi sapete ben poco del catechismo; ma Bosco non solo sa recitare il catechismo, ma lo canta”. – Lo stesso Filippello, che fu sempre suo intimo confidente e testimonio di tutte le sue azioni, asseriva: “Io sono persuaso che Giovanni non abbia mai commessi peccati. La virtù andava in lui crescendo coll’età. Fin da quando era ancor fanciullo, vedendolo in chiesa, aveva ammirato il suo contegno edificante e la divozione, colla quale pregava, e il suo riserbo nell’evitare, quanto poteva, la compagnia delle persone di altro sesso. Si distingueva fra tutti i suoi coetanei per morigeratezza, bontà di carattere; nell’infondere negli altri l’amore al [211] bene, dimostrava di avere uno zelo ed una intraprendenza meravigliosa. Manifestava sempre il desiderio di attendere agli studi a fine di fare del bene alle anime. A me ed a’ miei compagni diede sempre buoni consigli, e giammai mi avvidi che in qualche cosa sia caduto in errore. Colla sua affabilità invitavaci a frequentare con lui la chiesa, ci esortava, ci correggeva, e anche ai più dissipati non risparmiava i rimproveri. Poneva tutta la sua attenzione nell’allontanarci dalle cattive compagnie e nell’impedire i divertimenti pericolosi. Tutti noi ci lasciavamo dirigere e guidare da lui amorevolmente, essendosi conciliato il nostro rispetto e la nostra ammirazione. Camminava in mezzo a noi come uno che avesse autorità. Quando, per l’intemperie della stagione, quei della borgata non potevano andare alla parrocchia nelle ore pomeridiane, in sua casa o nel cortile, intratteneva i compagni in piccoli divertimenti, per avere agio di esporre loro qualche massima udita nella predica del mattino, istruirli nel catechismo, raccontar qualche esempio, o far loro sentire qualche pia lettura. Ordinariamente terminava i suoi trattenimenti colla recita del santo Rosario. Questa sua missione di apostolo gli procacciò fin d’allora fama di virtù non ordinaria. Tale semplicità e modestia splendeva in tutta la sua persona, che nelle feste i genitori della borgata gli davano volontieri i figli in custodia, sicurissimi fosse Giovanni un vero angiolo custode. Le madri dei dintorni animavano i loro fanciulli a frequentare la sua compagnia dalla quale l’esperienza dimostrava evidentemente come ritornassero sempre migliori”. “Molte di queste madri, aggiungeva Secondo Matta, giunte agli ultimi istanti della vita, ricordavano ai figliuoli, che scioglievansi in lacrime intorno al loro letto, gli esempi di Giovanni Bosco, e si facevano promettere che l’avrebbero preso per modello, imitandolo specialmente nella [212] preghiera e nell’obbedienza”. Insomma non pochi abitanti di Morialdo, di Castelnuovo e delle altre borgate, fra i quali D. Angelo Savio Salesiano ed il suo fratello D. Ascanio, più volte ci hanno affermato: “Tutti i compagni e coetanei di Giovanni conservarono sempre un’ottima opinione della sua condotta, e non abbiamo mai udito da essi contro di lui la menoma parola di accusa o di critica. E ancora oggigiorno in tutte queste regioni è grande la stima che nutrono i compaesani di Giovanni su l’innocenza della sua giovinezza”.
Una squadra di giovani dell’Oratorio, guidati da Giuseppe Buzzetti e da altri Salesiani, andava, non sono molti anni, ai Becchi per la festa della Madonna del Rosario. Incontrata una vecchia veneranda, questa li riconobbe per quelli che erano ed esclamò: “Io l’ho conosciuto D. Bosco fin da bambino, abitando io allora ai Becchi. Quanto era buono! Quante volte l’ho veduto pregare con fervore e accostarsi ai Sacramenti colla fede che gli traspariva dal volto!”. Ed io ora esclamerò alla mia volta: “Gloria dei figliuoli sono i loro padri”[57]. “Tieni conto del tuo buon nome, perchè questo sarà tuo più stabilmente che mille tesori preziosi e grandi. I giorni della buona vita si contano (perchè sono pochi), ma il buon nome dura eternamente”[58].
CAPO XXIV.
D.Calosso accoglie Giovanni in sua casa – Divisione dei beni di famiglia tra i fratelli Bosco – Morte di D. Calosso – Eroico disinteresse di Giovanni – Suo dolore per la morte del maestro e benefattore.
IL PADRE del giusto nuota nel gaudio, e chi ha un figlio saggio, in lui avrà la sua consolazione. Abbia questo gaudio la madre tua, ed esulti colei che ti ha generato[59]. Tale è l’oracolo infallibile della divina Sapienza. Margherita nondimeno nel suo gaudio e nella sua esultanza aveva pure una fonte di perenne afflizione. Chi può ridire quanto penasse quel cuore di madre nello scorgere il suo diletto Giovanni costretto a guadagnarsi col proprio lavoro il pane quotidiano, senza che alcuna speranza più le arridesse di metterlo a quegli studi, per i quali era persuasa avrebbe egli potuto fare un gran bene alle anime!
Senonchè D. Calosso non si era dimenticato del suo giovane amico. In lui aveva riconosciuti segni non dubbi di vocazione ecclesiastica, e non voleva che questa andasse perduta. E però il degno ministro di Dio, liberatosi da impacci di vario genere che non gli avevano permesso di eseguire [214] un suo pietoso disegno, chiamò un giorno a sè Giovanni, e dopo aver da lui udito il racconto delle sue vicende in quegli anni di lontananza e come Antonio nulla avesse smesso della sua cocciutaggine: – Giovanni mio, gli disse, tu hai posta in me la tua confidenza, e non voglio che ciò sia in vano; lascia adunque un irragionevole fratello, e vieni con me ed avrai un padre amoroso. – Giovanni comunicò tosto alla madre la caritatevole profferta, che venne da lei e dal fratello Giuseppe accolta come una vera felicità. Antonio non approvò, nè si oppose; d’altronde Giuseppe, indefesso lavoratore, prometteva di fare eziandio le parti di Giovanni nella coltivazione del podere.
In sul finir dell’estate pertanto Giovanni incominciò a far vita col cappellano, andando soltanto la sera a casa per dormire. “Niuno, scrive Giovanni, può immaginarsi la grande mia contentezza. D. Calosso era per me l’Angelo del Signore. L’amava più che padre, pregava per lui, lo serviva volontieri in tutte le cose. Era poi sommo mio piacere di faticare per lui e, direi, dare la vita in cosa di suo gradimento. Io faceva tanto progresso in un giorno col cappellano, quanto non avrei fatto a casa in una settimana. E quell’uomo di Dio mi portava tale affezione, che più volte ebbe a dirmi: – Non darti pena del tuo avvenire. Ti aiuterò ad ogni costo, e finchè vivrò non ti lascerò mancare nulla; se muoio ti provvederò egualmente”.
Tuttavia alla sera, ritornando Giovanni a casa, continuavano le guerre, succedendo i frizzi ai diverbi. Allora D. Calosso disse a Giovanni: – Se è così, va a prenderti alcune camicie e vieni ad abitare sempre con me. Sta certo che io non ti abbandonerò. – Rincresceva a Margherita lasciarlo di bel nuovo andar via da casa; pure non essendoci altro mezzo per avere la pace, vi si rassegnò. D. Calosso era pronto a [215] fargli compiere tutti gli studi di latinità in casa sua, e poi a sborsare le somme che occorressero perchè potesse riuscir prete. – E Giovanni andò a prendere stanza presso D. Calosso.
Margherita, disperando di ottenere il consenso di Antonio, che già oltrepassava i ventisei anni, risoluta e costante nel volere che il figlio studiasse, pronta a spendere tutto il suo patrimonio per sostenere ogni spesa, stabilì di venire alla divisione dei beni paterni. Non mancarono a ciò delle gravi difficoltà, specialmente per essere ancor minorenni Giuseppe e Giovanni; nulla di meno si venne a quella deliberazione. Margherita si era prima stretta a consiglio colla sorella Marianna, volendo ponderare maturamente quel passo, al quale molte volte avea già pensato e da cui era stata sempre rattenuta dall’affettuoso suo cuore. Esaminarono se vi fosse qualche altro partito da prendere, ma non fu loro possibile trovarlo. La maggior difficoltà però stava nel saper comporre le cose talmente, che la divisione delle terre non cagionasse la divisione totale dei cuori; ma a ciò provvide generosamente la sorella Marianna, dicendo a Margherita: – Tu ed io abbiamo qualche cosa del nostro: mettiamolo insieme e così potremo combinare l’affare in modo che Antonio non abbia a lamentarsi.
Antonio, appena ebbe notizia di questa deliberazione, non voleva assolutamente aderirvi, continuando ad insistere nella sua stolta pretensione che Giovanni dovesse come lui fare il contadino. Margherita però, la quale presa una risoluzione secondo giustizia era irremovibile, non cedette: e disse apertamente che i tribunali avrebbero finita essi la vertenza con dar ragione a chi l’aveva. Antonio quindi si rassegnò alla divisione; e, prima ancora che si facesse legalmente, si allontanò dalla madre, prendendo stanza in una parte della casa paterna, sulla quale aveva diritto; imponendo però alla [216] madre di nulla dare a Giovanni finchè il negozio non fosse aggiustato, e a Giovanni proibendo assolutamente di prendere cosa alcuna appartenente in comune alla famiglia. Giovanni avrebbe potuto pretendere la sua parte sui frutti dell’eredità paterna, eziandio pel tempo che precedeva l’atto della divisione legale; ma per non suscitare nuove questioni, obbedì all’ingiusta intimazione.
Più mesi ci vollero per ottemperare alle formalità di legge; ma, per tal modo ridotta la famiglia di Margherita a Giovanni e a Giuseppe, che volle vivere insieme col fratello, fu tolto un macigno dallo stomaco di Giovanni e gli si dava piena libertà di proseguire ne’ suoi studi.
Così gli affari di Giovanni procedevano con incredibile prosperità, ed egli stimavasi pienamente felice, non rimanendogli cosa alcuna a desiderare; quando un nuovo gravissimo infortunio sopraggiunse a troncare ancora d’un colpo il corso a tutte le sue speranze.
Un mattino del novembre 1830, D. Calosso inviò Giovanni presso i suoi parenti per una commissione. Era appena giunto a casa e stava preparandosi il fagotto delle camicie, allora che una persona, arrivando tutta ansante, gli fè’ cenno di correre immediatamente da D. Calosso, colpito da grave malanno, che domandava di lui e lo voleva assolutamente vedere e parlargli. Non corse, ma volò Giovanni accanto al suo benefattore, che fatalmente trovò a letto senza parola. Il buon sacerdote era stato assalito da un colpo apopletico. Riconobbe il suo discepolo e gli fissò in volto uno sguardo così commovente da riempirgli l’anima di dolore; fece alcuni sforzi, accennandogli qualche cosa; voleva parlare, ma non poteva più articolare sillaba; allora prese una chiave di sotto al capezzale e gliela consegnò, facendo segno di non darla ad alcuno e che quanto racchiudeva il cassetto chiuso da quella chiave tutto era per [217] lui. Giovanni si mise in tasca la chiave, che racchiudeva i danari, senza che egli lo sapesse, e prodigò al caro infermo le cure più affettuose che un figlio amorevole possa recare al proprio padre. Dopo due giorni di agonia il povero cappellano rendeva l’anima sua al Creatore. Era il giorno 21 novembre, e D. Calosso contava 75 anni. Con lui moriva ogni speranza per Giovanni.
Alcuni di quelli, che aveano assistito alle ultime ore dell’estinto, dicevano a Giovanni: – La chiave che ti ha data è quella del suo scrigno. Quei danari che vi si trovano sono tuoi; prendili. – Altri osservavano che in coscienza, non poteva prenderli, perchè non gli erano stati lasciati con atto notarile. Giovanni era in angustie; ci pensò su un poco e poi disse: – Oh! sì che voglio andare all’inferno per danari! Non voglio prenderli. – Quei testimoni però insistevano, asserendo che il modo, col quale il morente avealo chiamato, le sue parole quando era ancor sano, la chiave consegnata con quel gesto così espressivo, indicavano chiaramente la sua volontà e che quei danari gli appartenevano. Giovanni non si persuase. Intanto, venuto l’erede in compagnia di altri parenti, tutto affannato cercava di qua e di là la chiave dello scrigno. Giovanni gliela presentò dicendogli: – Ecco qui la chiave del danaro. Vostro zio me la consegnò, facendomi segno di non darla ad alcuno. Certuni mi dissero che poteva prendermi ciò che era nello scrigno: io però amo meglio essere povero; non voglio cagionare contestazioni: vostro zio non me lo disse che erano destinati per me. – Il nipote prese la chiave, aperse la cassa e vi trovò sei mila lire. Dopo averle contate, si volse a Giovanni e gli disse: – Rispetto la volontà dello zio: questi danari sono tuoi: io ti lascio piena facoltà: prendi tutto quello che vuoi. Giovanni stette alquanto soprappensiero: avea conosciuto in [218] modo abbastanza chiaro la volontà del defunto, avea la licenza dell’erede: – Ma no; concluse, non voglio niente! Io ho più caro il paradiso, che tutte le ricchezze e i denari del mondo. – Se vuoi niente, gli rispose l’erede, ti ringrazio del tuo atto generoso e grazioso. Sta da te, fa come vuoi. – Giovanni adunque prese nulla! Forse aveva udito qualche parente brontolare pretese. E nelle memorie compendia il fatto in queste semplici parole: “Vennero gli eredi di D. Calosso e loro consegnai la chiave ed ogni altra cosa”. Beato l’uomo che è trovato senza colpa, ed il quale non va dietro all’oro, nè sua speranza ripone nel danaro e nei tesori. Chi è costui e gli daremo lode? Perocchè egli ha fatto cose mirabili nella sua vita… ed avranne gloria eterna”[60].
La morte di D. Calosso però era per Giovanni un gran disastro. Egli piangeva incessantemente il benefattore defunto. Se era sveglio, pensava a lui; se dormiva, di lui sognava. Accresceva la sua mestizia il suono funebre delle campane, prolungato e ripetuto di parrocchia in parrocchia, per il Pontefice Pio VIII, morto il 31 novembre. Le cose andarono tanto oltre, che Margherita, temendo per la sua sanità, lo mandò per alcun tempo a Capriglio con suo nonno. La bontà divina tuttavia non lasciollo senza conforto. Egli scrisse nelle sue note: “A quel tempo feci altro sogno, secondo il quale io era acremente biasimato, perchè aveva riposta la mia speranza negli uomini e non nella bontà del Padre Celeste”. La memoria di D. Calosso per altro rimase sempre viva nel suo cuore, e di lui lasciò scritto: “Ho sempre pregato, e finchè avrò vita non mancherò ogni mattina di fare preghiere per questo mio insigne benefattore”.
CAPO XXV.
Margherita manda Giovanni alla scuola di Castelnuovo – Lo mette in pensione presso il sarto Giovanni Roberto – Giovanni si guadagna la simpatia dei compagni – Suoi progressi negli studi – Consolazione di sua madre – Come evita i compagni pericolosi – Continua la sua missione in mezzo ai giovanetti – Come vorrebbe il prete coi fanciulli.
LA MORTE di D. Calosso in quella stagione, mentre interrompeva in sul principio gli studi di Giovanni, rendeva per altra parte difficile l’accettazione sua alla scuola di Castelnuovo, ov’erano incominciate le lezioni fin dalle feste di Ognissanti. Margherita tuttavia, coadiuvata forse dal fratello Michele, personaggio conosciutissimo in Castelnuovo, potè superare questa difficoltà. E però, circa al Natale del 1830, Giovanni, nel decimoquinto anno dell’età sua, incominciò a frequentare le pubbliche scuole del proprio paese, le quali allora a fianco delle elementari avevano pure aperto un corso di lingua latina, mentre la buona sua madre disponevasi a maggiori fatiche e sacrifizi per assecondare la sua vocazione.
Gli studi fatti in privato, l’entrare in una pubblica scuola ed il cambiare maestro furono per Giovanni uno sconcerto, tanto che dovette quasi ricominciare la grammatica italiana per poi farsi strada alla latina. Da principio andava al [220] mattino ed al dopo pranzo da casa a scuola, percorrendo tra due andate e due ritorni venti chilometri circa di cammino al giorno; ma, danneggiando gli studi una perdita così notevole di tempo, ben tosto mutò programma e partiva al mattino per ritornare ai Becchi solamente alla sera. Talvolta spirava un vento molesto, tal’altra una pioggia o uno sgelo copriva il suolo di fango, oppure cadeva la neve ed il freddo acuto facevalo intirizzire; ma egli tutto tollerava con maravigliosa tranquillità d’animo e serenità d’aspetto. Per non cagionare spese soverchie alla madre, quando le vie erano fangose, si toglieva le scarpe e le portava a mano, giungendo al termine del viaggio coi piedi indolenziti e talora escoriati e sanguinanti. A Castelnuovo, messi i piedi nelle calzature, lasciava la sua tasca col cibo necessario, che seco recava, presso un tal Giovanni Roberto, uomo onesto, in casa del quale ritornava a rifocillarsi tra una lezione e l’altra. Quando sul far della notte imperversava la bufera, si fermava in paese, e andava a dormire in un sottoscala, ove una buona famiglia gli permetteva di ritirarsi. Il signor Pompeo Villata ci narrava di aver udito questi fatti nella sua stessa famiglia.
Mamma Margherita, per ragion d’economia e perchè rincrescevale tenere lontano il figlio da’ suoi occhi, avea permesso che dapprima facesse queste camminate, ma non tardò a vedere la necessità di trovargli un alloggio a Castelnuovo, perchè l’inverno si faceva sempre più crudo. La pensione poteva essere pagata in cereali, in vino, o in altri raccolti, secondo l’accordo. Giovanni d’altronde era molto amato da tutti quelli della sua borgata, i quali, temendo non avesse mezzi per proseguire gli studi, sembra che qualche volta facessero fra di loro una colletta, pregando Margherita di accettarla per i suoi poveri. Secondo Matta assicurava d’averle dato una volta una mezza emina di grano. Margherita [221] pertanto mise suo figlio in pensione presso il suddetto Giovanni Roberto, di professione sarto e buon dilettante di canto gregoriano e di musica vocale. Essa stessa l’accompagnò a Castelnuovo e nel lasciarlo gli diede un avviso dei più preziosi: – Sii divoto della Madonna!
La notizia dell’arrivo di Giovanni mise in curiosità di conoscerlo non poche persone. Le sue piccole geste erano note a Castelnuovo. Alcuni fanciulletti della famiglia di Monsignor Cagliero, allora che i giovani si avviavano alla scuola, poneansi sovente sulla porta col solo scopo di veder passare Giovanni Bosco. Ancora adesso ricordano il suo contegno modesto, raccolto, umile, co’ suoi libri sotto il braccio, il suo camminar da solo o con pochi compagni dei più serii. Vestiva una giubba logora, non troppo bene adattata alla sua persona e di una certa forma senza dubbio poco accetta a chi amasse far bella figura. Molti giovanetti di Castelnuovo, come appartenenti alla regione più nobile del Comune, si davano una certa aria d’importanza, reputandosi cittadini e riguardando quei delle borgate come gente più rozza e di minor conto. Quindi in sulle prime, fatti arditi dall’aspetto bonario di Giovanni, non mancarono di ridere e di scherzare sul suo vestito, e molte volte correndogli dietro in punta di piedi davangli una strappatina alle falde della giubba, ritirandosi poscia rapidamente a certa distanza. – Quella giubba, si dicevano a vicenda, è un dono che gli ha fatto certamente il parroco. È una meraviglia. Appartenne forse al nonno? – Giovanni non si scomponeva mai, ma tollerava con pazienza ogni sgarbo ed ogni molestia. Talvolta si volgeva sorridendo a quegli spensierati e loro graziosamente diceva: – Ma birichini! State un po’ fermi, lasciatemi tranquillo. Vi do io forse qualche noia? – Inoltre i condiscepoli, per la sua statura alquanto straordinaria in mezzo [222] a tanti piccolini, lo motteggiavano con un soprannome canzonatorio.
Queste burle però cessarono ben presto vuoi per la sua dolcezza, vuoi eziandio per aver egli dato mano a’ suoi trattenimenti festivi. “La parola dolce moltiplica gli amici, e la lingua graziosa nell’uomo virtuoso giova assai”[61]. Frattanto potè con maggior comodità che a Morialdo dar pascolo al suo cuore colle pratiche di pietà. In questi tempi le scuole comunali avevano un carattere eminentemente cattolico, secondo gli ordinamenti promulgati da Re Carlo Felice con le regie patenti del 23 luglio 1822. La scuola non doveva mai essere mista dei due sessi. In ognuna di esse campeggiava il Crocifisso. Nel mattino si dava principio colle orazioni e si terminava coll’Agimus tibi gratias; nel dopo pranzo si cominciava coll’Actiones nostras e si chiudeva la lezione colle preghiere della sera. La prima mezz’ora di ogni scuola si impiegava nell’insegnare il catechismo, e a questo pure era dedicata tutta intiera la lezione della sera del sabato, la quale finiva colle Litanie della Beata Vergine. I maestri dovevano intendersi col parroco, affinchè i fanciulli avessero comodità di assistere alla Messa prima della scuola e di confessarsi una volta al mese. Nei giorni di festa gli alunni erano obbligati ad assistere al catechismo ed alle funzioni nella chiesa parrocchiale. È colla pratica della pietà che si acquista la sapienza!
La scuola di lingua latina, da poco tempo istituita, era unica, e quindi in essa venivano raccolti tutti i giovani appartenenti alle varie classi di ginnasio, sotto la direzione di un solo professore, D. Emanuele Virano da Castelnuovo [223] d’Asti, quegli stesso che aveva benedetta la veste chiericale del Cafasso. Questi aveva molta scienza, particolare abilità nel comunicarla, e grande ascendente sugli scolari: egli sapeva così bene dividere il tempo e coordinare agli uni e agli altri le sue lezioni, che chi era di buona volontà poteva ricavarne non poco profitto. I progressi di Giovanni erano tali da attirare l’ammirazione del suo maestro. Un giorno fu dato per tema di composizione italiana il fatto di Eleazaro, che preferisce morire piuttosto che dare scandalo col mangiare carne porcina. Giovanni svolse così bene la traccia, che nessuno poteva capacitarsi l’avesse lui fatto. Si fece passare da uno all’altro professore quella pagina, e tutti ne facevano le meraviglie. In ultimo fu presentata a D. Moglia, il quale, dopo averla bene esaminata, concluse che neppure le persone più vecchie ed istrutte di quelle parti sarebbero capaci di scrivere un componimento simile, e per conseguenza essere impossibile che l’avesse fatto il giovanetto Bosco. Da questo giudizio di D. Moglia conobbe Giovanni non essere più egli nelle grazie di questo suo antico maestro. Infatti, per uno di quegli inesplicabili cambiamenti che talora veggonsi succedere nei cuori umani, D. Moglia si era ficcato in capo che il giovane contadinello dei Becchi avrebbe fatto meglio rinunziare agli studi e riprendere la zappa. Il perchè sallo Iddio, il quale preparava a Giovanni una nuova contraddizione, per mettere ancora una volta alla prova la sua fiducia in lui e la sua perseveranza.
Giovanni frattanto, benchè lontano dagli occhi della madre, manteneva sempre per lei quella santa affezione, che ella avea saputo ispirargli colle sue virtù. Nulla faceva senza il permesso di lei, ed essa concedevagli qualunque cosa domandasse, pronta ognora a contentarlo, essendo i suoi desiderii assai limitati e sempre di cose strettamente necessarie. [224]
Roberto e la sua famiglia aveano posto grande affetto a Giovanni, e specialmente il figlio, col quale frequentava le scuole, avea stretto con lui una cordiale amicizia. Mamma Margherita quasi ogni settimana veniva a portargli una provvista di pane che doveva durargli sette giorni: era un viaggio abbastanza lungo, ma ella sapeva quanto fosse importante esaminare da vicino gli andamenti del figlio. Anche quando Giovanni fu a Chieri come semplice studente e poi come chierico, continuò, benchè più raramente, a fargli le sue visite; e Giuseppe teneale sempre compagnia per vedere il fratello. Tutta la famiglia di Roberto era in festa al comparire di Margherita, perchè chi ha cuore trova corrispondenza nelle persone caritatevoli. Margherita esultava nell’udire come il figlio si mantenesse ogni giorno più fedele a’ suoi precetti: sentiva con piacere ripetersi da tutti come egli fosse virtuoso, molto pio, dedito alla preghiera ed all’esatto adempimento de’ suoi doveri scolastici: come si facesse notare fra i suoi compagni per la gran divozione e modestia, onde frequentava i SS. Sacramenti e come fosse oggetto di ammirazione pel suo contegno in chiesa e per l’assiduità alle sacre funzioni: motivo per cui il prevosto D. Dassano avealo messo come assistente in una classe durante il catechismo quadragesimale.
Alla virtù però non mancano insidiatori. Giovanni in quell’anno s’ebbe anch’egli i suoi pericoli per parte di alcuni compagni. Volevano condurlo a giuocare in tempo di scuola; e siccome egli per schermirsene adduceva la ragione di non aver danaro, gli suggerirono il modo di procurarsene, rubando al padrone o alla madre. Un compagno per animarlo a ciò dicevagli: – Mio caro, è tempo di svegliarsi; bisogna imparare a vivere al mondo. Chi tiene gli occhi bendati non vede dove cammina. Orsù provvediti di danaro e [225] godrai anche tu i piaceri de’ tuoi compagni. – Giovanni a così perfida suggestione rispose: – Io non posso comprendere ciò che vuoi dire, ma dalle tue parole sembra che mi voglia consigliare a giuocare e a rubare. Ma non dici tu ogni giorno nelle preghiere: Settimo non rubare? Non è questo forse un comandamento della legge di Dio? E poi chi ruba è ladro, e i ladri fanno trista fine. D’altronde mia madre mi vuole molto bene; e se le domando danaro per cose lecite, me lo dà; senza suo permesso non ho mai fatto niente; nemmeno voglio incominciare adesso a disubbidirla. Se i tuoi compagni fanno questo mestiere sono perversi. Se poi nol fanno e lo consigliano ad altri sono bricconi e scellerati. – Questo discorso passò dall’uno all’altro, e niuno più osò fargli di quelle indegne proposte. Anzi quella risposta andò all’orecchio del professore, il quale da quel momento prese a portargli maggior affezione; si seppe eziandio dai parenti dei giovanetti, anche dei benestanti, i quali perciò esortavano i loro figliuoli ad andare con lui e imitarne gli esempi, incantati specialmente pel candore che traspariva da ogni suo atto. Per tal modo potè con facilità farsi una scelta di amici che lo amavano e obbedivano come quelli di Morialdo e di Moncucco, i quali non mancavano di quando in quando di venirgli a fare qualche visita. La sua compagnia era una continua lezione di prudenza. In tutte le sue cose di molta o di poca importanza, mostrava sempre un grandissimo impegno; stava attento a quel che diceva, nè mai parlava senza aver prima ben riflettuto: presa una giusta risoluzione, nessuno più poteva smuoverlo da’ suoi propositi. Senz’accorgersene, i suoi amici si venivano formando il loro carattere sul modello del compagno, che cercava ogni via per guadagnarsi il loro cuore e rendere loro accetti i suoi salutari consigli. Fra le altre industrie, tutte le volte che ritornava [226] dalla casa materna, ove recavasi a passare qualche giorno di vacanza, soleva portare seco delle frutta per farne parte ad essi, che godevano moltissimo di quell’amabile generosità; ed egli prendeva da ciò occasione per parlare loro di religione e raccomandare calorosamente la divozione a Maria Santissima. Una speciale attrattiva aveva per lui la chiesa, detta del Castello, posta sul punto più culminante del colle: dove egli saliva ora solo, ora accompagnato dagli amici, per dare alla Vergine Benedetta il tributo della sua figliale devozione. Colà forse la Madre celeste gli fu larga di qualche favore segnalato, perchè col trascorrere degli anni non dimenticò mai quella chiesa e i soavi momenti in essa gustati. Quando Giovanni Filippello veniva a visitarlo a Torino, non lo lasciava mai partire senza regalargli un pacco d’immaginette da distribuirsi alle persone che andavano a detta chiesa per recitarvi il santo Rosario, e specialmente per allettare con esse i giovanetti ad ascendere quell’altura per onorare Maria.
Tale fu il suo costante tenor di vita, eziandio negli anni seguenti quando ritornava da Chieri nella stagione estiva, mantenendo sempre non solo, ma accrescendo la buona opinione che di lui si aveva in patria. Sacerdoti e popolo finirono sempre unanimi nel ripetere le sue lodi per la perseverante ed eccellente sua condotta, tutti asserendo com’egli fin dalla sua adolescenza fosse acceso da un vivo e costante desiderio di diventare missionario apostolico e fare gran bene alle anime. Come le madri di Morialdo e di Moncucco, così quelle di Castelnuovo dopo molti anni parlavano ai loro figliuoli delle virtù di Giovanni; e Mons. Cagliero ci narrava come, essendo egli ancor fanciulletto, la sua genitrice proponevagli Giovanni Bosco a modello, esortandolo spesse volte ad imitarlo. [227]
Giovanni adunque, tra le opere buone, gli studi e gli amici trascorreva tranquilli i suoi giorni. Tuttavia in mezzo alla sua felicità aveva una spina nel cuore: quella di non poter contrarre alcuna famigliarità coi preti del paese. Il parroco D. Bartolomeo Dassano, uomo veramente santo, dotto, caritatevole, esatto in tutti i suoi doveri, teneva un contegno sostenuto e poco accostevole ai fanciulli. Lo stesso riserbo usavano pure gli altri sacerdoti. Giovanni però fin da quell’età conosceva il bisogno che ha la gioventù di un sostegno amorevole, e che questa si lascia piegare come si vuole, purchè siavi chi se ne prenda cura: egli provava in se stesso una tale necessità. Spesso gli avvenne d’incontrarsi col prevosto accompagnato dal viceparroco: anzi alcune volte andava espressamente ad appostarlo nell’ora che sapeva essere solito ad uscire verso sera per la passeggiata. Sentiva un vivo desiderio di avvicinarlo e di ascoltare dalla sua bocca una parola di confidenza: provava in sè un bisogno di essere da lui amato. Appena lo vedeva comparire, lo salutava da lontano e più vicino tutto peritoso gli faceva eziandio un inchino. Il parroco in modo grave e cortese restituiva il saluto e continuava il suo cammino; ma non ebbe mai un motto affabile, che a sè traesse i giovani cuori e li eccitasse a confidenza. A que’ tempi si credeva che una simile gravità fosse il vero contegno delle persone di chiesa. Però un tal rispetto produceva in Giovanni timore e non amore. Egli più volte piangendo diceva fra se e con altri: – Se io fossi prete, vorrei fare diversamente: mi avvicinerei ai fanciulli, li chiamerei intorno a me, vorrei amarli, farmi amare da essi, dir loro delle buone parole, dare loro dei buoni consigli e tutto consacrarmi per la loro eterna salute. Quanto sarei felice se potessi discorrere un poco col mio prevosto! Questo conforto l’ebbi con [228] D. Calosso: con altri nol posso più avere? – Specialmente colla madre sfogava questi suoi pensieri; e Margherita, che conosceva il cuore del figlio ed era donna capace di apprezzare simili sentimenti: – E che vuoi farci! dicevagli. Sono uomini pieni di scienza, pieni di pensieri serii e non sanno adattarsi a parlare con un ragazzo, come sei tu!
– Ma che cosa costerebbe loro dirmi una buona parola, fermarsi qualche minuto con me?
– E che cosa vorresti che ti dicessero?
– Qualche bel pensiero che faccia bene all’anima mia.
– Vedi bene che han tanto da fare nel confessionario, sul pulpito, nelle altre cure della parrocchia!
– E non siamo anche noi piccolini le loro pecorelle?
– Sì, è vero; ma non hanno tempo da perdere!
– E Gesù perdeva tempo quando s’intratteneva coi fanciulli? quando sgridava gli Apostoli che volevano tenerli lontani, e diceva che li lasciassero andare a lui vicino, perchè di essi è il regno de’ cieli?
– Non ti do mica torto: anzi ti do ragione; ma che cosa vuoi farci?
– Io! oh vedrete: se potrò farmi prete, voglio consacrare tutta la mia vita per i fanciulli: non mi vedranno serio serio, ma sarò sempre io il primo a parlare con essi.
CAPO XXVI.
D. Virano si ritira dalla scuola di Castelnuovo – Gli succede D. Moglia – Scolaresca indisciplinata e tempo perduto – Pazienza di Giovanni – Impara la musica e il mestiere del sarto e del fabbroferraio – Sue industrie per le necessità della vita – L’albero della cuccagna.
LE COSE di Giovanni prendevano così ottima piega, allorchè novello incidente lo venne a disturbare. D. Virano, suo professore, fu nominato parroco di Mondonio nella diocesi d’Asti; e però nell’aprile di quell’anno 1831 si ritirava dalla scuola per ordinare le cose sue, eseguire le incombenze che esigevano le leggi e apparecchiarsi il suo nuovo domicilio: nel 1832 poi andava al possesso della sua parrocchia. Castelnuovo quindi rimaneva senza maestro di latino. Fu incaricato di supplirlo D. Moglia, uomo caritatevole e pio, del quale in Castelnuovo si conserva tuttora venerata memoria, ma incapace di dominare cinque gruppi di giovani vivacissimi e diversi per età, istruzione e sviluppo d’intelligenza. Egli dovea contemporaneamente far scuola corrispondente alle nostre prima, seconda e terza ginnasiale, umanità e retorica. La mancanza di disciplina pertanto mandò quasi al vento quanto nei mesi precedenti Giovanni aveva imparato. Il nuovo maestro, testimonio della sua buona condotta, [230] quantunque avesse udito parlarne con gran lode anche dai propri parenti alla cascina Moglia, e in fondo in fondo gli volesse bene, pure erasi fitto in capo che, essendo dei Becchi, non potesse essere che un asino, di buon conto se volete, ma sempre asino. L’età sua avanzata di quindici anni la supponeva causa d’inettitudine. Giovanni era classificato con quelli che facevano il primo corso ginnasiale. Un giorno il maestro dava il lavoro dei posti: Giovanni chiese per grazia che gli lasciasse fare il compito assegnato a quelli di terza ginnasiale. D. Moglia diede in una risata: – Che pretendi tu… tu dei Becchi? che cosa vuoi sieno capaci di fare que’ dei Becchi? Lascia, lascia di studiare il latino… non ne capirai niente. Tu va per funghi, va per nidiate: ecco il tuo buono: ecco la tua abilità: in ciò riuscirai stupendamente… Ma tu studiare il latino è una stranezza! – Giovanni senza dar segno di essere offeso insistè: il maestro replicò caricando la dose; ma siccome Giovanni non cessava di chiedergli che facesse quella prova, finalmente gli disse di accomodarsi con quel còmpito che gli piacesse meglio, ma protestando che egli non leggerebbe le bestialità che riuscirebbe a mettere in carta.
Per gli allievi di terza ginnasiale fu dettato un tema latino da tradurre in italiano. Dopo breve ora Giovanni presentava la sua pagina al professore, il quale la prese, e senza guardarla, la pose sul tavolino, sorridendo in atto di compassione. Giovanni erasi fermato in piedi innanzi al maestro, e: – La prego, gli disse, osservi la mia pagina; ne corregga gli errori. – Ma non ti ho detto, rispose stizzito il maestro, che quei dei Becchi non sanno niente… che non hanno ingegno per queste cose elevate? – Allora alcuni della scolaresca si alzarono e dissero: – Sì, sì, legga, legga la pagina di Bosco: chè anche noi vogliamo sentire i belli spropositi che vi [231] sono. – Il maestro, solito a cedere innanzi alla scolaresca, prese la pagina e le diede uno sguardo: la traduzione era esatta; ma D. Moglia, riponendola sul tavolino, esclamò: – L’ho detto io che Bosco è buono a niente!? l’ha copiata tutta per intero da qualche compagno… l’ha copiata certamente: è impossibile che questa sia opera sua. – Il vicino di posto a Giovanni, che era stato testimone del come aveva lavorato il suo compagno, senza ricorrere ad altri o a libri, s’alzò allora a prenderne le difese: – Signor professore, disse, lei afferma che Bosco ha copiata la traduzione; favorisca esaminare se fra le pagine degli scolari ve ne sia alcuna somigliante alla sua. – Era un’osservazione ragionevole, che avrebbe dovuto sciogliere ogni questione; ma il maestro sempre più ostinato rimproverò colui che l’avea fatta: – Ma che cosa vuoi sapere tu? Non hai inteso che que’ dei Becchi sono buoni a nulla, a nulla affatto? – E non ci fu verso di persuaderlo, chè, accecato da pregiudizi, non curavasi punto di cercare la verità. Quel giovanetto però, che avea visto Giovanni a fare il còmpito, narrò ai compagni per filo e per segno come era andata la cosa; e tutti ammirando non solo l’ingegno suo, ma ancor di più l’umiltà onde avea sopportate le ignominiose parole, concepirono per lui grandissima stima ed affetto. Questo fatto contribuì molto ad accrescere la sua influenza in mezzo a quei giovanetti, i quali l’ammiravano pure pel suo edificante contegno. Egli infatti fin d’allora procedeva tanto composto in tutta la persona e negli atti, così quando era solo come allorchè trovavasi in mezzo ai compagni, da essere un modello di cristiana dignità. Aborriva da ogni scherzo villano, da ogni giuoco che portasse a mettere le mani addosso agli altri, e da ogni specie di famigliarità sconveniente a persona bene educata. Era specialmente avversissimo al [232] giuoco della cavallina; ricusavasi sempre di prendervi parte e biasimava coloro che prima e dopo scuola in simile guisa si trastullavano.
Sotto la guida di un tal maestro si può immaginare quali avanzamenti abbia potuto fare Giovanni negli studi dall’aprile fino al fine dell’anno. Saremmo tentati di chiamarla desolante fatalità: eppure era sempre la divina Provvidenza che dirigeva gli avvenimenti per formare il suo servo alla propria vocazione.
Giovanni Roberto era allora capo-cantore della parrocchia, ed il giovanetto Bosco fin dal principio dell’anno, essendo fornito di buona voce, da lui guidato davasi con tutto amore all’arte musicale. Non solo imparò il canto fermo, ma in pochi mesi potè salire sull’orchestra ed eseguire parti obbligate in musica con felice successo. Nello stesso tempo incominciò ad esercitarsi nel suono del violino e a tentar sue prove sopra un vecchio cembalo o spinetta per poter accompagnare qualche volta sull’organo. Nel 1831, oltre le grandi solennità dell’anno, straordinari avvenimenti radunavano i fedeli in parrocchia, e davano occasione ai cantori di alternare le loro armonie ora liete ed ora tristi. Il 2 febbraio veniva eletto il nuovo Papa Gregorio XVI: il 27 di aprile moriva il Re Carlo Felice, ultimo sovrano della linea primogenita di Casa Savoia e a lui succedeva sul trono Carlo Alberto, capo della Casa Savoia – Carignano, il quale apriva in Torino la chiesa della Gran Madre di Dio incominciata nel 1818: ed al 6 agosto rendeva la sua anima al Creatore l’Arcivescovo Mons. Chiaverotti.
Questi esercizi di musica furono per Giovanni di vantaggio incalcolabile. Il buon Roberto era entusiasmato dei suo allievo e senza saperlo cooperava colle sue lezioni ai disegni di Dio. La sua casa era l’unica scuola, nella quale [233] il caro giovine avrebbe potuto imparare con sufficiente perfezione il canto: in qualunque altro luogo la madre lo avesse messo, e specialmente se lo avesse mandato fin da quell’anno a Chieri, con tutta probabilità sarebbe rimasto privo di così preziosa istruzione. Ed era necessario che si sviluppasse in lui l’amore e la cognizione di quest’arte, che doveva essere la vita dell’istituzione che la Provvidenza voleva per suo mezzo fondare. La lode perenne che si sarebbe innalzata da un capo all’altro del mondo al trono dell’Altissimo è la espressione della continua allegrezza che deve regnare nei cuori de’ figliuoli di Dio. Quanti giovinetti ebbero ad esclamare rivolti al Signore: “Esulteranno le mie labbra e l’anima mia da Te redenta, quando io canterò le tue lodi”[62].
Ma lo studio ed il canto non bastarono ad esaurire la attività di Giovanni, il quale, desiderando di occupare la ricreazione in qualche utile cosa, si pose ad imparare il mestiere del sarto. In brevissimo tempo divenne capace di mettere i bottoni, fare gli orli, le cuciture semplici e doppie; poi apprese a tagliare le mutande, i corpetti, i calzoni, i farsetti, talchè raccontava poi scherzando a’ suoi amici dell’Oratorio: – Mi pareva di essere divenuto un valente capo-sarto. – Ciò che aveva incominciato per ricreazione, dovette continuare in quell’anno per necessità, onde mantenersi aiutando il padrone nel mestiere: la divisione dei beni di famiglia, le esigenze di Antonio impedivano alla madre di provvederlo dei mezzi necessari per pagarsi la pensione. Questo mestiere poi gli giovò moltissimo più tardi quando, fondato l’Oratorio, dovette per lungo tempo esercitarlo a favore de’ suoi giovanetti. Il padrone vedendolo così progredire nel suo mestiere, [234] gli fece delle proposte assai vantaggiose, affinchè si fermasse definitivamente a lavorare con lui. Ma diverse erano le vedute di Giovanni: egli desiderava di avanzarsi negli studi, e di tante cose si occupava unicamente per evitare l’ozio ed avere i mezzi di raggiungere lo scopo suo.
Tra questa varietà di cose eravi eziandio il mestier del fabbro ferraio, in cui si esercitava allorchè la scuola non riuscivagli più profittevole. Egli frequentando la bottega di un certo Evasio Savio, eccellente cristiano, apprese il modo di lavorare alla forgia, colla mazza e la lima. Fino osservatore qual era, nulla sfuggivagli delle costumanze ora di questa, e più tardi di altre officine, e colle sue giudiziose e replicate interrogazioni veniva a possedere una sufficiente teoria intorno al nuovo mestiere che aveva preso a considerare.
E qui io chiedo a me stesso: Chi ha posto nel cuore di un contadinello una propensione così dichiarata a varii mestieri? Chi soavemente lo mette in tali circostanze, che l’occuparsene diventi talora per lui una necessità? Senza dubbio quegli stesso che, destinandolo a capo degli Oratori festivi e delle Colonie agricole, lo voleva eziandio fondatore di Ospizi per artigianelli. E però in lui va accumulando tali virtù, che il giovanetto del popolo, l’orfano lavoratore della terra e l’artigianello in lui abbia a trovare un uomo, che alla loro propria condizione appartenne, che intimamente ne conosca i bisogni, le aspirazioni, le abitudini e che si faccia tutto a tutti. Inoltre egli dovrà pensare a mantenere questi giovani innumerevoli, senza alcun reddito fisso, affidato unicamente giorno per giorno nella divina Provvidenza. Se al Venerabile Cottolengo, come pure ad altri Santi, Iddio conduceva i benefattori, perchè gli versassero nelle mani le proprie elemosine, pare volesse che il nostro Giovanni andasse lui stesso in suo nome a chiedere la carità ai fedeli a costo di qualunque [235] sacrifizio ed umiliazione. Per questo l’aveva fornito di un’anima intraprendente, attivissima, energica, ricca di espedienti per giungere al suo scopo, calma per rimuovere le difficoltà, costante e prudente nel scegliere i mezzi opportuni, affettuosa nel vincere i cuori, imperterrita nel non avere riguardi umani. Questa fu la sua palestra fin da fanciullo. Ai Becchi infatti avea usato mille industrie a fine di procurarsi i soldi necessari per attirare co’ suoi giuochi la gente; ed ora ei deve, finchè non sia chierico, provvedere a se stesso quanto gli è di bisogno alla vita. Un grazioso aneddoto accadutogli in questo tempo ci dimostra fino a qual punto fin d’allora egli si rendesse industrioso nel procurarsi il necessario per continuare gli studi. Ci venne raccontato da testimoni oculari del fatto.
Nel paese di Montafia si celebrava una gran festa e in mezzo alla piazza era piantato l’albero della cuccagna. Si ergeva altissimo e in cima aveva un cerchio, cui erano appesi varii oggetti di premio. Una folla immensa assisteva allo spettacolo. I giovanotti del paese gli uni dopo gli altri avvicinavansi all’albero e, data un’occhiata a quell’altezza, ne tentavano la salita per impadronirsi del premio. Chi giungeva a un terzo dell’albero e chi a metà, ma poi sdrucciolando ritornavano a terra. Le grida del popolo, che animava i più coraggiosi che sembravano in lena di salir molto alti, o i battimani e i fischi ai più deboli che non potevano reggersi su quel tronco liscio ed unto, andavano alle stelle. Giovanni osservava come quei giovanotti incominciassero tutti con rapidità ed affanno senza prender fiato e che, arrivati a un certo punto, più non potevano continuare, in giù trascinati dallo stesso peso del corpo. Egli quindi volle far sua prova un po’ diversamente. Si presentò risoluto, ma con calma, in mezzo allo spazio lasciato vuoto dalla folla, ed incominciò ad arrampicarsi lentamente, di quando in quando incrociando le [236] gambe che abbracciavano l’albero e sedendosi sulle calcagna per riposare. Il popolo, che sulle prime non intendeva il perchè di quella manovra, rideva a più non posso, aspettandosi da un momento all’altro di veder lui pure a scivolare, come aveano fatto quelli che aveanlo preceduto; ma guadagnando egli sempre più di altezza, si fece un silenzio generale. Quando Giovanni fu vicino alla punta dell’albero, che dondolava spaventosamente per essere colassù molto sottile, frenetici applausi si levarono da tutte parti al piccolo vincitore. Ed egli, stesa la mano, prese la borsa con venti lire, un salsicciotto ed un fazzoletto, se li pose in seno, e lasciando gli oggetti di minor importanza perchè si potesse continuar il giuoco, rapidamente discese, e col suo bottino si confuse tra la folla tripudiante per la riportata vittoria e disparve.
Nè questa fu la sola volta che Giovanni riuscì a guadagnare simili premii, i quali gli tornavano utilissimi per mantenerlo nella sua condizione di povero studente.
CAPO XXVII.
Giovanni alle vacanze – Singolare ricreazione nell’ora del riposo meridiano – Prima lettera pastorale di Mons. Luigi Fransoni, Vescovo di Fossano ed amministratore della Diocesi Torinese – Un secondo sogno – Giovanni è inscritto come studente nel Collegio di Chieri – Il parroco e i suoi compaesani lo provvedono per le spese della pensione.
FINITO con poca soddisfazione quest’anno scolastico, sempre incerto del suo avvenire, ma rassegnato, Giovanni ritornava presso la madre. In famiglia frattanto era accaduto un’importante mutazione. Mamma Margherita e il fratello Giuseppe, che omai aveva diciott’anni, stretta società con certo Giuseppe Febraro, si erano accomodati in mezzadria nel podere detto il Susambrino, proprietà allora Matta, la quale stendevasi sopra una collina a metà via tra i Becchi e il paese di Castelnuovo e che dopo alcuni anni venne comprata dal cavaliere Pescarmona. Giuseppe prese stanza nella casa colonica, mentre il Febraro aveva cascina e terreni propri confinanti col Susambrino. Margherita alternava la sua residenza ora in questa nuova abitazione ed ora ai Becchi, secondo l’esigenza dei lavori campestri e dei raccolti. Il fratellastro Antonio, definita la divisione dei beni paterni, dimorava solo in quella [238] parte di casa che eragli stata assegnata, coltivava il suo piccolo tratto di terreno e recavasi bracciante in giornata presso quei proprietari che avevano bisogno dell’opera sua. Giovanni prese alloggio presso il fratello Giuseppe, che lo amava svisceratamente, ed ebbe libertà di darsi intieramente a’ suoi libri. Possedeva una piccola biblioteca religiosa, formata dei volumi che gli aveano donati o imprestati il maestro D. Lacqua, il parroco di Moncucco e D. Calosso, fra cui v’erano pure le opere ascetiche del B. Alfonso Maria de’ Liguori e qualche catechismo ragionato che mandava a memoria. Egli però non volle essere di peso al fratello. Sua occupazione ordinaria pertanto era di condurre due vacche al pascolo nelle valli sottostanti, e talora prestare mano nella coltivazione del podere. S’era poi formato in un angolo della casa come un piccolo laboratorio, e andava rappezzando le proprie vesti e quelle di Giuseppe, e sopra di un fornello riattava gli strumenti agricoli che si erano guastati.
Una ragazzetta, certa Rosa Febraro, figlia del sunnominato Giuseppe Febraro, che poi, sposatasi con un Cagliero, divenne cugina di Mons. Giovanni Cagliero, Vicario Apostolico della Patagonia, conduceva pure il suo armento a pascolare da quelle parti. Essa racconta come talora il giovanetto Bosco fosse sì profondamente assorto nelle sue idee, da non accorgersi punto come le sue vacche sbandatesi entrassero nei terreni coltivati, e che essa affrettavasi a ricondurle al proprio luogo. Giovanni avvedendosi poi del servizio, ringraziavala con poche parole, e alcuna volta, approfittando delle ingenue esibizioni della fanciulla, a lei lasciava la custodia de’ suoi animali e secondo il solito si ritirava all’ombra dei salici o delle siepi a pregare o a leggere qualche libro.
In quella solitudine Giovanni aveva trovato modo di stare occupato nelle stesse ore di ricreazione, specialmente nei [239] calori meridiani, quando i contadini solevano riposare, avendo per regola costante di non abbandonarsi mai al sonno durante il giorno. “Quando è tempo di alzarti da mensa, non istare a bada; vattene il primo a casa tua e ivi divertiti e scherza e fa quel che ti piace, ma senza far peccati e senza parlare con superbia”[63]. È una cosa da nulla quella che ora io noto; ma anche le cose piccole e da nulla possono entrare in un gran quadro e cooperare alla sua bellezza. Lo scrittore ispirato descrisse nel libro di Tobia il cagnolino che accompagna Tobiolo nel viaggio e lo precede nel suo arrivo alla casa paterna. S. Giovanni Evangelista, sorpreso da un cacciatore mentre accarezzava una pernice, disse a chi mostrava di essere sorpreso di quella infantile semplicità: Perchè fate le meraviglie, se io riposo la mia anima, acciocchè possa slanciare i suoi pensieri al cielo? Ed è anche nell’istinto delle anime buone l’antico dominio che Adamo innocente aveva su tutti gli animali. Or bene: io dirò come nella casa di Giuseppe si tenesse un cane da caccia, al quale Giovanni aveva posto il nome di Bracco. Nelle ore di ricreazione lo aveva addestrato in varii giuochi e salti; si faceva porgere or l’una or l’altra zampa, secondo l’ordine che davagli colla voce. Presentandogli del pane, avealo assuefatto a prenderlo con delicatezza dalla sua. Quando il pezzo era troppo grosso, Giovanni dicevagli con viso brusco: – Ghiottone! come! vuoi mangiarlo tutto in un boccone? – Il cane allora restava indeciso, guardava il padrone, si contentava di leccare il cibo che aveva innanzi, e solo quando Giovanni gli diceva: – Mangia! – osava trangugiarlo. Tal volta costringeva il suo fido animale a salire e discendere la scala a piuoli che metteva sul fienile, [240] prendendo infinito diletto nell’imbroglio che provava per quella insolita via, alla quale pure l’avvezzò a poco a poco. Tal’altra portavalo o gettavalo sul fienile, che era molto alto, e, tolta la scala, si allontanava chiamandolo; il cane abbaiava, correva in su e in giù, cercava un luogo agevole per poter discendere, si ritirava spaventato dall’altezza, ma poi finalmente si gettava a basso e tutto festoso gli correva dietro. Bracco lo accompagnava ovunque andasse. Se Giovanni, stanco talora dal cammino, soffocato dal caldo, voleva alleggerirsi della giubba, chiamava: – Bracco, porta la mia giubba! – e se indugiava a dargliela, il cane avvicinandosi prendeva il lembo della giubba stessa, che Giovanni non si era ancora tolta e a sè la tirava. – Ma, Bracco! tu me la stracci: lascia stare: adesso te la darò. – Il cane lasciava tosto la giubba, e Giovanni toltasela gliela metteva sul dorso, ed esso tutto timido camminava, guardando sovente or l’uno or l’altro de’ suoi fianchi per timore che l’abito cadesse.
Alla domenica, dopo tutte le funzioni di chiesa, ritornava alla sua collina accompagnato dagli amici, e loro faceva godere nuovi divertimenti per mezzo del suo fido Bracco. Dopo avergli fatto eseguire uno svariato numero di giuocherelli tra le risa dei compagni, ordinavagli di saltare sul dorso di una vacca che pascolava poco distante. Il povero cane con uno sguardo dubbioso e mesto fissava il padrone, quasi volesse dire: Quale sproposito! Ma dietro l’intimazione di Giovanni, che non ammetteva replica, presa la spinta, saltava e cadeva dalla parte opposta, per aver troppo slanciato il colpo. Tuttavia ritentava la prova, ed eccolo fermo sulla groppa della vacca. Sedevasi sulle zampe posteriori, restringevasi più che poteva per tema di cadere, nè osava discendere in attesa che gliene si desse licenza. Giovanni allora si allontanava, [241] fingendo di più non badare a lui; ma il cane incominciava a guaire, quasi chiedendo permesso di togliersi da quell’imbarazzo, nel quale lasciavalo non per brev’ora, fino a tanto che l’animale, vedendo che il padroncino non se ne dava per inteso, mandava un forte abbaiamento, spiccava un salto e correva a raggiungerlo quasi rimproverandolo d’indiscrezione. Indicibile è l’allegria che provavano i giovanetti a tale spettacolo.
Parrebbe che Giovanni, il quale da piccino aveva sofferto tanto dolore per la morte di un merlo, difficilmente avrebbe tollerato la perdita di questo ingegnoso animale. Ma non fu così, ricordandosi della promessa fatta al Signore. Avendoglielo chiesto in dono certi suoi parenti di Moncucco, senz’altro egli stesso di buon grado lo condusse a casa loro. Bracco fu accolto con molte feste, e quando Giovanni lo vide tutto sommesso ai nuovi padroni, di soppiatto ripartì solo; ma giunto che fu a casa, si vide comparire innanzi il suo fido animale. Tutto peritoso, colla testa bassa, come chi riconosce di aver fatto una disobbedienza, si avvicinò lentamente dimenando la coda e fermandosi tratto tratto. Giovanni non gli sorrise secondo il solito, ma gli disse: – Bene! vedi, Bracco, questa non è più tua casa: dunque io non ti darò più da mangiare. – Il cane allora andò ad accovacciarsi in un angolo della stanza, e per lungo tempo non si mosse. Pochi giorni dopo giunsero i parenti di Moncucco per riprenderlo; ma tornato nuovamente a Moncucco, appena fu libero, prese la via del Susambrino. Giovanni lo ricevette col bastone alla mano; il cane invece di fuggire, andò a coricarsi a ‘suoi piedi e, rivolto colle gambe in aria, sembrava gli accennasse dibatter pure a patto che più non lo allontanasse. Giovanni si commosse a quell’atto e lo ritenne seco.
Una cara notizia giungeva frattanto a rallegrare la pace di queste vacanze. Un Breve Pontificio con data 12 agosto [242] affidava a Mons. Luigi Fransoni, vescovo di Fossano, l’amministrazione dell’Archidiocesi Torinese. Ed in una domenica del mese di settembre Giovanni udiva dal pulpito leggere la sua prima lettera pastorale, nella quale accennavasi come i tempi incominciassero a intorbidarsi. Infatti l’autorità civile ordinava, contro le disposizioni ecclesiastiche, che si celebrasse la Messa funebre per un chirurgo morto poco cristianamente ad Annecy e vietava ai Gesuiti la stampa del loro calendario, se non vi notavano le lezioni comuni nella festa di S. Gregorio VII, invece delle proprie che si pretendevano lesive all’autorità del principe. Senza saperlo secondavasi l’intendimento dei settari, i quali, smaniosi di affrettare il compimento dei loro tenebrosi programmi, in numero di 200, nel mese di febbraio, avevano tentato di assalire la Savoia, donde vennero dispersi dalle truppe regie: mentre nel mese di aprile la polizia arrestava i complici di una nuova congiura ordita dall’Avv. Angelo Brofferio e da altri. Quella lettera improntata a mestizia, il nome di Mons. Fransoni udito per la prima volta, non avrà destato nel cuore di Giovanni le simpatie di un soave presentimento? Era il padre, il sostegno, l’amico confidente che il Signore destinavagli, perchè gli desse protezione efficace nella prima fondazione delle sue opere meravigliose. Uno era fatto per l’altro; il contadinello dei Becchi aveva le stesse inclinazioni del nobilissimo Signore Genovese. Questi, benchè allevato nel lusso e nelle comodità, non si era fatto cappuccino, per il negato consenso del marchese suo padre; ma vestito l’abito chiericale a venticinque anni, appena sacerdote si era dato tutto ai catechismi e ad ascoltare le confessioni dei fedeli, e ascrittosi ai missionari diocesani, aveva percorso evangelizzando molte alpestri regioni della Liguria, con stenti, ma con frutto incalcolabile. Se Giovanni nulla intese allora del [243] segreto di Dio, pure un nuovo sogno sembra si colleghi con questo fatto per la sua contemporaneità.
Giovanni alla scuola di Castelnuovo aveva stretto relazione con un tal compagno di nome Giuseppe Turco, il quale lo aveva condotto a far conoscenza della propria famiglia, cui apparteneva una vigna posta nella regione detta Renenta, confinante col podere Susambrino. In quella vigna Giovanni sovente si ritirava come luogo più lontano dalla strada che attraversava la valle e quindi più tranquillo. Saliva sopra un rialto, donde poteva vedere chiunque fosse nella sua vigna e in quella di Turco, e senza essere veduto faceva la guardia all’uva col suo libro in mano. Il padre di Giuseppe Turco incontrandosi frequentemente con lui, cui portava uno speciale amore, gli metteva la mano sul capo, dicendogli: – Fa coraggio, Giovannino: sta molto buono e studia che la Madonna ti aiuterà.
– In lei ho riposta tutta la mia fiducia, rispondeva Giovanni; ma mi trovo sempre nell’incertezza: vorrei continuare i corsi di latinità e farmi prete. Mia madre non ha mezzi per aiutarmi.
– Non aver timore, caro Giovanni; vedrai che il Signore ti spianerà la strada.
– Io lo spero, conchiudeva Giovanni – e congedandosi andava al solito posto, col capo chino, ripetendo: Ma…. ma…
Ed ecco, dopo qualche giorno, il signor Turco e suo figlio lo vedono tutto allegro correre e saltellare per la loro vigna e loro presentarsi festosamente. – Che hai, Giovannino, gli chiese il proprietario, che sei così allegro, mentre da un po’ di tempo ti vedeva tanto pensieroso?
– Buone nuove, buone nuove, esclamò Giovanni: stanotte ho fatto un sogno, nel quale io vidi che avrei continuato gli studi, mi sarei fatto prete, e mi troverei posto a capo di [244] molti giovanetti, della cui educazione mi occuperei pel resto della mia vita. Ed ecco ora tutto bell’e fatto; io presto potrò essere prete.
– Ma questo non è che un sogno, osservò il sig. Turco; e poi dal detto al fatto c’è un bel tratto.
– Oh! il resto è nulla, concluse Giovanni. Sì, io mi farò prete, sarò alla testa di tanti e tanti giovanetti, cui farò molto del bene. – Così dicendo, tutto contento, se ne andò alla vedetta.
All’indomani, ritornando dalla parrocchia, ove erasi recato ad assistere alla santa Messa, fu a visitare la famiglia Turco; e la signora Lucia, chiamati i suoi fratelli, coi quali egli veniva sovente ad intrattenersi, lo interrogò sulla cagione che gli faceva risplendere in volto tanta gioia. Egli ripetè come avesse fatto un bel sogno. Pregato a raccontarlo, accennò di aver visto venire verso di sè una gran Signora che conduceva un numerosissimo gregge, e che avvicinandosi a lui e chiamandolo per nome, gli aveva detto: – Ecco, Giovannino; tutto questo gregge lo affido alle tue cure. – E come farò a tener custodia ed aver cura di tante pecore e di tanti agnelletti? Ove troverò io i pascoli, nei quali condurli? – La Signora gli rispose Non temere; io ti assisterò. – E sparì.
Questa narrazione ci venne fatta dallo stesso signor Giuseppe Turco e dalla signora Lucia, e pienamente armonizza con una linea delle sue memorie, nella quale sono scritte queste semplici parole: A 16 ho fatto un altro sogno. Io son certo che vide e seppe molte cose più che non disse per dar sfogo alla piena che riempivagli il cuore; ed era questo un segno del premio meritato colla sua perseverante fiducia. L’assistenza infatti della Madre Celeste in questo stesso anno doveva rendersi sensibile [245] Margherita, dolente che il figlio avesse già perduto tanto tempo, prese la risoluzione di mandarlo a Chieri e d’inscriverlo nelle pubbliche scuole pel prossimo anno. Col solito sorriso gliene diede il lieto annunzio, e cominciò a preparargli il corredo necessario. Ma Giovanni, accortosi che le strettezze famigliari la mettevano in qualche imbarazzo, senz’altro le disse: – Se voi siete contenta, io mi prendo due sacchi e mi presento ad ogni famiglia della nostra borgata per fare una colletta. – Margherita acconsentì. Era questo per Giovanni un sacrifizio assai duro d’amor proprio, dovendo chiedere la carità per se stesso; ma vinse la ripugnanza e si sottomise all’umiliazione. Erano i primi passi in quella difficile via, che avrebbe dovuto percorrere fino all’ultimo suo respiro. “Quanto più sei grande, umíliati in tutte le cose, e troverai grazia dinanzi a Dio”[64]. Avendo accettata l’umiliazione, Dio lo ha esaltato. Andò pertanto a bussare alle singole porte della borgata di Morialdo, accolto dalle madri come un figlio, dai giovanetti come un fratello; espose il bisogno nel quale si trovava e raccolse pane, formaggio, meliga e qualche emina di grano. Così scarsa provvista di vettovaglie non poteva certamente bastare. Una donna della borgata dei Becchi, recatasi in quei giorni nel paese, deplorava fortemente in piazza che il parroco non trovasse modo di far studiare un giovane, il quale a suo giudizio riusciva miglior oratore degli stessi preti della parrocchia. Le persone, che udivano quei lamenti, la interruppero esortandola a recarsi dal prevosto ad esporre a lui stesso quelle osservazioni. La buona donna accettò il consiglio, e senz’altro fu in canonica. D. Dassano, che nulla sapeva della determinazione di Margherita, persuaso che [246] Giovanni avrebbe continuato gli studi in Castelnuovo, prese in considerazione la cosa. Recatosi a visitare alcuni signori, raccolse una certa somma e la mandò a Margherita. Fu ricevuta da lei con viva riconoscenza e se ne servì per comprare alcuni oggetti di vestiario che ancora mancavano.
Margherita intanto si dava premura di trovar persone veramente cristiane, presso le quali potesse con sicurezza collocare in pensione il suo Giovanni. Probabilmente per suggerimento del prevosto scelse la casa di una sua compatriota, Lucia Matta, vedova con un sol figlio studente, la quale recavasi appunto in Chieri per assister e vegliare sul suo fanciullo. Fu stabilita la pensione di lire mensili ventuna; ma siccome Margherita non poteva pagare l’intera somma, si convenne che Giovanni mettesse il restante coll’adempiere agli uffici di servitore, come portar acqua, legna, stendere la biancheria di bucato e altri somiglianti lavori.
Giovanni non tardava a recarsi dal prevosto non solo per manifestargli la riconoscenza, della quale era pieno il sensibilissimo suo cuore, ma eziandio per ottemperare al regolamento scolastico. Uno studente per essere accettato nelle scuole regie, ossia per ottenere l’Admittatur, doveva provvedersi di un’attestazione del parroco del suo domicilio, nella quale fosse dichiarato essersi desso presentato a lui e aver dato il proprio nome. Quest’atto sottometteva il giovane alla speciale vigilanza del parroco, dal voto del quale dipendeva poi il proseguimento negli studi; ragione per cui gli studenti di allora erano rispettosi verso dell’autorità ecclesiastica, il buon esempio del paese, la consolazione della famiglia.
CAPO XXVIII.
Partenza di Giovanni per Chieri – Bontà dei professori – Le prime tre classi di grammatica – Aneddoti di non facile spiegazione.
GIOVANNI aveva superata la prova, alla quale lo volle sottoporre la benignità del Signore. Cambiata più volte stanza a Morialdo, a Capriglio, a Moncucco, a Castelnuovo, avuto agio di studiare le propensioni, i difetti e costumi dei giovanetti nelle solitarie cascine, nelle borgate, nei piccoli paesi e nei grossi borghi, viene ora condotto in una città, ove turbe di fanciulli studenti ed artigiani gli daranno agio per nuove osservazioni necessarie a sempre meglio conoscere il campo che egli deve coltivare. Lunga e spinosa è la sua via, ma quanto fruttuosa! “Chi non è stato tentato (dalle tribolazioni) che sa egli? L’uomo sperimentato in molte cose, sarà molto riflessivo: e colui che ha imparato molto, discorrerà con prudenza. Chi non ha esperienza, fa poche cose; ma colui che è stato in molti luoghi, acquista molta sagacità”[65].
Giovanni però deve ancora esperimentare in sè la vita dello studente colle sue angustie, difficoltà, pericoli, privazioni, [248] perchè sappia sostenere, soccorrere, compatire, provvedere, consolare coloro, che come lui debbono giungere alla carriera sacerdotale, seguendo senza esitazione un sentiero sparso di croci. La vita degli studenti a que’ tempi non era così facile come ai giorni nostri, nei quali vi sono molti collegi ed ospizi, ove i giovani d’ingegno e di buona volontà trovano facilmente ricovero e sono mantenuti gratuitamente o semigratuitamente. D’altronde i ristretti commerci limitavano i beni di fortuna dei genitori. Quindi primo pensiero per le genti di campagna, i cui figli desideravano di farsi prete o intraprendere altra carriera di studi, si era quello di cercare un luogo ove collocarli. Talora si mettevano due o tre in una stessa stanza, presso qualcuno che si prendesse cura di sorvegliarli; per lo più si accomodavano in strette soffitte o da soli o con qualche compagno. La pensione o il fitto era pagato con alcune misure di cereali o di civaie, o con una o due brente di vino, od anche col prestare certi servigi pattuiti. Il vitto o semplicemente la minestra veniva somministrata dal padrone di casa, oppure i parenti inviavano loro settimanalmente il pane necessario. Sovente i giovani partivano dal paese con qualche sacco di farina, di meliga, di patate, di castagne, e ciò doveva loro servire di nutrimento tutto l’anno. Per quanto facesse freddo nei più rigidi inverni, non si parlava di fuoco, giacchè costava assai la legna. Ciò che mancava, i poveri studenti dovevano in qualche modo procurarselo o col trascrivere carte, o col far ripetizioni od altro, coll’occupare in somma qualche ora del giorno in cose diverse delle materie scolastiche. E noi infatti vedremo Giovanni, che per alleviare la madre sua da una spesa molto pesante, impiegherà una gran parte del giorno in cose non certamente profittevoli a’ suoi studi. Di qui pure la ragione del suo studiare alla notte, come anche del gettarsi ad un genere di vita da lui chiamata [249] dissipata, ma che, se si considera con attenzione ne’ suoi effetti, la si deve dire piuttosto provvidenziale.
Il giorno dopo la Commemorazione dei Defunti dell’anno 1831, Margherita consegnava a Giovanni due emine di grano e mezza di miglio, perchè con questo incominciasse a pagarsi la pensione: – E tutto quello che posso darti, gli disse; a ciò che manca penserà la Provvidenza! – Giovanni Becchis, desideroso di dare al caro amico prova del suo affetto, non avendo cosa alcuna da donargli, venne a caricare sopra il suo carro il baule del corredo e i sacchi di grano e di miglio e glieli condusse gratuitamente a Chieri. Il dì seguente Margherita, posto sulle spalle di Giovanni un sacchetto di farina e uno di granturco per venderli sul mercato di Castelnuovo e far qualche soldo, onde comprare carta, libri e penne, con lui partì, mentre il fratello Giuseppe auguravagli buona fortuna.
In Castelnuovo s’incontrarono con Giovanni Filippello, che aveva la stessa età di Bosco. Margherita, dovendo sbrigare in paese alcuni affari, pregò Filippello ad accompagnare fino a Chieri suo figlio, ove essa non avrebbe tardato a raggiungerlo. Filippello acconsentì, e, ricevuti pochi soldi da Margherita, si mise in viaggio con Giovanni. Dopo due ore di cammino, giunti ad Arignano, sedettero per riposarsi alquanto. Bosco aveva narrato al compagno degli studi già fatti, delle belle cose imparate assistendo alle prediche, alle istruzioni ed ai catechismi, gli proponeva opere di carità da praticare e gli narrava fatti edificanti con opportune riflessioni. A un certo punto Filippello lo interruppe dicendogli: – Vai solo ora a studiare in collegio e sai già tante cose? Presto diventerai parroco! – Bosco, fissandolo attentamente in volto, gli rispose: – Parroco? Sai tu che cosa voglia dire essere parroco? Sai quali sieno i suoi obblighi? Quando egli s’alza dal pranzo o [250] dalla cena, deve riflettere: io ho mangiato, ma e le mie pecorelle hanno tutte avuto da sfamarsi? Ciò che egli possiede oltre il suo bisogno, deve darlo ai poveri. E poi quante altre e gravissime responsabilità! Ah! caro Filippello, io non mi farò parroco. Vado a studiare, perchè voglio consecrare la mia vita pei giovanetti. – Ciò detto, si rimisero in marcia fino a Chieri. Filippello camminava come assorto nel pensiero dello spirito di carità che animava quel suo diletto compagno. D. Bosco stesso ricordava questo dialogo al medesimo Filippello nel 1884, dicendogli: – Mi sono fatto parroco? Margherita non tardò a raggiungere il suo Giovanni, e nel presentarlo alla signora Lucia Matta, che doveva ospitarlo, e deponendo innanzi a lei i sacchi di cereali: – Qui c’è mio figlio, disse; qui c’è la pensione. Io ho fatta la mia parte, mio figlio farà la sua, e spero che non sarete malcontenta di lui – E commossa, ma piena di gioia, se ne ritornò alla sua cascina.
La città di Chieri, lontana da Torino sedici chilometri, a levante, è posta in una pianura dolcemente inclinata verso scirocco, ai piedi di amene colline che da tre lati la circondano. Riparata dai venti boreali, gode di un cielo saluberrimo. Per sei porte si entra nelle sue belle vie, ricche di molte chiese, di palagi, di conventi e monasteri; di istituti d’educazione per la gioventù, fra cui il Seminario e il Collegio per le scuole pubbliche stabilito nell’antico convento dì S. Chiara, e di vari; monumenti che ricordano le glorie passate. Due sono le parrocchie: S. Maria della Scala e S. Giorgio. Nei tempi, dei quali scriviamo, novemila erano i suoi abitanti. In venti fabbriche lavoravano il cotone circa quattro mila operai e diverse filature di seta ne impiegavano cinquecento. I suoi mercati erano fra i più cospicui del Piemonte. [251]
A chi era stato allevato tra i boschi e appena aveva visto qualche paesello di provincia, pare dovesse far grande impressione il trovarsi in quella città. Ma Giovanni non si lasciò distrarre dai nuovi spettacoli. Se fin da fanciullo era stato geloso nell’occupare il tempo per darlo alle sue letture; tanto più ora che dipendeva solamente da lui raggiungere la meta prefissagli, armossi di tale energia di volontà, da non ammettere inconsulte divagazioni. Egli stesso scrive: “La prima persona che conobbi fu il sacerdote D. Eustachio Valimberti, di cara ed onorata memoria. Egli mi diede molti buoni avvisi sul modo di tenermi lontano dai pericoli: mi invitava a servirgli la Messa, e ciò gli porgeva occasione di darmi sempre qualche buon suggerimento. Egli stesso mi condusse dal prefetto delle scuole, P. Sibilla domenicano, e mi pose in conoscenza cogli altri miei professori. Intanto erano incominciate le scuole. Siccome gli studi fatti fino allora erano un po’ di tutto, che riuscivano quasi a niente, avendo bensì molte utili cognizioni, ma disordinate ed imperfette, così fui consigliato a mettermi nella sesta classe, che oggidì corrisponde alla classe preparatoria alla prima ginnasiale. Il maestro di allora, T. Pugnetti, anch’esso di cara memoria, mi usò molta carità. Mi accudiva nella scuola, mi invitava a casa sua, e mosso a compassione della mia età e della buona volontà, nulla risparmiava di quanto poteva per giovarmi.
Ma la mia età e corporatura mi faceva comparire come un alto pilastro in mezzo a’ miei compagni. Ansioso di togliermi da quella posizione, dopo due mesi di sesta classe, avendone raggiunto il primo posto, venni ammesso all’esame e promosso alla classe quinta. Entrai volentieri nella classe novella, perchè i condiscepoli erano più grandicelli e poi aveva a professore la cara persona di D. Valimberti. Passati altri due mesi, essendo eziandio riuscito più volte il primo [252] della classe, fui per via eccezionale ammesso ad altro esame e quindi promosso alla quarta che corrisponde alla nostra seconda ginnasiale.
In questa classe era professore Giuseppe Cima, uomo severo per la disciplina. Al vedersi un allievo alto e grosso al par di lui comparire nella sala a metà dell’anno, scherzando disse in piena scuola: – Costui o che è una grossa talpa, o che è un gran talento. Che ne dite? – Tutto sbalordito da quella severa presenza: – Qualche cosa di mezzo, risposi: è un giovane che ha buona volontà di fare il suo dovere e progredire negli studi. – Piacquero quelle parole al professore, il quale con insolita affabilità soggiunse: – Se avete buona volontà, voi siete in buone mani; io non vi lascierò inoperoso. Fatevi animo, e se incontrerete difficoltà, ditemele tosto, chè io ve le appianerò. – Lo ringraziai di cuore.
Era da circa due mesi in questa classe, quando un piccolo incidente fece parlare alquanto di me. Un dì il professore spiegava la vita di Agesilao, scritta da Cornelio Nipote. In quel giorno non aveva meco il libro, avendolo dimenticato a casa; e per celare al maestro quella dimenticanza, tenevami davanti il Donato aperto. Siccome non sapeva su che cosa stare attento, mentre badava alle parole del maestro, volgeva i fogli ora da una parte ora dall’altra. Se ne accorsero i compagni. Uno incominciò, l’altro continuò a ridere a segno che la scuola era in disordine: – Che c’è? chiese il precettore: che c’è? mi si dica sull’istante! – Siccome l’occhio di tutti stava rivolto verso di me, egli mi comandò di fare la costruzione e ripetere la stessa sua spiegazione. Mi alzai allora in piedi e, tenendo tuttora il Donato tra mano, ripetei a memoria il testo, la costruzione con tutti i commenti fatti dal maestro poc’anzi. Quando ebbi finito, i compagni quasi [253] istintivamente, mandando voci di ammirazione, batterono le mani. Non è a dire a quale furia si lasciasse andare il professore; perchè quella era la prima volta che, secondo lui, non poteva tenere la disciplina. Mi diede uno scappellotto, che io scansai piegando il capo; poi tenendo la mano sul mio Donato, si fece dire dai vicini la cagione di quel disordine. Costoro, mentre io era per esporre umilmente la cosa al maestro, dissero: – Bosco ebbe sempre davanti a sè il Donato, ed ha letto e spiegato come se tra mano avesse avuto il libro di Cornelio. – Il professore prese difatto il Donato, mi fece ancora continuare due periodi, e poi all’istante passando dalla collera allo stupore ed all’ammirazione mi disse: – Per la vostra felice memoria vi perdono la dimenticanza che avete fatta: siete fortunato; procurate soltanto di servirvene in bene”.
Ma, nei quattro anni di ginnasio, oltre l’ingegno e la memoria, pare fosse in Giovanni un’altra virtù segreta e straordinaria che l’aiutava. Così opinarono quelli fra i suoi antichi condiscepoli, che ci narrarono i fatti seguenti. Una notte sognò che il maestro aveva dato il lavoro dei posti e che egli stava eseguendolo. Appena svegliato, balzò dal letto e scrisse quel lavoro, cioè il dettato latino; poi si mise a tradurlo e in ciò si fece aiutare da un prete suo amico. Che è che non è, al mattino il professore diede di fatti nella scuola il lavoro dei posti, e precisamente quello stesso tema sognato da Giovanni; dimodochè, senza più usare vocabolari, nè impiegarvi molto tempo, scrisse subito il suo lavoro tale quale si ricordava di averlo fatto nel sogno e gli era stato corretto, e riuscì ottimamente. Interrogato dal maestro, gli espose la cosa ingenuamente, cagionandogli così vivo stupore.
Un’altra volta Giovanni consegnò la pagina del lavoro così presto, che non sembrava possibile al maestro che un giovane avesse potuto in sì breve tempo superare tante [254] difficoltà grammaticali; perciò lesse attentamente quel foglio. Strabiliando nel trovarlo perfetto, comandò che gli portasse la brutta copia nel quaderno. Giovanni gliela diede. Qui nuovi stupori. Il maestro avea preparato quel tema solo nella sera antecedente, ed essendogli riuscito troppo lungo, ne aveva dettato solamente la metà: nel quaderno di Giovanni lo trovò tutto intero, nè una sillaba di più, nè una di meno. Come era andata questa faccenda? Non era possibile che in quel breve tempo Giovanni l’avesse tracopiato, e neppure poteva esservi il minimo dubbio che fosse penetrato nell’abitazione del professore, assai distante da quella ove egli era in pensione. Dunque?… Bosco lo confessò: – Ho sognato. – Per questi e per altri somiglianti avvenimenti, i compagni di pensione lo chiamavano il sognatore.
Io non giudico di questi fatti, nè vado per ora a cercarne la spiegazione. Un’insistente tradizione li perpetuò nell’Oratorio. D. Bosco interrogato non dissentì, anzi di molti altri consimili e di una incomparabile magnificenza a noi faceva racconto. Lo storico della vita di D. Bosco non può passarli sotto silenzio, perchè sarebbe lo stesso che scrivere la storia di Napoleone I senza far cenno di alcuna delle sue vittorie. Il nome D. Bosco e la parola sogno sono correlativi; e se queste pagine li mettessero in oblio, sorgerebbero a migliaia e migliaia le voci degli antichi allievi a chiedere: – E i sogni? – E fu mirabile infatti il ripetersi in lui quasi continuo per sessant’anni di questo fenomeno. Dopo un giorno di pensieri, di progetti, di lavori, posata la stanca sua testa sul capezzale, entrava in una nuova regione di idee e di spettacoli, che lo affaticavano fino all’alba. A questo succedersi della vita ideale alla vita reale nessun altro uomo avrebbe potuto reggere senz’alterazione di mente: D. Bosco invece fu sempre calmo e calcolatore in tutte le sue azioni. [255]
Ho presenti le ammonizioni dell’Ecclesiastico: “Le vane speranze e le menzogne sono per lo stolto, e quindi i sogni levano in alto gli imprudenti. Come chi abbraccia l’ombra e corre dietro al vento, così chi bada a false visioni… I sogni dei malvagi sono vanità… Il tuo spirito eziandio sarà soggetto a fantasmi. Non prenderti cura di tali cose, eccetto che fosse mandata dall’Altissimo la visione. Perciocchè molti furono indotti in errore dai sogni e si perderono per aver in essi posta fidanza. La parola della legge sarà perfetta senza queste menzogne, e la sapienza sarà facile e piana nella bocca dell’uomo fedele”[66]. Sta bene; ma è vero eziandio che la bontà paterna del Signore nel Vecchio Testamento e nel Nuovo e nel corso della vita di innumerevoli Santi per mezzo di sogni diede conforto, consiglio, comando, spirito di profezia, voce di minaccia, di speranza, di premio sia per gli individui come per le intiere nazioni. A questa classe appartengono forse i sogni di D. Bosco? Ripeterò: io non giudico: vi è chi deve giudicare. Dico solamente che la vita di D. Bosco è un intreccio di avvenimenti così meravigliosi che non si può misconoscere la diretta assistenza divina, restando quindi affatto esclusa l’idea che egli fosse uno stolto, un illuso, un seguace della vanità e della menzogna. Chi visse al suo fianco per trenta e per quarant’anni, non conobbe mai in lui il minimo segno da far sospettare volesse egli guadagnarsi la stima de’ suoi soggetti, facendosi credere privilegiato di doni soprannaturali. D. Bosco era umile e l’umiltà aborre dalle menzogne. I suoi racconti avevano sempre e unicamente per fine la gloria di Dio e la salute delle anime, ed erano di una semplicità che legava i cuori. [256]
Mai udimmo stranezze che indicassero fantasia alterata, o palesassero amore di novità nell’esporre scene riguardanti le verità cattoliche. D. Bosco parlando di questi sogni, ci disse più volte: – Chiamateli sogni, chiamateli parabole, date loro qualsivoglia altro nome che più vi garbi, io sono sicuro che raccontati faranno sempre del bene.
CAPO XXIX.
Prudenza di Giovanni nella scelta degli amici – Aiuta i compagni negli studi – Società dell’Allegria Pratiche di pietà – Fortuna di un buon confessore.
LO SPIRITO SANTO ha detto: “Vivi in amistà con molti, ma prendine uno di mille per tuo consigliere. Se ti fai un amico, lo sia dopo averlo sperimentato, e non ti fidare leggermente di lui; perocchè havvi chi è amico quando gli torna comodo, e non dura ad esserlo in tempo di tribolazione; ed havvi qualche amico, compagno di tavola, il quale sparisce nel giorno della necessità; ed altri che si cangia in nemico; ed altri ancora che metterà fuori l’odio, le acerbe querele e gli strapazzi (manifestando i segreti che gli hai confidati, rendendo pubblici i dissapori, cercando di disonorarti e di metterti in odio presso gli altri). Allontanati da’ tuoi nemici (specialmente quelli dell’anima tua) e sta in guardia anche su gli amici”[67].
Giovanni, guidato dalla sola prudenza, istintivamente seguì queste norme fin dal primo suo affacciarsi alle scuole di Chieri. Così egli scrive: “Nelle prime quattro classi dovetti imparare a mio conto il modo di trattare coi compagni. In mia mente [258] avea divisi costoro in tre categorie: buoni, indifferenti, cattivi. Questi ultimi evitarli assolutamente e sempre, appena conosciuti; cogli indifferenti trattenermi per cortesia e per bisogno; coi buoni contrarre amicizia, ma famigliarità solamente cogli ottimi, quando se ne incontrassero che fossero veramente tali. Questa fu la mia ferma risoluzione. Siccome però in sul principio in questa città non conosceva alcuno, così mi son fatta per allora una legge di non famigliarizzare con alcuno, attento a fuggire le occasioni anche lontane dei pericoli. Tuttavia ho dovuto lottare non poco con quelli che io non conosceva per bene. Taluni volevano guidarmi ad un teatrino; altri a fare una partita al giuoco; altri ad andare al nuoto; qualcuno anche a rubacchiare frutta nei giardini o nella campagna. Un cotale fu così sfacciato, che mi consigliò a rubare alla mia padrona di casa un oggetto di valore a fine di procacciarci dei confetti. Io mi son liberato da questa catena di tristi col fuggire rigorosamente la loro compagnia di mano in mano mi veniva dato di poterli scoprire. Generalmente poi diceva a tutti per buona risposta, che mia madre avevami affidato alla mia padrona di casa, e che, per l’amore che io a lei portava, non voleva andare in nessun luogo, nè fare cosa alcuna senza il suo consenso”.
Questa ferma obbedienza alla buona Lucia tornò utile a Giovanni anche temporalmente; perciocchè ella, vedendolo così diligente in tutti gli umili servigi di casa, che doveva prestare secondo i patti, così assennato, pio e fornito di tante altre belle doti, non potendo essa attendere come avrebbe desiderato alla propria famiglia, distratta troppo da vari negozi, con grande piacere a lui affidò il proprio unico figlio, di carattere assai vivace, amatissimo dei trastulli e pochissimo dello studio, incaricandolo eziandio di fargli ripetizione, sebbene frequentasse la classe superiore alla sua. [259] Giovanni se ne occupò come di un fratello. Colle buone, con piccoli regali, coi trattenimenti domestici e più conducendolo alle pratiche religiose, se lo rese docile, obbediente e studioso, a segno che dopo sei mesi il dissipatello era divenuto si buono e diligente da contentare il suo professore ed ottenere posti di onore in classe. La padrona ne fu lieta assai, e per premio condonò a Giovanni intiera la pensione mensile, somministrandogli il vitto; per cui a Giovanni non restava altra spesa che quella dei libri e delle vestimenta. Per ben due anni egli continuò quest’amorevole e vigilante assistenza al giovanetto. Il servitorello era divenuto istitutore di giovani studenti: la divina Provvidenza lo andava esercitando in un altro ramo della sua futura molteplice missione. In questo egli si eserciterà per tutto il corso de’ suoi studi, non tralasciando però mai di addestrarsi in quegli altri che Iddio gli aveva fatti apprendere precedentemente. La sua attività non aveva requie. Nelle ore che gli studenti sogliono dedicare alla ricreazione, egli affaticavasi in opere manuali. In un laboratorio di falegnami suoi conoscenti, vicino alla sua abitazione, imparò con gran facilità a piallare, squadrare, segare il legno, ad adoperare il martello, lo scalpello, le verrine, sicchè riuscì abile a costrurre mobili, grossolani se si vuole, ma indispensabili per una stanza. Talora lavorava per conto proprio, tal’altra a servigio de’ suoi benefattori; col qual nome chiamò sempre quelli che lo tenevano in pensione.
Intanto i compagni, che volevano tirarlo ai disordini, vedendosi ributtati, non mancarono di sfogare la loro stizza con le solite maniere poco cortesi e talora provocanti, alle quali però Giovanni non diede retta, continuando di contraccambio a trattarli colla solita benevolenza. La sua amorevolezza pertanto inspirò fiducia in costoro, che erano di solito i [260] più trascurati nei doveri, ed incominciarono a far ricorso a lui, pregandolo della carità scolastica, d’imprestare o dettar loro il tema della scuola. Avveravasi propriamente in lui quel detto: “Figliuolo, fa le cose tue con mansuetudine, e oltre la gloria avrai l’amore degli uomini.”[68]. Giovanni accondiscese; ma spiacque tal cosa al professore, il quale la proibì severamente, giacchè quella falsa benevolenza fomentava la loro pigrizia. Questa proibizione così giusta contrariava l’affetto che Giovanni portava a’ suoi condiscepoli. Avvenne un giorno che i suoi compagni di pensione, non sapendo o non potendo fare il compito, lo pregarono a volerneli aiutare con imprestare loro il suo. Giovanni, non volendo disobbedire al maestro e d’altra parte non potendo soffrire che i suoi compagni coll’andare a scuola senza compito dovessero subire il castigo, ne pensò una bella: lasciò la pagina sul tavolino di studio, e poi senz’altro si ritirò. I compagni, approfittando di sì propizia occasione, si gettarono su quella pagina, e in tutta fretta ne copiarono il contenuto. Giunta l’ora della scuola, ciascuno presentò il proprio compito al maestro, il quale si pose a leggerlo. Ma quale dispetto non provò quando, confrontando i vari lavori fra di loro, si avvide che erano tutti perfettamente eguali! Naturalmente il suo sospetto cadde su Giovanni, il quale interrogato affermò non aver trasgredito gli ordini dati; soggiunse che, avendo lasciata la propria pagina sul tavolino, non era improbabile che fosse stata copiata. Il maestro, conoscendo l’indole sua, capì tutto e non, potè a meno che ammirare ad un tempo la sua obbedienza, il suo buon cuore e la sua furbizia. Terminata la scuola, gli disse: – Non sono dispiacente di ciò che hai fatto; ma non [261] farlo più un’altra volta. – Il maestro intendeva benissimo come Giovanni con carità industriosa, servizievole e pronta pure a sacrifici cercasse di tirare al bene quei compagni.
Allora Giovanni si appigliò ad un’altra via più profittevole, vale a dire, a spiegare ai compagni le difficoltà che trovavano ed anche ad aiutare quelli cui fosse mestieri. Per tal modo egli recava piacere a tutti e di tutti si cattivava la benevolenza, l’affezione e la stima. Essi pertanto cominciarono a venire per ricreazione, poi per ascoltare racconti, poi per compiere i doveri di scuola; finalmente anche senza motivo venivano a lui, come i compagni di Morialdo e, di Castelnuovo. Per dare un nome a quelle riunioni, solevano chiamarle Società dall’Allegria: nome che assai bene si conveniva, perchè ciascuno era obbligato a cercare quei libri, introdurre quei discorsi e trastulli che avessero potuto contribuire a stare allegri; per contrario era proibita ogni cosa che cagionasse melanconia, e specialmente checchè non fosse secondo la legge del Signore. Chi pertanto avesse bestemmiato, o nominato il nome di Dio invano, o fatti cattivi discorsi, era immediatamente allontanato dalla società come indegno di appartenervi. Giovanni trovavasi alla testa di quella moltitudine di compagni. Di comune accordo furon posti per base di quella cara società i due articoli seguenti:
1 Ogni membro della Società dell’Allegria deve evitare ogni discorso, ogni azione che disdica ad un buon cristiano.
2 Esattezza nell’adempimento dei doveri scolastici e dei doveri religiosi.
Fra i componenti la Società dell’Allegria Giovanni ne potè rinvenire alcuni veramente esemplari. Meritano di essere nominati Guglielmo Garigliano di Poirino e Paolo Braja di Chieri. Il giovane Paolo Vittorio Braja era nato in Chieri il giorno 17 giugno dell’anno 1820, da Filippo Braja e [262] Catterina Cafasso da Brusasco. Giovanetto era stato educato in casa, sotto la guida amorevole dello zio paterno canonico Giacinto Braja. Più tardi frequentò le scuole municipali, in cui fu caro ai superiori e maestri e segnalato esempio di studio e pietà ai condiscepoli. Di memoria e perspicacia non comune, al discernimento univa una prudenza superiore all’età sua. A dieci anni, andava già manifestando il desiderio di percorrere gli studi per avviarsi alla carriera sacerdotale. Si dilettava di ripetere le prediche udite. Un giorno per eccitamento dei parenti ed amici, studiò un intero discorso, e in un’adunanza di molta gente, salito sopra di un pulpito preparato all’uopo, declamò con tanta grazia, che lo si sarebbe creduto provetto oratore, riscuotendo l’ammirazione ed il plauso di quanti vollero essere presenti a tale esercizio. Soventi volte raccomandava agli amici e parenti di evitare il lusso e la moda, dicendo che l’arciprete Fosco molto insisteva su tal materia, asserendo che il lusso è un laccio del demonio. Applicava molto a proposito le parole udite, e se ne serviva per dar consigli agli amici e molte volte si dimostrava caritatevole consolatore degli afflitti.
Scrive D. Bosco: “Garigliano e Braja partecipavano volontieri all’onesta ricreazione, ma in modo che la prima cosa a compiersi fossero sempre i doveri di scuola. Amavano ambedue la ritiratezza e la pietà, e mi davano costantemente buoni consigli. Tutte le feste, dopo la congregazione del collegio, andavamo alla chiesa di S. Antonio, dove i PP. Gesuiti facevano uno stupendo catechismo, in cui raccontavansi parecchi esempi così ben scelti da ricordarsene per tutta la vita. Lungo la settimana poi la Società dell’Allegria si raccoglieva in casa di uno dei soci per parlare di religione. A questa radunanza interveniva liberamente chi voleva. Garigliano e Braja erano dei più puntuali. Ci trattenevamo alquanto in [263] amena ricreazione, in pie conferenze, letture religiose, in preghiere, nel darci buoni consigli e nel notarci a vicenda quei difetti personali, che ciascuno avesse osservato o dei quali avesse da altri udito parlare. Senza che allora il sapessimo, mettevamo in pratica il sublime avviso: Beato chi ha un monitore. E quello di Pitagora: Se non avete un amico che vi corregga i difetti, pagate un nemico che vi renda questo servizio. E quell’altro dello Spirito Santo: “È migliore una aperta riprensione, che un amore che si nasconde; sono migliori le ferite che vengono da chi ama, che i falsi baci di chi odia”[69]. Oltre a questi amichevoli trattenimenti andavamo ad ascoltare le prediche, spesso a confessarci e a fare la santa Comunione”.
Qui è bene ricordare come di quei tempi la religione facesse parte fondamentale dell’educazione. Un professore, che eziandio celiando avesse pronunziato una parola lubrica e irreligiosa, era immediatamente dimesso dalla carica. Se facevasi così dei professori, si può immaginare quanta severità si usasse verso gli allievi indisciplinati e scandalosi!
La mattina dei giorni feriali si ascoltava la santa Messa ed ogni allievo doveva essere fornito di un libro di preghiere e leggerlo divotamente. Al principio della scuola si recitava l’Actiones coll’Ave Maria, dopo dicevasi l’Agimus pure coll’Ave Maria. Nel sabato dovevano tutti recitare la lezione del catechismo assegnata dal direttore spirituale, e sul finire della scuola onorare Maria SS. colle Litanie.
Nei giorni festivi poi gli allievi erano tutti raccolti nella chiesa della congregazione. Mentre i giovani entravano, si faceva lettura spirituale, cui seguiva il canto dell’Ufficio della Madonna; dipoi la Messa; quindi la spiegazione del Vangelo.[264]
La sera catechismo, con l’obbligo ad ogni alunno di rispondere alle interrogazioni fatte dal direttore spirituale, vespro, istruzione. Ciascuno doveva accostarsi ai SS. Sacramenti; e per impedire la trascuratezza di questi importanti doveri erano obbligati a portare una volta al mese il biglietto di Confessione e a Pasqua il biglietto della santa, Comunione. Chi non avesse adempiuto a quest’obbligo, non era più ammesso agli esami alla fine dell’anno, sebbene fosse dei migliori nello studio. Coloro che il direttore spirituale licenziava dalla congregazione perchè disobbedienti o perchè ignoravano il catechismo, erano eziandio espulsi dalle scuole.
Era prescritto un triduo di preparazione alle Feste del Santo Natale, nel quale si tenevano due prediche al giorno, si assisteva alla santa Messa, si recitava l’Ufficio della Beata Vergine e le preci della novena. Nella quaresima, tutti i giorni di scuola gli studenti dovevano intervenire al catechismo, che precedeva l’ora consueta delle lezioni. Ogni anno, per cinque giorni, dal Venerdì detto di Passione al Martedì Santo, tutti insieme si radunavano per gli esercizi spirituali, con due meditazioni e due istruzioni quotidiane, e si poneva termine a questo raccoglimento spirituale colla Comunione pasquale. I singoli giovani dovevano procurarsi la dichiarazione di avere atteso regolarmente a questi esercizi.
Tale era l’ordinamento religioso degli studi secondari promulgato da Re Carlo Felice, con le regie patenti del 23 luglio 1822. Si partiva dal principio che la scuola doveva essere religiosa, essendo Iddio il fondamento della scienza e di ogni moralità. L’istruzione era posta sotto l’ispezione del Vescovo e i maestri non potevano assumere, nè proseguire l’insegnamento senza che ogni anno presentassero un certificato del proprio Vescovo, in cui si attestasse aver essi tenuta una lodevole condotta e aver esercitato il loro ufficio [265] nel modo che si conveniva al bene della Religione e dello Stato. Da un pericolo mortale erano eziandio difesi i giovani d’allora, nel quale oggigiorno s’imbattono ad ogni piè sospinto. Le sêtte avevano incominciato a introdurre e diffondere nel Regno gran copia di pubblicazioni irreligiose, immorali e sovversive; ma il Re Carlo Alberto non tardava a porvi riparo. Nel settembre 1831 aveva creata una commissione composta di cinque membri coll’incarico di vegliare che nei suoi Stati non s’introducessero queste pestilenze; e i suoi ordini vennero eseguiti con zelo.
Non è quindi a dire quanto i maestri sorvegliassero sulle letture degli alunni. Scrive D. Bosco: “Questa religiosa, severa disciplina produceva maravigliosi effetti. Si passavano anche più anni, senza che si udisse una bestemmia o cattivo discorso. Gli allievi erano docili, rispettosi tanto nel tempo di scuola, quanto nelle proprie famiglie. E spesso avveniva che in classi numerosissime alla fine dell’anno erano tutti promossi a classe superiore. Nella terza, umanità e retorica i miei condiscepoli furono sempre tutti promossi. La più fortunata mia avventura fu la scelta di un confessore stabile nella persona del teologo Maloria, canonico della Collegiata di Chieri. Egli mi accolse sempre con grande bontà, ogni volta che andava da lui. Anzi mi incoraggiava a confessarmi e comunicarmi con maggior frequenza. Era cosa assai rara in quei tempi trovare chi incoraggiasse alla frequenza dei Sacramenti. Non mi ricordo che alcuno de’ miei maestri mi abbia tal cosa consigliata. Chi andava a confessarsi e a comunicarsi più di una volta al mese, era giudicato dei più virtuosi; e molti confessori non permettevano. Io però mi credo debitore a questo mio confessore, se non fui dai compagni trascinato a certi disordini, che gli inesperti giovanetti hanno pur troppo a lamentare nei grandi collegi”.
CAPO XXX.
Giovanni conduce i compagni alla chiesa ed ai Sacramenti – Le passeggiate nei giorni di vacanza – Sua particolar divozione alla Madonna – Affetto per la famiglia – Morte di Paolo Braja – Giovanni ritorna a Castelnuovo.
GIOVANNI, premuroso del proprio profitto spirituale e di quello de’ compagni, animavali alla frequenza delle sacre funzioni e dei SS. Sacramenti nei giorni festivi, e colle sue belle maniere riusciva ad attirare alla chiesa eziandio quelli non ascritti alla Società dell’Allegria. Alla domenica poi, compiuti tutti i doveri del buon cristiano, e nei giorni di vacanza, per toglierli dall’ozio e salvarli dalle compagnie meno buone, preparava loro adattati divertimenti e intrattenevali con giuochi di prestigio, dei quali andavano pazzi, e che egli aveva imparati a bello studio per animarli al bene. Per questo egli era venerato da’ suoi colleghi come capitano di un piccolo esercito.
Non di rado conduceva i suoi amici a fare passeggiate, preferibilmente fuori di città, ed esse avevan sempre per termine la visita di qualche parrocchia o santuario, ove si entrava per adorare Gesù in Sacramento e salutare l’immagine [267] della SS. Vergine. S’inoltravano fra le belle colline che circondano Chieri, e, passando di paese in paese, talmente prolungavano, con grande piacere, le loro gite, che tornavano a casa, trascorsa da lunga pezza l’ora del pranzo.
Alle volte, sul far dell’alba, si andava pei boschi di Superga a cogliere funghi, ed ivi si passavano le giornate intere. Era un chiamarsi a vicenda dalla cima dei poggi, un rispondersi dal fondo dei burroni: erano grida prolungate, ripetute di gioia, e di quando in quando un cantare spensierato. Chi riempiva di funghi il cappello, chi faceva sacca colle maniche della giubba legandole alle estremità, e chi se ne rimpinzava il seno. Tornavano a casa sull’annottare stanchi, rossi in volto pel lungo correre, sudati ed allegri e con una fame da disgradar quella di un eschimese.
Talora poi si ficcavano in capo di andar fino a Torino per vedere il cavallo di bronzo in piazza S. Carlo, o quello di marmo nella scala del palazzo reale. Partivano da Chieri, come se andassero alla conquista del mondo, con un pezzo di pane in saccoccia; giunti a Torino, con quattro soldi di castagne si provvedevano il companatico. Si portavano sul luogo, davano un’occhiata alla statua, poi visitavano una chiesa e si rimettevano in cammino pel ritorno pienamente soddisfatti. Ci vuol poco per divertire cuori semplici ed innocenti!
In quest’anno per ben due volte fatti straordinari attiravano alla capitale del Piemonte le moltitudini dei paesi circonvicini. Il giorno 1 aprile Mons. Luigi Fransoni, eletto Arcivescovo di Torino con Bolla del 24 febbraio, prendeva possesso della sua nuova sede con pompa solennissima. Più tardi, nel mese di luglio, veniva consegnata al santuario della Consolata la statua in argento fuso della Madonna tenente in braccio il Celeste Bambino, che Re Carlo Felice [268] aveva commessa a distinti orefici, aggiungendo egli ciò che mancava alle oblazioni dei fedeli; e con questa due corone d’oro, omaggio della Regina Vedova Maria Cristina. Quale spettacolo di divozione, quando questa sacra effigie brillò la prima volta ai raggi del sole nella processione annuale, che tutt’ora si può considerare come festa di tutto il Piemonte! E Giovanni non dovette mancarvi: egli stesso ci narrò che troppo eragli caro il santuario di Maria Consolatrice.
Egli non dimenticava mai la gran parola di sua madre, quando avealo condotto alle scuole di Castelnuovo: – Sii divoto della Madonna! – E però in Chieri prediligeva la chiesa di S. Maria della Scala, volgarmente detta il duomo, per l’ampiezza e magnificenza delle tre navate più vasta di tutte le cattedrali del Piemonte, e fiancheggiata da ventidue altari in splendide cappelle. Quivi, sotto quelle alte ed antichissime volte di stile gotico, si avanzava ogni giorno Giovanni, infallantemente mattino e sera, e andava ad inginocchiarsi dinanzi all’icona di Nostra Signora delle Grazie, per porgerle omaggio di affetto figliale e per ottenere tutti i favori necessari a riuscir bene nella missione che Essa stessa aveagli affidato. Finchè fu studente in Chieri, perseverò fedele in questa pia pratica. E non leggiero stimolo a frequentare detta chiesa, anche in altre ore, essergli doveva la cara presenza e il contegno angelico del seminarista Giuseppe Cafasso al servizio dell’altare nelle funzioni solenni e la sua ammirabile carità nell’insegnare il catechismo ai fanciulli.
Al mese di maggio poi, per offrire alla sua Madre Celeste il più caro mazzo di fiori, raccoglieva i giovani più discoli e li menava a confessarsi nella sopraddetta chiesa, offiziata da dieci canonici, fra i quali v’era pure il suo confessore. [269]
La sua virtù esercitava sui cuori un ascendente irresistibile. La temperanza nel mangiare e nel bere, la mortificazione dei sensi, specialmente degli occhi era tale, da essere segnato a dito come modello di morigeratezza e di purità. Le madri saggie e religiose di Chieri, come già quelle di Morialdo, di Moncucco e di Castelnuovo, desideravano ardentemente che i figli ne frequentassero la compagnia; e coloro che con lui andavano, crescevano sempre più obbedienti e rispettosi verso i loro parenti.
In mezzo a’ suoi studi e alle altre occupazioni, Giovanni non dimenticava la propria famiglia, alla quale ritornava sovente coll’affettuoso pensiero. Verso Antonio, che quest’anno prendeva moglie, non solo non aveva il menomo rancore, ma nudriva una sincera affezione, che sempre conservò per tutto il tempo di sua vita.
Abbiamo detto che spesse volte sognava. Fra le altre, una volta sognò che il fratello Antonio, facendo il pane alla cascina di Madama Damevino, presso casa sua, fosse sorpreso dalla febbre, e che, incontratolo per la strada e interrogatolo, gli aveva risposto: – Mi prese la febbre or ora; non posso più reggermi in piedi; debbo andarmi a riposare. – Raccontò al mattino il sogno a’ suoi compagni, i quali subito esclamarono: – Sta pure certo che avvenne come tu dici. – E fu vero. La sera giunse a Chieri il fratello Giuseppe, cui tosto domandò Giovanni: – Sta meglio Antonio? – Giuseppe meravigliato rispose: – Lo sai già che è ammalato?
– Sì; lo so, replicò Giovanni.
– Credo che sia cosa da poco, aggiunse Giuseppe; lo prese ieri la febbre, mentre stava facendo il pane presso Madama Damevino; ora però sta assai meglio.
Senza dare importanza a questo sogno, noteremo come esso svela i sentimenti più intimi del suo cuore, che lo [270] indussero a beneficare la famiglia del fratellastro, appena ne fu in grado, come attesta D. Michele Rua.
Margherita sovente si recava a Chieri, portando in una cesta pane di frumento e focaccie di meliga, per regalarne il figlio. Qualche volta le teneva dietro Bracco. Il povero cane faceva mille feste al suo padrone; e quando mamma Margherita era in sulle mosse per partire, cercava di nascondersi per rimanere con Giovanni. – Guarda, ripeteva allora mamma Margherita al figlio, guarda quanta fedeltà, quanta obbedienza, quanto amore ed attaccamento ha questo cane al suo padrone. Se noi avessimo solo per metà simile sottomissione e affetto a Dio, come meglio andrebbero le cose del mondo, quanta gloria ne verrebbe al Signore.
Sembrava che quest’anno dovesse scorrere senza pene per Giovanni; ma non fu così. Egli dovette soffrire per la perdita di uno de’ suoi più cari compagni, il giovane Paolo Braja. Vero modello di pietà, di rassegnazione, di viva fede, dopo lunga e penosa malattia, ricevuti i SS. Sacramenti, il giorno 10 luglio, il pio giovanetto spirava l’anima sua bella, che andava così a raggiungere l’angelico S. Luigi, di cui si mostrò seguace fedele in tutta la vita. Parecchi maestri e lo stesso professore canonico Clapiè eransi recati a visitarlo mentre era infermo. Tutto il collegio ne provò rincrescimento: tutti i compagni intervennero in corpo alla sua sepoltura; e non pochi per molto tempo solevano andare con Giovanni in giorno di vacanza a fare la santa Comunione, recitare l’Ufficio della Madonna, o la terza parte del Rosario in suffragio dell’anima dell’amico defunto. Fu compianto da tutti quelli che lo conobbero: parenti, amici, precettori, condiscepoli. Uno dei professori all’udirne la dolorosa notizia esclamò piangendo: – Non ho mai pianto la perdita di alcuno e questo caro giovanetto mi strappa le lacrime! – Il padre [271] suo poi nei registri di famiglia lasciò scritte queste parole: “1832 alli 10 luglio è passato agli eterni riposi Paolo Vittorio Braja, d’anni 12, figlio di me Filippo e della fu Caterina Cafasso, che senza dubbio posso con vero fondamento dire volò in Paradiso”.
Intanto l’anno scolastico 1831- 32 volgeva al suo termine e Giovanni se ne ritornava a Castelnuovo. Gli amici suoi di Morialdo, de’ quali non erasi mai dimenticato, tenendo sempre con essi relazione e di quando in quando facendo loro nel giovedì qualche visita, saputo che veniva per le ferie autunnali, gli corsero incontro a molta distanza dal paese e quasi in trionfo lo accompagnarono alla casa materna. Questa scena si rinnovò poi ogni anno e sempre con una festa speciale. Tra quei giovani fu pure introdotta la Società dell’Allegria, a cui venivano aggregati coloro che lungo l’anno si erano segnalati nella morale condotta, e dal catalogo della quale all’opposto nell’autunno seguente si scancellavano quelli che si fossero regolati male, specialmente se avessero bestemmiato o fatti cattivi discorsi.
Giovanni, ritornato a casa, sentiva il bisogno di completare gli studi, che forse in qualche parte non erano riusciti così perfettamente come desiderava. Egli non era giovane da lasciar le cose a metà; non si contentava della semplice riuscita, ma anelava a fare un sodo profitto, e di ogni cosa voleva conoscere la ragione. Tre corsi così compiuti in un anno da altri sarebbe stato reputato come un vero successo: per lui invece era motivo di esaminare se forse non fosse corso troppo. Letti i documenti, io non posso sciogliere un dubbio, se cioè gli esami finali della terza classe Giovanni li avesse subiti prima o dopo delle vacanze di quest’anno. Tengo sott’occhio il suo attestato dell’anno 1832 – 33, nel quale leggo con data del 5 novembre 1832 aver Giovanni Bosco preso l’esame ed essere [272] stato promosso in albo studiosorum grammatices. È questa la data dell’esame, oppure semplicemente quella del giorno dell’attestazione?
Comunque sia, Giovanni, che aveva fatto ripetizione agli altri in modo da procurar loro gli onori della scuola, sentiva il bisogno di aver egli stesso ripetizione da maestri che conoscessero bene le materie della terza ginnasiale, risoluto di continuare gli studi nei due mesi e mezzo di vacanze autunnali. Palesato il suo disegno alla madre ed assicuratosi che avrebbe potuto essere ospitato alla Serra di Buttigliera, si presentò al teologo Giuseppe Vaccarino, parroco di Buttigliera d’Asti, supplicandolo a volerlo assistere nella ragionata traduzione degli autori latini. D. Vaccarino, ancor molto giovane, aveva preso possesso della sua parrocchia solamente il 5 febbraio di quell’anno 1832; e però le fatiche del nuovo campo evangelico, il desiderio di far profitto coll’esperienza degli altri intrattenendosi a lungo coi parroci confinanti, e la necessità di perfezionare i suoi studi, lo decisero a bellamente rifiutare l’opera sua. Più tardi parlando con D. Gamba suo parrocchiano esclamava: – Se allora io avessi potuto prevedere quali erano i fini della divina Provvidenza su quel giovanetto, certamente avrei accettato il grato incarico a costo di qualunque sacrificio, non badando a’ miei studi o ad altro, per poter dire: Ebbi la fortuna di essere maestro di D. Bosco!
Giovanni, deluso in questa sua speranza, ritornò alla cascina del Susambrino e solo soletto procurava di sciogliere colla sua intelligenza le difficoltà che presentavangli i libri di testo. Un giorno passando D. Dassano nella valle sottostante, lo vide custodire due vacche al pascolo e col libro di un autore classico latino in mano. Gli era stato detto che Giovanni desiderava aver ripetizione. Fermatosi, lo interrogò sopra i [273] suoi studi, si fece leggere un tratto ad alta voce, stupì della correttezza di pronuncia e del modo sciolto ed assennato, col quale percorreva quella pagina. Senz’altro salì da mamma Margherita e le disse: – Conducetemi il vostro Giovanni in parrocchia e conchiuderemo qualche cosa. – All’indomani Margherita s’affrettò a rispondere all’invito del prevosto. Il quale per fare esperimento di Giovanni, gli assegnò alcune pagine di un suo libro da studiare a memoria, dicendogli che ritornasse dopo un dato numero di giorni per recitarle. Giovanni si ritirò, e alcune ore appresso ricomparve nella sala del vicario. Sorpreso D. Dassano, gli chiese qual motivo lo avesse ricondotto; e udito che aveva imparata la lezione, sulle prime non volle credere e lo congedava; ma Giovanni, insistendo rispettosamente, ebbe licenza e recitò con speditezza quelle lunghe pagine, senza restar imbrogliato in un solo periodo. D. Dassano, fuori di sè per la meraviglia, fissatolo per un istante in volto: – Ebbene, gli disse, ti faremo scuola, e se a te piace, mi terrai pulito il cavallo e ne avrai cura. – Il viceparroco, presente allora, soggiunse: – La scuola la farò io: da questo giovane ne spero molto bene! – Quindi Giovanni ogni mattina partiva puntualmente da casa, assisteva alla lezione, che davagli quel buon sacerdote assai istruito nella letteratura latina ed italiana, e compiva l’obbligo che aveva accettato di tener in ordine la stalla. Ed anche qui non sapeva che cosa volesse dire momento d’ozio. Quando il padrone non aveva bisogno di attaccare il cavallo alla vettura, egli gliel conduceva a fare la passeggiata; e allorchè si trovava nelle vie solitarie fuori del paese, spingevalo al galoppo, e correndogli al fianco gli saltava in groppa, e colla sua meravigliosa sveltezza riusciva a stargli in piedi sul dorso, mentre quello continuava la sua corsa. Era questa la sua unica ricreazione. Il rimanente del tempo era dato allo studio, ai [274] trattenimenti festivi, ora al Susambrino ed ora ai Becchi, e alle pratiche di pietà. “Nelle vacanze, esclamava in nostra presenza Filippello, lo si vedeva assiduo alla chiesa di Castelnuovo, nella quale accostavasi con frequenza ai Sacramenti. Era stimato e amato da tutti, ed io non posso far di lui tanti elogi quanti si merita”. A Giovanni adunque si possono applicare le parole dei Proverbi: “Una buona riputazione val più che le molte ricchezze: e più dell’argento e dell’oro vale l’essere amato”[70].
CAPO XXXI.
Giovanni ritorna a Chieri ed entra nella classe di Grammatica latina – Stima che ne hanno il professore ed i compagni – Sua umiltà – Ripetizione ai giovani chieresi – Riceve il Sacramento della Confermazione – Il Magistrato della Riforma e gli esami finali – Scuola domenicale a Morialdo – La prima Messa di D. Giuseppe Cafasso.
VENUTO il novembre del 1832, Giovanni ritornò a Chieri in casa della signora Lucia Matta, che gli affidava di bel nuovo il suo figliuolo e lo dispensava dal pagare la pensione e dal provvedersi il vitto. Al collegio, per avere l’ammissione alla scuola, presentò l’attestato del parroco di aver egli frequentato le funzioni della parrocchia e fatta una volta al mese la Confessione sacramentale, come prescriveva agli alunni la legge in sul principiare di ogni anno scolastico. Promosso con buoni voti, Giovanni fece il suo ingresso, sicuro di sè, nella classe di grammatica, che corrispondeva alla nostra terza ginnasiale. Era per lui un trionfo. Il Can. Francesco Calosso e il Sac. Prof. Teol. Giovanni Bosco di Chieri, che poi fu dottore in lettere e filosofia nell’Accademia militare di Torino e professore di sacra eloquenza nella Regia Università, più volte parlarono con Monsignor Giovanni Cagliero e con altri della meravigliosa sua applicazione, per cui incominciando lo studio [276] del latino in un sol anno avesse percorso tre classi e con splendida riuscita.
Suo professore di grammatica fu il P. Domenico Giusiana, dei Predicatori, al quale Giovanni portava grande affetto e da cui era riamato con singolare tenerezza. Il buon discepolo ne era ben degno. Il dottor Carlo Allora di Castelnuovo d’Asti, suo compagno di scuola a Chieri, nel 1888 ricordava con viva compiacenza come il nostro Giovanni in quegli anni non faceva nessuna pompa delle sue doti, non mostrava nel suo contegno neppur l’ombra di affettazione o di ambizione e dalla sua persona traspariva un non so che di straordinario e soprannaturale: quale studente, egli era come il sorvegliante di tutti i compagni, e sebbene non incaricato in modo speciale, pure era tenuto come superiore, perchè tutti stavano a quanto lui diceva. Fin da quei tempi era un santo! esclamava entusiasmato della giovinezza di Giovanni. Questi infatti, fra le altre virtù, dava prova di umiltà nel trattare coi condiscepoli. In quell’anno stesso un compagno, carpitogli segretamente un quaderno, vi ricopiava un sonetto, mutando solo alcune parole, e quindi lo mandava in giro fra i condiscepoli, attestando essere desso opera sua. Mentre assaporava le lodi che da tutti venivangli fatte, dopo qualche giorno, quel foglio capitò nelle mani di Giovanni, il quale, senza offendersi di quell’indelicatezza, nè rivendicare a sè l’onore di tal lavoro, tacque, ripugnandogli svergognare l’amico; ma scrittovi in calce il motto: Est ne de sacco ista farina tuo? lo ripiegò e lo fece restituire a quel vanerello.
Conosciutasi in Chieri la sua pietà e morigeratezza, la sua abilità e il suo profitto meraviglioso nello studio, molte famiglie lo ricercarono per ripetitore ai loro figliuoli, non solo suoi compagni di classe, ma eziandio a quelli iscritti alle classi superiori di umanità e di retorica; e così incominciò a [277] far scuola ed assistere allievi nelle case private. Lo scopo primario di Giovanni era di far del bene, ma non rifiutava le piccole retribuzioni che gli erano offerte. Con ciò la divina Provvidenza lo metteva in grado di provvedersi quanto eragli necessario per abiti, lingeria, oggetti di scuola e le altre varie spese, senza cagionare alcun disturbo alla famiglia. Da tutte parti inoltre egli veniva richiesto per dare trattenimenti nelle famiglie, cui prestavasi volentieri ogni volta che poteva, senza pregiudicare i suoi studi o la virtù. Abbiamo udito esclamare da più d’uno che trattò con lui in quegli anni : – Era tanto buono che non poteva esserlo di più! – Presso i compagni era il mentore, il pacificatore ed anche il maestro nella via della perfezione. Infatti la Società dell’Allegria continuava, con grande vantaggio degli associati.
Intanto egli era vicino a compiere i diciotto anni e non aveva ancora ricevuto il Sacramento della Confermazione. In quei tempi l’amministrazione della Cresima nei paesi di campagna non era troppo frequente. In quell’anno però lo zelo del Teol. Vaccarino procurava a’ suoi parrocchiani non ancor cresimati questa grande fortuna. E Giovanni si mise subito in viaggio, e fu cresimato in Buttigliera d’Asti il 4 agosto 1833 da Mons. Giovanni Antonio Gianotti, Arcivescovo di Sassari, essendo padrino il Sig. Giuseppe Marsano e madrina la contessa Giuseppina Melina. Non ci furono trasmesse memorie sul modo, col quale il nostro Giovanni si preparò a questo grande atto; ma dagli effetti, che in lui manifestarono così luminosi i doni del Santo Divino Spirito, possiamo benissimo argomentare la vivezza della sua fede.
In sul finire dell’anno scolastico le scuole di Chieri ebbero una visita del Magistrato della Riforma nella persona dell’avvocato professore D. Giuseppe Gozzani, uomo di molto merito. Veniva a presiedere la Commissione esaminatrice e a [278] verificare lo stato degli studi. Il suo nome era il terrore degli studenti, poichè era giusto, ma di una giustizia legale, inesorabile. Sparsasi la nuova del suo arrivo, la scolaresca si mise in gran fermento, si faceva un gran dire, si udivano parole sommesse di minaccia. D. Gozzani, uomo calcolatore e di sangue freddo, prevenuto delle poche buone accoglienze che gli avrebbero fatto gli alunni, appena giunto a Chieri, li radunò e fece loro un discorso, promettendo che non solo non avrebbe usato rigore, ma neppur severità. Così calmati al quanto gli animi, dettò il tema per gli esami in iscritto, e ritirate le pagine, partì all’improvviso per Torino. Di là mandò i voti, che furono tutt’altro che benigni. Tuttavia i condiscepoli di Giovanni, in numero di quarantacinque, furono tutti promossi alla classe superiore di umanità, che corrisponde alla nostra quarta ginnasiale. Egli però corse gran pericolo di essere ritenuto, per aver dato copia del lavoro ad altri; se venne promosso, lo dovette alla protezione del venerando suo professore P. Domenico Giusiana, che gli ottenne un nuovo tema, il quale, riuscitogli bene, gli procurò la promozione a pieni voti. Egli aveva incontrate le simpatie di D. Gozzani, che gli usò molta benevolenza nel concedergli il secondo esperimento. E di ciò Giovanni conservò gratitudine e buona memoria, a segno che si tenne di poi sempre in istretta ed amichevole relazione con questo sacerdote, il quale, andato a vivere in Multedo Superiore, presso Oneglia sua patria, fra le molte opere di carità fondò un posto gratuito nel Collegio Salesiano di Alassio per un giovanetto che desiderasse studiare per lo stato ecclesiastico. Era allora lodevole consuetudine che in ogni corso, almeno uno studente, a titolo di premio, venisse dal Municipio dispensato dal minervale di lire 12. Per ottenere questo favore era necessario riportare pieni voti negli esami e nella condotta. [279]
Giovanni fu sempre favorito dalla sorte, ed in ogni corso ottenne la dispensa di quel pagamento. Noi abbiamo negli archivi l’attestato di promozione colla data del 22 agosto 1833, firmato dal Padre Sibilla, prefetto degli studi: e nei singoli bimestri le firme del Can. Clapiè e di D. Piovani, direttori spirituali, del professore P. Giusiana e del prefetto dimostrano la sua diligenza nello studio e l’ottima condotta.
Col finire dell’anno scolastico 1832- 33, il figlio della signora Lucia aveva compiuto i suoi corsi, e Giovanni si licenziò da quella casa ospitale, dalla quale aveva ricevuto gran bene, ma che egli aveva rallegrata con una perenne felicità di educazione e di edificazione cristiana. Giovanni Battista Matta, divenuto poi adulto, mise un negozio di drogheria in Castelnuovo d’Asti sua patria, ove fu sindaco per molti anni, e nel 1869 collocava in educazione un suo fanciulletto nell’Oratorio di Torino, ove lo lasciò per tre anni. D. Bosco lo volle sempre a mensa con sè, e gli usò tanti riguardi, da cagionare ammirazione in coloro che non conoscevano la causa di tale preferenza. Era questo un segno di quell’imperitura gratitudine che ognora viva conservava verso di quella famiglia.
Giovanni, tornato al Susambrino, trovò che le nozze del fratello Giuseppe avevano condotto ai fianchi di mamma Margherita una buona creatura, che a lei rendeva tutte quelle premure che essa aveva esercitate verso la nonna. Perciò egli gran parte del tempo si ritirava ai Becchi, ove nei giorni festivi radunava i ragazzi del borgo per istruirli nel Catechismo ed anche insegnar loro a leggere e a scrivere, chiedendo solo per retribuzione che andassero una volta al mese ai SS. Sacramenti. E noi qui vediamo i principii delle scuole domenicali e serali per i poveri figli del popolo, che si aggiungono all’Oratorio festivo. Nei giorni feriali invece, dopo aver [280] lungamente meditati i suoi temi e gli autori di testo, occupavasi nel fabbricare quei mobili, dei quali la famiglia mancava. E noi abbiamo veduto una tavola e qualche scanno, opera delle sue mani, che tuttora esiste. Metteva anche a profitto l’arte del calzolaio, che aveva imparato a Chieri in quell’anno, e benchè non facesse scarpe fine, pure riusciva a rattopparle, se sdruscite, e ridurle quasi a nuovo. Questa sua industria, consigliata pur dalla povertà, gli fu cagione di non pochi risparmi. Nel suo piccolo laboratorio pertanto, al fornello da ferraio, al tavolo da sarto, al banco da falegname aggiunse pure il deschetto da calzolaio.
Queste stesse vacanze furono per lui segnate da un solenne avvenimento. Il pio chierico Giuseppe Cafasso, fatti gli esercizi spirituali nella canonica di Moncucco sotto la direzione del prevosto Can. Cottino, ed ordinato sacerdote nel sabato delle Quattro Tempora d’autunno, 21 settembre, celebrava, il giorno dopo, la sua prima Messa in Castelnuovo, tra il giubilo e le feste de’ suoi compaesani. Giovanni dovette piangere di santa invidia quando lo vide ascendere all’altare; tanto più che da anni il cuore spingevalo a desiderarne l’amicizia e sempre nuovi ostacoli lo avevano tenuto da lui lontano. Ma, finito il santo sacrifizio, avvicinandosi a lui in mezzo al popolo per baciargli la prima volta la sacra mano, io credo che uno sguardo affettuoso del novello sacerdote, gli abbia fatto conoscere come il suo voto fosse esaudito e che egli avrebbe trovato in lui un padre, un arco, un consigliere, un benefattore costante. Giovanni però non poteva allora prevedere fino a quale punto sarebbesi stretto, per mano della divina Provvidenza, il vincolo d’amicizia fra lui e D. Cafasso; nè che di quella indimenticabile festa sarebbe a lui toccato di perpetuare la memoria co’ suoi scritti, e tanto meno che egli avrebbe potuto svelare al mondo [281] i più intimi sentimenti destati dall’amore di Dio in quel giorno nell’anima del suo nuovo ministro. “D. Cafasso, stampò D. Bosco nel 1866, lasciò scritte le deliberazioni che prese sul principio del suo sacerdozio. Si portò un giorno a piè del Crocifisso, e: – Signore, disse, Voi siete la mia eredità: Dominus pars kaereditatis meae[71]. Questa è la scelta che volontariamente ho fatto nel memorando giorno della sacra mia ordinazione. Sì, o mio Dio, Voi siete la mia eredità, la mia delizia, la vita del mio cuore in eterno: Deus cordis mei, et pars mea Deus in aeternum[72]. Ma non solo, o mio Dio, voglio essere tutto vostro, ma voglio farmi santo; e, siccome non so se breve o lunga sarà la mia vita, così vi protesto che voglio farmi santo e presto santo. Cerchi pure il mondo le vanità, i piaceri, gli onori, le grandezze della terra: io non voglio, non cerco e non desidero che farmi santo, e sarò il più felice degli uomini facendomi santo, presto santo e gran santo. – Questo disse, e mantenne la parola”. Infatti fu la santità della vita e della dottrina di D. Cafasso che doveva trasfondersi in Giovanni e in centinaia di sacerdoti per sostenere la lotta, che le sêtte dei congiurati andavano preparando contro il trono e contro l’altare.
Fra queste, quella che metteva maggiormente sopra pensiero l’autorità civile era La Giovine Italia, creata e diffusa – con ardore da Giuseppe Mazzini per mezzo d’una pubblicazione periodica che portava quel nome. La Gazzetta Piemontese, nel N.99 del 1833, nel riprodurre un tratto delle istruzioni che da quella si andavano divulgando, scriveva: “Il fine dell’associazione è libertà, indipendenza, umanità, [282] uguaglianza. La tendenza è la repubblica. Il giornale La Giovine Italia, sviluppa questo principio. Lo spargerne un gran numero di esemplari è un cooperarvi grandemente. La propagazione indurrà i proprietari a tirarsi dietro i contadini. I parrochi delle campagne soprattutto sono da tentarsi, ma colla maggior avvedutezza: conviene prima studiare il debole della bestia e da quel lato assaltarla e vincerla. A ottenere tal fine sarà necessario non essersi mai mostrati dispregiatori della religione, dissimulare anche i loro difetti. La bandiera della indipendenza italiana deve sventolare presso l’altare, come si mostra il cereo pasquale, e sul campanile della parrocchia: senza di ciò l’idiota non aggiungerà la sua forza bestiale alla nostra. Quando di buon cuore il parroco operi questa congiunzione e la proclami dall’altare, la vittoria è cert. Bisogna ricordare gli Spagnuoli nella guerra dell’indipendenza. Il Cristo sull’asta della bandiera vada avanti, nelle mani del prete il Vangelo: poi acque avvelenate, agguati d’ogni maniera, terreno che copra voragini ove cada il nemico, i comuni responsabili per non aver messo a fuoco e per non essersi ritirati, tele inchiodate per impedire la cavalleria, rotture di ponti e di strade, barricate nelle città, olio ed acqua bollente, tizzoni accesi, cenere gittata dalle finestre, le pesti tutte infernali che si possono cavar dall’inferno, inventarne di nuove, avanzare, se si può, lo scaltrimento di Pluto”.
Tuttochè si vigilasse attentamente, pure queste dottrine ed eccitamenti cominciavano a divulgarsi e farsi strada fra il popolo, fra l’ardente gioventù di più bell’ingegno, ed anche fra l’esercito. Alcuni giudizialmente convinti di avervi pigliato parte, furono condannati a durissime pene; nel 1833 il Consiglio di guerra in Torino proferiva sentenza di morte contro l’Avv. Scovazzi e l’Avv. Cariolo di Saluzzo, colpevoli [283] di insubordinazione ed eccitamento a far parte di società, sovvertitrici del Governo, e contro sei militari imputati di alto tradimento: anche in Chambery nello stesso anno avevano luogo condanne capitali: un medico Rufini, arrestato in Genova, si toglieva da sè la vita nel carcere: sangue spargevasi in Alessandria ed altre città del Piemonte. Queste sentenze non valsero a estirpare le società segrete, ma soltanto a renderle più caute nelle loro operazioni e nel disporre più tardi nuovi e più arditi rivolgimenti. A base delle loro operazioni contro la Chiesa avevano posto il Piemonte.
Il Governo cercava di premunirsi, ma la sola forza materiale non bastava. Egli poi aveva in sè il torto del Cesarismo. Come ottenere rispetto alla propria autorità, mentre non si professa sottomissione alla più sublime delle autorità, a Gesù Cristo, rappresentato dalla sua Chiesa?
Nel 1832, per invito del Re Carlo Alberto, era stata istituita con lettere pontificie una Delegazione Apostolica o, Consiglio di Vescovi, per riordinare le cose religiose in Piemonte. Col pieno accordo e l’aiuto del Re, essi fondarono, la celebre Accademia di Superga, nella quale dovevansi, formare agli alti studi di religione i più eletti ingegni dei sacerdoti già laureati in teologia e in leggi: riordinarono le Provincie degli Ordini religiosi e abolirono alcuni conventi ove era rilassata l’osservanza delle regole: pensarono di promuovere l’osservanza delle leggi canoniche e togliere quegli abusi che fossero invalsi nel clero, con un regolamento conforme per tutte le diocesi: si proposero di porre l’insegnamento della teologia sotto l’unica direzione del Vescovo, fondar piccoli seminari, erigere cattedre di pubblico insegnamento, lasciando soltanto all’università le facoltà di legge, medicina, chirurgia, ed introdurre nelle città e terre i Fratelli delle Scuole Cristiane, le Suore di S. Giuseppe, le Figlie della [284] Carità. Ma questa Delegazione Apostolica sin da’ suoi primordi aveva contraddizioni dal Senato del Piemonte, che ricusò di riconoscerla e di interinare le lettere apostoliche di creazione.
Nel 1835, la Commissione Civile per la revisione dei libri non volle sottostare ai Revisori Ecclesiastici. Essa non permetteva stampe o scritti, nei quali l’empietà fosse insegnata, la moralità offesa; ma impediva che s’insegnasse come i Vescovi fossero dipendenti dalla S. Sede: proscriveva gli autori, che combattessero le idee gallicane e sostenessero i diritti della Chiesa: tollerava quanti erano favorevoli alle massime della filosofia moderna, sia in fatto di religione che di politica, incagliando la diffusione dei libri che impugnavano tali errori.
Il Re Carlo Alberto, religioso di mente e di cuore, aveva senno pratico, elevatezza di mente, era esattissimo nelle pratiche di pietà, rigido verso se stesso, conoscitore delle perfidie che si nascondono nelle adulazioni; tuttavia per la sua inclinazione alle mezze misure e per le aspirazioni ad un regno italico, non aveva la rotta affatto cogli uomini della rivoluzione, coi quali si era affiatato da giovane. Si pigliava per ministro il De la Tour e poi il Solaro la Margherita schiettamente cattolici; ma accoglieva pure nel gabinetto i liberali Villamarina e Barbaroux, i quali facilmente non curavano i concordati conchiusi colla S. Sede, nè le leggi, e le disposizioni ed i regolamenti su materie ecclesiastiche, che in vari tempi i sovrani sabaudi avevano promulgato.
Dividevano le loro opinioni non pochi teologi, i quali, avendo appreso falsi principi di diritto canonico dai dottori cesaristi dell’università, invece di essere i naturali difensori delle ragioni della Chiesa, ne divenivano disgraziatamente gli oppositori. E questo era un gran male e profondamente [285] radicato. Ma D. Cafasso era l’uomo destinato a porvi rimedio, continuando l’opera incominciata dal Teol. Guala nel convitto di S. Francesco d’Assisi. Insegnando la morale al giovane clero, saprà trasfondergli nel cuore tale rispetto, amore obbedienza al Romano Pontefice e con tale chiarezza esporgli i suoi sacri diritti nelle relazioni cogli Stati, da formare una nuova generazione di leviti, sprezzatori dei sofismi gallicani e sostenitori invitti della supremazia ed infallibilità papale. Tutte le Diocesi dei Piemonte risentiranno il vantaggio di un tale insegnamento di verità, giustizia e carità. E D. Gafasso compirà pure l’istruzione ecclesiastica del nostro Giovanni, formandone uno strenuo difensore della Chiesa, dandogli norme sicure per conoscere tutta l’estensione particolareggiata dei diritti e privilegi divini ed umani di lei, che è precisamente il regno di Dio sulla terra. Giovanni Bosco infatti, incontrandosi più volte con ecclesiastici dell’antica scuola, colla sua umile dolcezza non lascerà mai di prendere le difese del Papa e della Chiesa, e sarà bello il vederlo in sul finir della disputa, dopo brevissima pausa, sorridendo, concludere: Massime dell’università!
CAPO XXXII.
Il pensiero della vocazione – Giovanni delibera di entrare tra i Francescani – A Chieri alloggia presso un caffettiere – Come impedisce i cattivi discorsi – Splendidi elogi della sua condotta – La scuola gratuita di latinità al sagrestano del duomo.
COLL’ANNO di umanità Giovanni vedeva avvicinarsi il tempo, nel quale avrebbe dovuto deliberare intorno alla sua vocazione, Mentre prima anelava con tanto desiderio a divenir prete, ora un timore reverenziale lo riempiva, al pensiero della sublimità di tale stato, della propria miseria e degli obblighi eterni che avrebbe contratti con Dio. State in timore davanti al mio santuario. Io il Signore[73].
Su questo punto della sua vita il nostro Giovanni lasciò scritto una pagina di umiltà ammirabile. Il sogno di Morialdo mi stava sempre impresso; anzi si era altre volte rinnovato in modo assai più chiaro, per cui volendoci prestar fede, doveva scegliere lo stato ecclesiastico, cui appunto mi sentiva propensione; ma non voleva credere ai sogni, e la mia maniera di vivere e la mancanza assoluta delle virtù necessarie [287] a questo stato rendevano dubbiosa e assai difficile quella deliberazione. Oh se allora avessi avuto una guida, che si fosse presa, cura della mia vocazione, sarebbe stato per me un gran tesoro; ma questo tesoro mi mancava! Aveva un ottimo confessore, che pensava a farmi buon cristiano, ma di vocazione non si volle mai mischiare. Consigliandomi con me stesso, dopo avere letto qualche libro che trattava della scelta dello stato, mi sono deciso di entrare nell’Ordine Francescano. Se io rimango chierico nel secolo, diceva fra me, la mia vocazione corre gran pericolo di naufragio. Abbraccierò lo stato ecclesiastico, rinuncierò al mondo, andrò in un chiostro, mi darò allo studio, alla meditazione, e così nella solitudine potrò combattere le passioni, specialmente la superbia, che nel mio cuore avea messe profonde radici.
In Chieri egli aveva frequentato il convento dei Francescani, e alcuni di quei Padri, conosciute le rare qualità di scienza e di pietà, delle quali era dotato, aveangli fatto invito di entrare nel loro Ordine, assicurandolo che sarebbe stato dispensato dallo sborsare la somma prescritta ad ogni novizio per l’ingresso. Questa proposta aveva pel momento acquietato ogni sua perplessità, tanto più che, trovandosi impensierito pel pagamento della pensione in seminario, ogni altra via parevagli chiusa.
Mamma Margherita lo avea lasciato sempre libero sulla scelta dello stato. Quindi non era mai entrata in discorso sull’avvenire, mai aveva fatto progetti sopra una vita più comoda per mezzo suo, mai mostrato il menomo desiderio di volerlo in casa presso di sè o di andare ad abitare con lui quando fosse prete. Se talora Giovanni le chiedeva che cosa pensasse, che desiderasse da lui, essa invariabilmente gli dava una sola risposta: – Io non aspetto altro da te, fuorchè la tua salvezza eterna! Giovanni, benché [288] la vedesse tranquilla, giudicò non essere ancora venuto il tempo di palesarle il suo progetto; sia perchè sentiva il sacrificio che le avrebbe cagionato quel distacco, sia anche perchè non era cosa che avrebbe mandato subito ad effetto. Per l’ammissione tra i Francescani era necessario subire un esame, per cui dovevano trascorrere prima alcuni mesi di preparazione. Tuttavia egli pensò di procurarsi le carte che sapeva necessarie, e ne fece richiesta al suo prevosto; il quale lo contentò, ma nel, dargliele, com’era naturale, D. Dassano gliene chiese il motivo, e Giovanni non gli nascose la presa risoluzione.
Frattanto era giunto il tempo di ritornare a Chieri. Sta Avendo la signora Lucia Matta tolto il suo alloggio da questa, per aver suo figlio terminati gli studi di ginnasio, bisognava trovare per Giovanni una nuova pensione. In quell’anno un cugino ed amico della famiglia Bosco, della stessa borgata di Morialdo, Giuseppe Pianta, aveva deciso di andare ad aprire una bottega di caffè e liquori in Chieri. Margherita colse l’opportunità e lo pregò di accettare Giovanni in casa sua, ed il Pianta propose al giovane l’ufficio di garzone caffettiere nella sua bottega; al che accondiscese Giovanni, anche per essere più vicino di abitazione al suo professore D. Banaudi, col quale era già in amichevole relazione. Sembra però che all’arrivo di Giovanni in quella città il Pianta non avesse ancor finiti i suoi apprestamenti e non si fosse ancora accomodato nella nuova casa. Stando alle relazioni fatte dagli anziani del paese a D. Secondo Marchisio ed alle notizie che ne ebbe il professore D. Giovanni Turchi, pare che il nostro Giovanni abbia abitato per alcun tempo presso un tal Cavalli, il quale gli assegnò un angolo della stalla di notte, e lo obbligò a prendersi cura di un giumento e ad attendere a qualche lavoro, in una sua [289] vigna poco lontana dalla città. Giovanni però aveva chiesta ed ottenuta esplicita promessa di essere lasciato in piena libertà ogni sabato sera, per potersi recare in chiesa a fare la sua Confessione. E questa una prova di più dell’eroica fortezza di Giovanni nel sostenere tanti disagi per giungere al sacerdozio. Questo fu l’anno, nel quale dovette sopportare le maggiori privazioni, persino nel povero e scarso vitto. Si dice che il signor Ceppi, negoziante in ferro a Chieri, abbia fatte istanze presso il Pianta, perchè si affrettasse ad ospitare Giovanni. Comunque sia andata la cosa, noi lo troviamo presto in casa del cugino, a fare il sorvegliante notturno e ad occuparsi delle varie faccende domestiche. Non riceveva stipendio, ma aveva libero il tempo necessario per poter studiare. Il cugino concedevagli l’alloggio gratuito e gli somministrava la minestra. La madre, come era consuetudine, gli provvedeva da casa pane e pietanza. Uno stretto vano sopra un piccolo forno, costrutto per cuocere le paste dolci e al quale si ascendeva per una scaletta, era il luogo destinatogli per dormire; per poco, che egli si fosse allungato nel lettuccio, i suoi piedi sporgevano non solo dall’incomodo pagliericcio, ma dalla stessa apertura del vano
“Quella pensione era certamente assai pericolosa per causa degli avventori, così scrisse D. Bosco stesso; ma essendo con buoni cristiani e continuando le relazioni con esemplari compagni, io potei andare avanti senza danno morale”.
Il padrone talora lo incaricava di notare le puntate ai giocatori del bigliardo, ed egli recavasi nella sala sempre leggendo un libro. Il suo volto, allorchè si pronunziava qualche bestemmia o si intraprendeva qualche discorso poco onesto, si faceva così serio, che moriva la parola in bocca ai giocatori. Sovente però, non contento di disapprovare col silenzio, sapeva anche valersi della parola e correggere con carità ed [290] efficacia coloro che avevano mancato. Per il che parecchi di quei buontemponi, non osando parlare liberamente come lor talentava, pregarono il Pianta che non mettesse più Giovanni a notare i punti del giuoco, perchè, dicevano, imponeva loro rispetto e si sentivano in soggezione. E talora esclamavano stizziti: – Ma allontanate quel ragazzo da questo luogo!
Compiuti i doveri del servizio, Giovanni studiava e con diligenza eseguiva i suoi lavori scolastici, impiegando il restante del tempo libero, parte in leggere i classici italiani o latini e parte nel confezionare liquori e confetture. Alla metà dell’anno era in grado di preparare caffè, cioccolatte, e conosceva le regole e le proporzioni per fare ogni genere di confetti, di paste, di liquori, di gelati e rinfreschi; tanto che il principale, considerando l’utile che gli avrebbe potuto recare al negozio, gli fece vantaggiose profferte, perchè, lasciando ogni altra occupazione, si desse intieramente a quel mestiere. Giovanni però, che faceva quei lavori soltanto per divertimento e ricreazione, recisamente rifiutossi, protestando nuovamente che la sua risoluta intenzione era di continuare gli studi. In quel negozio egli imparò eziandio a far cucina, e così andava preparandosi colle necessarie cognizioni all’amministrazione di un povero ospizio di carità.
Con queste svariate occupazioni, mai non trascurò le pratiche di pietà giornaliere. Affermava lo stesso Sig. Giuseppe Pianta il 10 maggio del 1888 a D. Bonetti, a D. Berto e a D. Francesia, in una stanza della Casa Salesiana di Chieri: “Era impossibile trovare un giovane più buono di Giovanni Bosco. Tutte le mattine andava a servire alcune Messe nella chiesa di S. Antonio. In casa avevo la madre mia vecchia ed ammalata, ed era ammirabile la carità che egli sapeva usarle. Sovente passava la, notte intiera studiando, [291] ed alla mattina io lo trovavo ancora sotto il lume acceso a leggere e a scrivere”. Si dice che sia durante quelle notti che abbia imparato così bene a memoria Dante e Virgilio,
Egli formava il buon esempio di tutto il vicinato. La signora Clotilde Vergnano, figlia del proprietario della casa, diceva nel 1889, che essa allora giovinetta nol vide mai stare oziando e far ricreazione nel cortile cogli altri fanciulli del vicinato: che alcune volte lo incontrava su per le scale, mentre andava a prender acqua per un buon prete, D. Arnaud, e che mai le fu dato di vederlo alzar gli occhi e fissarla in viso: che venne infine a sapere come il medesimo D. Arnaud, testimonio della vita ritirata ed edificante del giovane, scrisse poi al parroco di Castelnuovo, perchè si occupasse per collocarlo in un luogo più comodo e sicuro.
Il signor Giuseppe Blanchard confermò come, durante il tempo che Giovanni abitò in casa di Giuseppe Pianta, mai fu veduto prendere parte agli allegri e chiassosi divertimenti, con i quali egli, allora pur giovanetto, si sollazzava, coi suoi fratelli ed amici, malgrado che gliene facessero vive istanze quando ritornava dalla scuola.
Per quanto Giovanni amasse i giovanetti e s’intrattenesse volentieri con loro, seguiva infallibilmente la massima: “Ogni cosa ha il suo tempo”[74]. In ogni sua azione era ordinato e non transigeva dalla regola che si era prefissa. Aveva fissato il tempo per le riunioni della Società dell’Allegria, il tempo per le ripetizioni ai compagni che a lui si rivolgevano per aiuto, il tempo per accudire alle faccende de’ suoi ospiti, il tempo che doveva consacrare alla preghiera, alla chiesa, ai Sacramenti. [292]
E la ricreazione aveva pur il suo tempo; ma ecco in qual modo. Ce lo racconta il canonico Giuseppe Caselle, che allora stava a dozzina con sei o sette giovanetti presso un buon prete di Chieri, maestro nelle scuole municipali, il quale abitava in casa di un certo Torta, posta in faccia a quella del Pianta. “Quasi ogni sera, egli narra, specialmente nell’inverno dopo cena, quando le occupazioni glielo permettevano, Giovanni Bosco veniva a trattenersi con noi, e lo aspettavamo nella sala, o nel piccolo cortiletto, se il tempo era bello. Non è a dire con quale gioia lo accoglievamo, quando egli compariva. Ed egli contento, incominciava a farci ridere qualche facezia, e, sempre pronto ai nostri desideri, ci raccontava graziose storielle edificanti e sapeva tenerci due ore e più senza che ce ne accorgessimo. Talora ci ripeteva o ci spiegava qualche tratto del catechismo. Di quando in quando in bel modo ci interrogava se andavamo a confessarci, se stavamo buoni; e noi per secondare il suo desiderio ci accostavamo ai santi Sacramenti più di quanto era allora costumanza. Allorchè gli dicevamo di essere andati, a confessarci, egli se ne rallegrava e ci faceva coraggio a perseverare nei buoni proponimenti. Noi eravamo disposti a fare per lui qualunque cosa. Per quanto tarda fosse venuta l’ora non sapevamo distaccarci da lui. Sovente il nostro medesimo maestro calava adagio in punta di piedi e veniva presso a noi per udire quali interessanti cose ci narrasse Bosco, da tenerci così attenti e silenziosi. Più di una volta il maestro ci disse avete un bell’esempio sotto gli occhi! Chi sa che cosa sarà per diventare questo giovanetto! In quelle sere poi, nelle quali Giovanni non poteva venire, noi eravamo melanconici, la ricreazione ci sembrava troppo lunga e noiosa ed aspettavamo che il maestro ci chiamasse per recitare le orazioni”. [293]
Giovanni riserbavasi quell’ora sola di sollievo alla sera, non avendo lungo il giorno un istante di respiro, ed egli sapeva convertirla così bene in un’ora di lezione morale.
In quell’anno poi si prese un impegno, che ha l’impronta di vero eroismo cristiano. Frequentando per le sue divozioni il duomo di Chieri, strinse amicizia con l’ottimo sagrestano maggiore, di nome Carlo Palazzolo, uomo di sincera pietà, che tre volte già era andato a Roma a piedi in pellegrinaggio per visitare le basiliche e le catacombe. Egli contava già i suoi trentacinque anni, e benchè corto d’ingegno, senza mezzi e distratto dalle occupazioni del suo ufficio, desiderava ardentemente di farsi prete. Conosciuta la bontà del giovane Bosco, lo pregò di volergli fare scuola. Fu esaudito subito, e Giovanni si assunse l’incarico di fargli regolarmente lezione tutti i giorni in guisa da poterlo preparare a subire con lui l’esame per la vestizione chiericale Palazzolo era quasi digiuno di studi, non aveva gran tempo da disporre; ma Giovanni, rifiutando ogni compenso, si recava puntualmente ogni dì alla sua abitazione presso il duomo a fargli scuola: di quando in quando per lo stesso motivo Palazzolo si recava a far visita all’amico; e Giovanni gli insegnò con tanta pazienza ed abilità, che in poco più di due anni non solo lo condusse al punto che voleva, ma, presentatolo ai professori del collegio per gli esami, questi riescirono felicemente. Chi non vede in ciò un preludio della sua futura istituzione dei Figli di Maria per promuovere le vocazioni dei giovani adulti allo stato ecclesiastico?
Quivi Giovanni fece eziandio conoscenza con Domenico Pogliano, campanaro del duomo, del quale erasi già, senza saperlo, guadagnata la stima per la sua fervente devozione, per il suo apostolato tra i coetanei coi catechismi, p gli onesti divertimenti così necessari onde allontanare la gioventù [294] dal male. Questo bravo uomo, conoscendo come la casa del Pianta, non fosse luogo troppo adatto, per studiare con raccoglimento, invitò Giovanni ad approfittare della quiete di sua abitazione, e questi non mancò di recarvisi moltissime volte. Il campanaro asseriva di non aver mai veduto un giovane così riserbato e virtuoso come Giovanni Bosco, e il tavolino, al quale egli si assideva per studiare, è conservato tuttora con venerazione dagli eredi del Pogliano.
Così ci narrava D. Carlo Palazzolo negli ultimi anni di sua vita.
CAPO XXXIII.
Il prevosto D. Dassano palesa a Margherita la decisione di Giovanni di farsi Francescano – Generosità della madre cristiana – Privazioni sofferte da Giovanni nell’anno di umanità – Sua riconoscenza verso chi aveagli dato soccorso.
IN QUESTO frattempo D. Dassano aveva giudicato prudente avvertire Margherita della risoluzione presa dal figlio di farsi Francescano. Un dopo pranzo del mese di dicembre pertanto fu a visitarla, e, dopo averle esposta la cosa, le fece osservare come vi fosse molto da fare in Diocesi e che assai più conveniente sarebbe che Giovanni, facendosi sacerdote, si occupasse del sacro ministero in qualche parrocchia: le dimostrò come, avendo egli ricevuto da Dio molti talenti, farebbe certamente una splendida riuscita; quindi concluse: – Cercate di distoglierlo da questa idea: voi non siete ricca: siete avanti negli anni, ben presto non potrete più lavorare: se vostro figlio va in convento, come potrà provvedere alla vostra necessità? È per vostro bene che son venuto ad avvisarvi.
La buona Margherita ringraziò il parroco della confidenza che aveale fatta, ma sull’avviso che le dava non lasciò trapelare qual fosse il suo pensiero. Immediatamente se ne venne a Chieri, e, presentatasi al figlio, col solito sorriso [296] sulle labbra – Il parroco, gli disse, per sua bontà è stato da me e mi ha confidato che tu vuoi farti religioso: è vero?
– Sì, madre, mia. Credo che voi avrete nulla in contrario.
– Io voglio assolutamente che tu esamini il passo che vuoi fare e che poi sèguiti la tua vocazione, senza guardar ad alcuno. La prima cosa è la salute della tua anima. Il parroco voleva che io ti dissuadessi da questa decisione, in vista del bisogno che potrei avere in avvenire del tuo aiuto. Ma io dico: In queste cose non c’entro, perchè Dio è prima di tutto. Non prenderti fastidi per me, Io da te voglio niente: niente aspetto da te. Ritieni bene: sono nata in povertà, sono, vissuta in povertà, voglio morire in povertà. Anzi te lo protesto: se tu ti risolvessi allo stato di prete secolare e per sventura diventassi ricco, io non verrò a farti una sola visita. Ricordalo bene! – D. Bosco, a settanta e più aveva ancora d’innanzi agli occhi l’aspetto imperioso assunto da sua madre nel dirgli queste parole, e nell’orecchio risuonavagli ancora il tono vibrato della sua voce; della quale ripetendo le energiche espressioni veramente cristiane, sentivasi commosso fino alle lagrime.
Ma il Signore che vedeva la sincerità del cuore di Margherita, dispose che ella non fosse divisa dal figlio e che Giovanni avesse in lei una coadiutrice generosa nella fondazione dell’Oratorio di S. Francesco di Sales.
Frattanto nessuno in Chieri aveva il minimo dubbio su ciò che Giovanni andava divisando. Egli era sempre uguale a se stesso. Tanta tranquillità nell’applicarsi agli studi, tanta generosità ed affabilità continua verso i compagni farebbe supporre e una vita esente da ogni angustia. Eppure non vi fu anno come quello di umanità che, per le incertezze dell’avvenire e la mancanza di mezzi materiali, cagionasse a [297] lui maggiori pensieri e sacrifici. Per vestirsi, procacciarsi la maggior parte del nutrimento e provvedersi quanto occorreva per la scuola, doveva contentarsi delle esigue retribuzioni, colle quali non da tutti i suoi allievi erano corrisposte le sue ripetizioni, e di quel poco che gli recava sua madre. E la buona Margherita, quando trovavasi mancante del necessario pel figliuolo, si raccomandava a persone benefiche per aver qualche imprestito o sussidii in grano o altro. D. Giovanni Turchi ricorda come suo padre talora dicesse di aver anch’egli dato il suo contributo a questa opera di carità. “Ma non sarà contristato il giusto per qualunque cosa gli avvenga”, dice Salomone[75]; e Giovanni, rassegnandosi allegramente al volere di Dio, il quale tutto dispone pel bene di chi lo ama, dissimulava le sue privazioni, che lo costringevano a digiuni più stretti di quelli comandati dalla Chiesa.
Un giorno di vacanza aveva pensato di fare una colazione quale forse da tempo non aveva gustata. Colta una certa quantità di fichi, andò a comprarsi un grosso pane da munizione. Mentre tornava a casa, s’imbattè in un crocchio di compagni, che giuocavano alle bocce sulla piazza di S. Antonio, e si fermò a vedere. Intanto, senza accorgersene, incominciò a sbocconcellare quel pane, e distratto dal giuoco e da altri pensieri, finì per consumarlo tutto. Cessato il giuoco, si ricordò che a casa lo aspettavano i fichi; ma voltosi per andare, si meravigliò di non aver più il suo pane. Cerca di qua, cerca di là; ne chiede ai compagni; sospetta che, per fargli una burla, glielo abbiano nascosto. Uno risponde: – Io non ho visto il tuo pane; – l’altro: – Io non [298] l’ho preso; – finalmente salta su un ultimo: – Ma che cosa cerchi? se te lo sei mangiato tutto! ho visto io con questi miei occhi, meravigliato che potessi insaccare una quantità così grossa di pane. – Giovanni allora persuaso si mise a ridere, giacchè nè se n’era accorto mentre mangiava, nè per nulla sentivasi aggravato lo stomaco di quel cibo. Perciò ritornossene a casa colla colezione bell’ e fatta. Certamente più giorni di astinenza gli avevano destato un simile appetito.
Era infatti voce comune tra i compagni che Bosco non potesse avere abbastanza nutrimento. Giuseppe Blanchard, fra gli altri, sovente, avendo pane e frutta, gliene dava, dicendo – Prendi, Giovannino, prendi che ti, farà bene.
Suo fratello Leandro si lamentava colla madre come Giuseppe portasse via da tavola le castagne più grosse per darle a Bosco; ma essa, brava donna, venditrice di frutta, più volte toglieva dal piatto una mela scelta fra le più belle e la porgeva al figlio ordinandogli: – Portala a Giovanni: egli è tanto buono e pregherà per noi. – Talora Giovanni supplicava il suo giovine amico a non incomodarsi e a ritenere per sè quelle ghiottonerie; ma Giuseppe insisteva con tanto affetto, che era giuocoforza accettarle. Ebbene, narrava il buon Blanchard nel 1839, D. Bosco non si dimenticò di me, non arrossì di confessare quel poco che io aveva fatto per lui, quando era giovane e stava così a disagio. Io l’aveva perduto di vista, e, se l’avessi incontrato, forse non avrei più osato nè salutarlo, nè avvicinarmi, tenendo per certo che non mi avrebbe più riconosciuto. Quanto m’ingannava! Un dì, mentre io portava in una mano un po’ di pietanza e dall’altra una bottiglia di vino, lo incontrai in Chieri, in mezzo a molti preti, venuti per riverirlo, sulla porta della casa Bertinetti, dove era alloggiato. Appena mi vide, lasciò [299] la compagnia e mi venne a salutare: – Oh, Blanchard, e come va?
– Bene, bene, signor cavaliere; io risposi
– E perchè tu ora mi chiami cavaliere? Perchè non mi dái del tu? Io sono il povero D. Bosco senza titoli e niente altro!
– Perdono io credeva che a quest’ora – E intanto io cercava di sbrigarmi, perchè, male in arnese e col mio pranzo sulle braccia, non osava discorrere così alla domestica con D. Bosco, che mi pareva diventato un gran personaggio. Ma D. Bosco mi disse: – Non vuoi più bene ai preti?
– Oh sì, che voglio sempre bene ai religiosi, ma in questo arnese non oso fermarmi qui. – Allora D. Bosco mi soggiunse – Mio caro, mi ricordo che, quando io era studente, mi hai tolta tante volte la fame, e sei stato nelle mani della divina Provvidenza uno dei primi benefattori del povero D. Bosco. – E qui rivolto a tutti quei preti che lo accompagnavano esclamò additandomi: – Signori! ecco uno dei miei primi benefattori – E dopo che ebbe narrato il fatto, mi disse: – Ci tengo assai che tu lo sappia come io ricordi sempre il bene che mi hai fatto. – E stringendomi la mano mi soggiunse: – Ogni qual volta dovrai venire a Torino, recati a pranzo da me.
Dieci anni dopo all’incirca, nel 1886, Blanchard udite notizie poco liete della sanità di D. Bosco, venne finalmente a Torino e all’Oratorio. Il portinaio, vedendolo entrare, lo fermò, e chiestogli il motivo che lo conduceva, gli rispose: – Oggi non si può parlare con D. Bosco.
– Oh, soggiunse Blanchard: D. Bosco è o non è in casa?
– È in casa ma non dà udienza, perchè infermiccio, replicò il portinaio.
– Ciò non importa; egli mi ha da ricevere, perchè me lo disse mille volte che venissi! [300] – Sarà, osservò senza scomporsi il portinaio ma oggi non posso lasciar entrare alcuno: l’ordine è per tutti.
– Sì, per tutti, ma coll’eccezione di me, che sono amico suo dall’infanzia. Oh non mi dia questo dispiacere! Tanto più che non istà guari bene: motivo speciale perchè io lo abbia a vedere. A tanta ingenua insistenza, il portinaio avvisò col filo elettrico che un forestiero desiderava vedere D. Bosco, e la risposta fu che entrasse pure. Il buon vecchio, arrivato in anticamera, ebbe nuova questione col segretario, che intendeva presentarlo a D. Rua; quand’ecco si apre una porta e comparve D. Bosco, il quale, avendo riconosciuto alla voce Blanchard, veniva strascinandosi a stento per toglierlo d’imbarazzo. Presolo per mano, lo fece entrare e sedere presso di sè, lo interrogò della sua salute, della sua famiglia, de’ suoi affari, e quindi gli disse coll’accento della più viva gratitudine: Sono tanti anni che ci siamo conosciuti, sono vecchio e malaticcio, ma non dimentico mai quel che facesti per me nel tempo della nostra fanciullezza. Pregherò per te e tu non dimenticare il tuo povero D. Bosco. Dopo mezz’ora, vedendolo affaticato, Blanchard si ritirò; ma D. Bosco raccomandò che fosse accompagnato a pranzo, e, non potendo egli in quel giorno discendere, volle che in refettorio l’amico occupasse il suo posto in mezzo ai superiori. Quivi il bravo uomo narrò quanto gli era occorso per giungere fino a D. Bosco e le parole di riconoscenza che questi aveagli ripetute.
CAPO XXXIV.
Giovanni si presenta all’esame per essere accettato tra i Francescani – Sogno ed incertezze – Interesse che di lui si prendono alcuni Castelnovesi – Consiglio di D. Cafasso – Continua gli studi a Chieri.
NELLE memorie di D. Bosco troviamo come egli si, presentasse a subire gli esami per l’ammissione tra i novizi francescani. “Approssimandosi la festa di Pasqua, così egli, che in questo anno 1834 cadeva il 30 di marzo, feci domanda per essere accettato tra i Riformati. Mentre attendeva la risposta e a nessuno avevo palesato i miei intendimenti, ecco un bel giorno, presentarsi a me un compagno di nome Eugenio Nicco, col quale avea poca famigliarità e interrogarmi: – Dunque hai deciso di farti Francescano? – Lo guardai con meraviglia: – E chi ti ha detto questo? – E l’altro mostrandomi una lettera: – Mi vien scritto di avvisarti che sei atteso in Torino a prendere l’esame con me, perchè io pure ho deciso di abbracciare lo stato religioso in quest’Ordine. – Andai adunque al convento di S. Maria degli Angioli in Torino, subii l’esame, fui accettato alla metà di aprile[76], e [302] tutto era preparato per entrare nel convento della Pace in Chieri. Però pochi giorni prima del tempo stabilito per la mia entrata ebbi un sogno de’ più strani. Mi parve di vedere una moltitudine di quei religiosi colle vesti sdruscite indosso e correre in senso opposto uno all’altro. Uno di loro mi venne a dire: – Tu cerchi la pace e qui la pace non la troverai. Vedi l’atteggiamento de’ tuoi fratelli. Altro luogo, altra messe Dio ti prepara. – Volevo fare qualche domanda a quel religioso, ma un rumore mi svegliò e non vidi più cosa alcuna. Esposi tutto al mio direttore, che non volle udire parlare nè di sogno, nè di frati: – In questo affare, rispondevami, bisogna che ciascuno segua le sue propensioni e non i consigli altrui”. Questa risposta del suo direttore ed il sogno avuto dovevano render senza dubbio perplesso il nostro caro Giovanni; ma non vedendo un motivo sufficiente per recedere dalla presa determinazione, pensò forse che nell’anno di noviziato avrebbe potuto fare esperienza, se convenivagli o no quel sodalizio. D’altra parte Dio gli aveva messa nel cuore la propensione allo stato religioso, e questa egli sentiva farsi giorno per giorno più imperiosa, come vedremo nel corso del racconto. Pertanto, persuaso che Dio avrebbe guidato gli avvenimenti in modo da condurlo sopra la via, per la quale voleva procedesse, andò a Castelnuovo per chiedere la benedizione alla madre prima di indossare l’abito francescano. [303]
Margherita nulla aveva da opporre e come donna forte lo licenziò senza commuoversi.
Giovanni si recò pure alla casa parrocchiale. D. Dassano fin dai primi di gennaio, per una seria questione col sindaco locale relativamente al suono della campana maggiore, aveva rinunciato alla parrocchia di Castelnuovo e Mons. Fransoni poco dopo lo aveva nominato a reggere quella di Cavour. A Castelnuovo era stato inviato dalla Curia di Torino come amministratore il teologo D. Antonio Cinzano, il quale in quel mattino era assente. Evasio Savio, fabbro ferraio, che da gran tempo amava Giovanni e ne ammirava l’ingegno e la costanza nella pietà e nello studio, vedendolo sulla porta della canonica con un involto di lingerie sotto il braccio, gli chiese: – Perchè hai lasciato Chieri? Vuoi forse con quell’involto ritornare a servire in qualche masseria?
– No, rispose Giovanni; vengo dall’economo a farmi rilasciare il certificato di buona condotta; e poi vado a farmi frate francescano.
– E per quale motivo?
– Come potrebbe mia madre ancora aiutarmi a proseguire oltre negli studi? Andando coi frati spero riuscirò!
– Hai già pranzato?
– Non ancora.
– Vieni adunque in casa mia, mangerai e dopo pranzo parlerò io coll’economo – Savio, considerando il bene che Giovanni avrebbe potuto fare ne’ suoi paesi e dispiacente della perdita che avrebbe patito Castelnuovo, avutolo a pranzo, cercò di persuaderlo a rinunciare a quel progetto che non gli sembrava ben maturato; e pare lo esortasse a chiedere consiglio a D. Giuseppe Cafasso. Era l’ottima delle proposte. Benchè Giovanni non avesse ancora famigliarità col giovane e santo prete studente di morale in Torino, questi [304] era pur l’unico, al quale poteva rivolgersi con sicurezza.
Di D. Cafasso si poteva affermare: Nel cuore dell’uomo prudente abita la sapienza ed egli illuminerà qualunque ignorante”[77]. Quindi Savio si recò a far visita a D. Cinzano, nel quale aveva gran confidenza, per interessarlo in favore di Giovanni, dicendo che era tempo di mettersi tutti d’accordo nell’aiutarlo a finire gli studi e che cagionavagli viva pena vederlo entrare in convento. L’economo, il quale conosce giovane per la fama che aveva di virtuoso e studioso e per una lettera di raccomandazione, che aveva ricevuta dal teologo Arnaud di Chieri, gli rispose, che volontieri avrebbe sostenuto parte della spesa, ma che intanto si rivolgesse al Sig. Cav. Giovanni Pescarmona, allora sindaco di Casteluovo, perchè anch’egli volesse fare la sua buona parte. Ciò detto, si separarono; e Savio mandò a casa Giovanni dicendogli che tornasse con sua madre dopo tre o quattro giorni e che sperasse nel Signore. Intanto egli si recò dal Cav. Pescarmona, signore larghissimo verso Castelnuovo in opere di beneficenza, quali sono la fondazione dell’Asilo, sei doti all’anno di 300 lire l’una a sei figlie povere del paese e varie altre istituzioni, e gli espose la condizione del giovane Bosco e lo invitò a voler concorrere in quella spesa. Quel signore accettò volentieri la dimanda e suggerì a Savio di parlare eziandio col signor Sartoris, tanto benemerito dei poveri. Sartoris pure accondiscese di buon grado; e si venne alla conclusione che D. Antonio Cinzano economo, il Cav. G. Pescarmona ed il Sig. Sartoris avrebbero pagato lire 7 mensili caduno fino al termine di quell’anno. Recatasi Margherita Bosco col figlio a Castelnuovo, accolse colle lacrime agli occhi e con [305] viva riconoscenza la bella notizia e ritornossene ai Becchi ringraziando Iddio. Tale è la sostanza della relazione che fece Giovanni Turco fu Domenico al sacerdote salesiano D. Secondo Marchisio, asserendo d’aver tutto ciò udito a raccontare dallo stesso suo suocero Evasio Savio, morto il 14 maggio 1868, asserzione confermata pure dal fratello Giuseppe Turco.
- Cafasso intanto aveva già pensato di agevolar a Giovanni in ogni modo la via al sacerdozio. Giovanni, ritornato a Chieri, appena gli fu possibile si recò a Torino al Convitto di S. Francesco d’Assisi, e a lui presentandosi, gli manifestò il suo stato e la sua decisione, chiedendogliene consiglio. D. Cafasso lo dissuase dall’aggregarsi ai Francescani, dicendogli. – Andate avanti tranquillamente negli studi, entrate in seminario e secondate ciò che la divina Provvidenza vi sta preparando.- D. Cafasso aveva conosciuto in un colpo d’occhio tutta la missione che era destinata a Giovanni.
Come Margherita seppe l’ultima determinazione del figlio, si mostrò egualmente contenta. – Purchè, essa diceva, si faccia la volontà di Dio. – E infatti parve che questa divina volontà confermasse i suoi disegni, in questo stesso anno, con un altro sogno, che D. Bosco narrò confidenzialmente a D. Giulio Barberis verso il 1870. Nel suo manoscritto aveva notato: “Il sogno di Morialdo si ripetè nel mio 19° anno di età e altre volte in seguito”. Gli era parso di vedere un maestoso personaggio, vestito di bianco, raggiante di luce splendentissima, in atto di guidare una turba innumerabile di giovanetti. Rivoltosi a lui aveagli detto – Vieni qua: mettiti alla testa di questi fanciulli e guidali tu stesso. Ma io non son capace di dirigere ed istruire tante migliaia di fanciulli rispondeva – Giovanni. Quell’augusto personaggio insistette imperiosamente, finchè Giovanni si pose a capo di [306] quella moltitudine di ragazzi e incominciò a guidarli, secondo il comando che eragli stato fatto.
Giovanni adunque per tutte queste ragioni depose l’idea di entrare tra i Francescani; ma, tenendo però sempre in cuore un desiderio inesplicabile di farsi comecchessia religioso, continuò i suoi studi, che non aveva in questo tempo interrotti.
Ma qui verrà desiderio di sapere chi era questo Evasio Savio, che ebbe tanta influenza nelle sorti di Giovanni. Risponderà per me un carissimo nostro confratello, ora defunto, D. Domenico Ruffino. “Savio era un bravo operaio, un fiore di galantuomo e di buon cristiano, che si mantenne sempre molto amico di D. Bosco. Nell’anno 1862 incontratolo per Torino, dopo di avergli parlato di D. Cafasso e di altre persone che non mettevano limiti alla loro carità, il discorso passò sopra certuni, che secondo lui avrebbero dovuto fare miglior uso delle ricchezze. D. Bosco gli disse: – Chi sa che, se avendole voi, ne fareste miglior uso – Egli è questo il motivo, rispose Evasio, per cui non desidero ricchezze: il mio più gran fastidio sa qual è? – Sarà di vivere e morire in grazia di Dio! – No: alla morte io non ci penso: guardo solo ad essere preparato. Il mio maggior fastidio si è questo: io lavoro da fabbro ferraio, e mi è una pena immensa, quando, terminato il lavoro comandatomi, debbo notare il prezzo sul libro. Allora io penso tra me: Chi sa se la cifra che io noto qui, sarà anche notata allo stesso modo dal Signore? Se notando qualche cosa di più, non sarà questa una cifra per la mia condanna? Egli è perciò che io do quasi sempre la roba al 20 per 100 di meno di quel che si dà nelle altre officine. – La sua amicizia D. Bosco lo accendeva di zelo nel coadiuvarlo per quanto poteva nelle opere sue e sovente veniva a visitarlo all’Oratorio. Nei primi tempi non sarebbero state conosciute a [307] Castelnuovo le Letture Cattoliche, se si fossero adoperati nel distribuirle solo coloro che erano di ciò incaricati. Ma Savio, semplice artiere, possessore di una sola giornata e mezzo di terreno, costretto a guadagnarsi il vitto col proprio lavoro, fornito di così poca istruzione da poter notare appena i propri conti, riceveva le Letture Cattoliche, le portava di qua e di là anche in altri paesi, non badando a viaggi, a fatiche, e tante volte anche a spese”.
Fin qui D. Ruffino. Egli è pur sempre vero, che gli strumenti più generosi nelle mani di Dio per promuovere la sua gloria, sono i poveri di spirito, le anime semplici ed i cuori retti.
CAPO XXXV.
La carità di Giovanni verso i condiscepoli non ammette eccezione – Egli è l’anima dei divertimenti – Sfida col ciarlatano alla corsa, al salto, alla bacchetta magica e sulla punta dell’albero – Coi giuochi impedisce i discorsi pericolosi.
DURANTE le angustie sovradescritte, cui dovette soggiacere il nostro Giovanni per decidere di sua vocazione, ei punto non cambiò del suo tenore di vita; per il che niuno, nè dei compagni, nè dei superiori, si addiede del pericolo corso di non più rivederlo tra di loro. Ed egli, continuando ad usare verso de’ condiscepoli la solita carità scolastica di spiegar loro le lezioni non bene intese e d’insegnare a fare i compiti, di tutti si attirava sempre più la stima e l’affezione. Anzi è da notare come questa sua carità non ammetteva eccezioni. Narrava il signor Pompeo Villata d’aver più volte udito da un suo zio, vivente ancora nel 1889, come nella scuola vi erano quattro cinque giovanetti ebrei, i quali si trovavano assai impacciati pel còmpito che dovevano fare dal venerdì al sabato a sera: imperciocchè, secondo il rigore della legge loro insegnata dal rabbino, non avrebbero potuto ciò fare senza colpa, e d’altronde tale omissione era loro causa di vivo rincresci mento e di rossore, dovendo comparire negligenti in faccia a tutta la scolaresca. Giovanni, preso da compassione per [309] poverini, toglievali d’impaccio ogni sabato, scrivendo loro il lavoro dato dal maestro. Ciò faceva per impedire che operassero contro coscienza e che fossero esposti ad osservazioni e critiche poco caritatevoli dei compagni. In quei tempi gli Ebrei erano solamente tollerati nel civile consorzio. Ma tanta carità gli guadagnò talmente i loro animi, che ebbe perfino l’ineffabile consolazione di procurare ad uno di essi la grazia della conversione e del santo Battesimo.
Eziandio ai giovanetti popolani estendeva le sue cure. Nei giorni festivi egli andava per le piazze e per le strade in cerca di essi, per condurli, con sante industrie, al catechismo. Talvolta compariva nei luoghi ove i più riottosi si raccoglievano per giuocare, e mettendosi nella partita e guadagnando, prometteva di restituire la somma vinta, purchè lo seguissero alla chiesa. Non è quindi a far le meraviglie se egli possedeva il cuore di tanti amici. Il dottor Giovanni Marucco di Chieri così di lui ci attesta: Io lo ammirava per la sua ritiratezza, modestia e mansuetudine. Mai udii dalle sue labbra una parola scorretta o d’impazienza; caritatevole con tutti, era desiderato specialmente dagli scolari delle classi inferiori. A lui nessuno poteva dare una negativa. Correggeva con carità i compagni, i quali dopo le sue parole non osavano più contrastare. Negli esami si distingueva sempre. Era una gara tra professori e compagni per mostrargli affezione e desiderarne la compagnia. Egli non poteva essere più buono di quel che era”. Il dottor Gribaudi, suo compagno, raccontava ai superiori dell’Oratorio: “Sospiravamo il momento di poterci trattenere con lui, perchè i suoi bei modi esercitavano sopra i nostri animi un fascino irresistibile, ed ogni qual volta io ed altri miei compagni potevamo fargli corona e udire i consigli, coi quali ci spronava a fuggire il male e a fare il bene, confermandoli con qualche opportuno [310] esempio, noi eravamo felici”. D. Giacomo Bosco aggiungeva: “Nelle sere della bella stagione i compagni in numero di venti e più andavano a radunarsi vicino ad un ponticello fuori della città di Chieri e lo aspettavano, gli uni appoggiati, gli altri seduti cavalcioni sul parapetto. Il suo arrivo produceva in tutti una viva gioia: si stringevano intorno a lui, ed egli incominciava a raccontare cose sempre nuove varie, edificanti e con tanta piacevolezza che un’ora sembrava un minuto. Quando, trattenuto da qualche affare, non compariva al convegno, tutti restavano malcontenti e sospiravano di vederlo nella sera seguente”. È proprio vero che “l’uomo amabile nel conversare sarà amico più che fratello”[78]. Quei giovanetti erano così presi di affetto per lui, che, mancando talora alcuno in famiglia a qualche dovere, le madri non sapevano trovar maggior castigo, che quello di privarli per breve tempo della sua compagnia.
Giovanni era eziandio l’anima di tutti i loro divertimenti. Così lasciò scritto: “In mezzo a’ miei studi e trattenimenti diversi, come suono, canto, declamazione, teatrino, cui prendeva parte di tutto cuore, aveva eziandio imparati molti altri giuochi. Carte, tarocchi, pallottole, piastrelle, stampelle, salti corse erano tutti divertimenti di sommo mio gusto, in cui se non era celebre, non era certamente mediocre. Molti li aveva imparati a Morialdo, altri a Chieri; e se ne’ prati di Morialdo era piccolo allievo, in quell’anno era divenuto un compatibile maestro. Ciò cagionava molta meraviglia, perchè a quell’epoca tali giuochi, essendo poco conosciuti, parevano cose dell’altro mondo. Soleva spesso dare pubblici e privati spettacoli. Siccome la memoria mi favoriva assai, così sapeva [311] a mente una gran parte dei classici, specialmente poeti. Dante, Petrarca, Tasso, Parini, Monti ed altri assai mi erano così famigliari, da potermene valere a piacimento come di roba mia. Per la qual cosa riuscivami assai facile a trattare all’improvviso qualunque argomento. In quei trattenimenti, in quegli spettacoli talvolta cantava, talora suonava, o componeva versi che giudicavansi capi di opera, ma che in realtà non erano che brani d’autori accomodati agli argomenti proposti. Per questo motivo non ho mai date ad altri le mie composizioni; e taluna che fu scritta, ho procurato di consegnarla alle fiamme. A forza però di fare versi e rime, aveva preso tale abitudine di rimar le parole, che, quando poi incominciai a predicare, tutti notavano l’abbondanza delle parole rimate che a grande mi sfuggivano dalla bocca, sicchè dovetti fare un fatica per rimediare a quel difetto”. Rimase memoria in modo particolare di due accademie, alle quali egli prese parte, l’una in omaggio al sindaco e l’altra in onore della stessa città di Chieri.
La sua abilità nella ginnastica fu cagione in quest’anno di un singolare avvenimento. Alcuni esaltavano a cielo un saltimbanco, che aveva dato pubblico spettacolo con una corsa a piedi, percorrendo la città di Chieri da una all’altra estremità in due minuti e mezzo, che è quasi il tempo della locomotiva a grande velocità. Costui riserbava per la domenica i giuochi più nuovi e più straordinari, per cui attirando molti giovanetti intorno a sè, ne avveniva che a Giovanni ne restavano pochi da condurre alla chiesa. Egli perciò era sommamente rattristato. Cercò di far capire ai giovani che facevano male tener dietro in quelle ore al giocoliere, parlò ai sordi. Mandò persone che invitassero il saltimbanco a desistere dà suoi giuochi, almeno in tempo delle funzioni in Sant’Antonio; ma a tale proposta lo screanzato si era [312] messo a ridere. Anzi, tronfio della sua abilità, erasi vantato di superare in destrezza tutta la gioventù del collegio, pronto ad una gara e sicuro di vincere. Gli studenti rimasero offesi da simile provocazione. Se ne fece questione di corpo: si parlò del modo, col quale costringere il ciarlatano a ritrarre quell’insulto: gli sguardi di tutti si rivolsero a Giovanni, ed egli non volle dissentire dal far causa comune con essi: diportarsi altrimenti sarebbe stato offenderli: d’altronde prevedeva che, per vantaggio del bene, avrebbe acquistato sempre maggior ascendente sull’animo della scolaresca.. Anche in questo caso viene a proposito il consiglio di Salomone: “La buona grazia e l’amicizia fanno l’uomo franco; e tu conservale (stando unito agli amici) per fuggire i rimproveri”[79]. Infatti, avendo noi interrogato D. Bosco, perchè si fosse regolato nel modo che vedremo appresso, egli ci rispose – Per accondiscendere al desiderio dei compagni. – Egli adunque, non badando alle conseguenze delle sue parole, disse che, per far piacere agli amici, si sarebbe volentieri misurato con quel ciarlatano nel giuocare, saltare e in qualunque altro esercizio ginnastico. Un imprudente suo amico riferì subito la cosa al saltimbanco, il quale accettò la sfida, beffandosi dello sfidatore. La scolaresca applaudì al suo campione, il quale, trovandosi così impegnato, si consolò pensando che, se la vittoria gli avesse arriso, l’avversario svergognato avrebbe abbandonato il campo.
Si sparse subito la voce per Chieri: – Uno studente sfida un corriere di professione. – Il luogo scelto fu il viale Porta Torinese. La scommessa era di 20 lire. Non possedendo Giovanni quel danaro, parecchi amici di famiglie agiate, appartenenti [313] alla Società dell’Allegria, gli vennero in soccorso. Tutta la scolaresca e una moltitudine di gente assisteva. Sono eletti i giudici del giuoco. Giovanni si toglie la giubba per essere più sciolto nei movimenti: quindi si fa il segno della croce e si raccomanda alla Madonna, come era solito in ogni circostanza grande o leggiera della vita. Si comincia la corsa, ed il rivale lo guadagna di alcuni passi; ma tosto Giovanni riacquista il terreno e lo lascia talmente indietro, che a metà corsa si ferma dandogli partita guadagnata.
– Ti sfido a saltare, e avrò la consolazione di vederti in un fosso e ben bagnato, disse a Giovanni il ciarlatano, ma voglio scommettere lire 40 e di più se vuoi. – Gli studenti, che aveano esposta la prima somma, accettarono la sfida, e toccando al ciarlatano scegliere il luogo, ei lo fissò contro il parapetto del ponticello d’una gora. I competitori, circondati da una numerosa turma di fanciulli e di persone adulte, si volsero verso il sito indicato. Il fosso era assai largo e pieno di acqua. Il ciarlatano saltò il primo e pose il piede vicinissimo al muriccio, sicchè più in là non si poteva avanzare; dovette però abbracciarsi ad un albero della ripa, per non cadere nel fosso. Tutti erano sospesi ed attenti per osservare che cosa sarebbe stato capace di fare Giovanni, giacchè oltre il limite raggiunto dal ciarlatano pareva impossibile andare innanzi. L’industria però gli venne in soccorso. Fece il medesimo salto, ma con questa diversità, che, gettate le mani sul muriccio, slanciò il suo corpo al di là del parapetto, si da rimanervi ritto in piedi. Gli applausi furono generali.
– Voglio ancora farti una sfida: scegli qualunque giuoco di destrezza gridò il ciarlatano sdegnosamente. Giovanni accettò e scelse il giuoco della bacchetta magica, colla scommessa di 80 lire. Giovanni pertanto prese una bacchetta, le pose ad una estremità un cappello, quindi appoggiò l’altra [314] estremità sulla palma della mano; dipoi, senza toccarla coll’altra mano, la fece saltare sulla punta del dito mignolo, dell’anulare, del medio, dell’indice, del pollice; quindi sulla nocca della mano, sul gomito, sulla spalla, sul mento, sulle labbra, sul naso, sulla fronte; indi, rifacendo lo stesso cammino, la bacchetta gli tornò sulla palma della mano.
– Non temo di perdere, disse il ciarlatano al suo rivale, è questo il mio giuoco prediletto. – Prese adunque la medesima bacchetta, e con meravigliosa destrezza la fece camminare fin sulle labbra; ma, avendo alquanto lungo il naso, essa urtò, perdette l’equilibrio, sicchè il cerretano dovette afferrarla con l’altra mano per non lasciarla cadere a terra. Il povero saltimbanco, vedendo andare così a fondo il suo patrimonio, quasi furioso esclamò: – Piuttosto qualunque altra umiliazione, ma non quella di essere vinto da uno studente. Ho ancora cento franchi, e questi li scommetto e li guadagnerà chi di noi arriverà a portare i piedi più vicino alla cima di quest’albero. – Accennava ad un olmo, che era accanto al viale. Gli studenti e Giovanni accettarono anche sta volta; anzi, sentendo di lui compassione, in certo modo erano contenti che egli guadagnasse, giacchè non volevano rovinarlo. Il ciarlatano, abbracciatosi al tronco dell’olmo, salì pel primo e, lesto come un gatto, di ramo in ramo, giunse a tale altezza, che, per poco fosse salito più alto sarebbesi il ramo piegato e rotto, lasciando cadere a precipizio l’audace rampicante. Tutti gli spettatori dicevano che non era possibile salire più in alto. – Sta volta hai perduto! – andavano ripetendo a Giovanni. Questi fece la sua prova. Salì fin dove potevasi senza far curvare la pianta; poi, tenendosi colle mani all’albero, alzò il corpo e portò i piedi circa un metro oltre l’altezza del suo contendente, sopravanzando la punta stessa dell’albero. Chi mai [315] può esprimere le acclamazioni della moltitudine, la gioia dei compagni di Giovanni, il trionfo e la soddisfazione del vincitore e la rabbia del saltimbanco! In mezzo però alla grande desolazione del vinto, gli studenti vollero procurargli un conforto. Mossi a pietà della tristezza del poverino, gli proposero, di ritornargli il suo danaro, se accettava una condizione di pagare cioè un pranzo all’albergo del Muretto. Accettò egli con gratitudine la generosa proposta; ed in numero di ventidue, che tanti erano i partigiani di Giovanni, andarono a godere un lauto pranzetto, che costò 45 lire e permise così al ciarlatano di rimettere in tasca ancora 195 lire.
Quello fu veramente un giovedì di grande allegria per tutti e di grande gloria per Giovanni. Nè dovette essere troppo, malcontento il ciarlatano, il quale riebbe quasi tutto il suo danaro e godette un buon pranzo. Nel separarsi egli ringraziò tutti dicendo: – Col ritornarmi questo danaro, voi impedite la mia rovina. Vi ringrazio di tutto cuore. Serberò di grata memoria, ma non farò mai più scommessa cogli studenti.
Testimonio di questa gara fu il campanaro del duomo, Domenico Pogliano, che narrava il fatto a’ suoi famigliari ed amici ed affermava aver fatto Giovanni così nettamente il salto del fosso, che sembrò fosse portato da un angelo. Noi poi che ancora nel 1885 abbiamo visto D. Bosco a giuocherellare con un bastoncello in modo veramente meraviglioso, facilmente ci persuadiamo non esservi esagerazione in questo racconto.
Giovanni continuò finchè fu secolare, a giovarsi di questa sua abilità per introdursi nei crocchi dei giovani condiscepoli o conoscenti, quando aveva timore si uscisse in qualche discorso poco decente. Con parole cortesi incominciava a distrarli, proponendo loro alcuni giuochi curiosi. Ora sfidavali a prendere da terra un soldo col dito mignolo e coll’indice [316] della stessa mano; ora a fare arco della persona, rivoltandosi totalmente in dietro sì da toccare il suolo col capo, stando sui piedi; ed ora a congiungere bene i piedi e chinarsi a baciare la terra senza toccarla colle mani. Frattanto, mentre i giovani sfidati facevano le loro prove, i compagni si smascellavano dalle risa a que’ contorcimenti, a que’ tentativi inutili, a quegli stramazzoni e musate per terra degli inesperti; e, per tal modo occupati, più non pensavano all’argomento dei loro primieri discorsi, e non si partivano mai da Giovanni senza aver prima ricevuto da lui un buon pensiero.
Chi legge queste pagine, nel vedere il giovane Bosco così destro in simili giuochi, così slanciato in una sfida, così ardito in mezzo alla moltitudine, insomma capo popolo fra gli studenti, s’immaginerà che egli allora avesse un portamento sciolto, un fare da spavaldo. Eppure non era così. Abbiamo udito a narrare da sacerdoti esemplari suoi condiscepoli, che giovane egli aveva lo stesso contegno che teneva da prete a settant’anni: amorevole, alquanto sostenuto, riserbato nel tratto e nei gesti, parco nelle parole. Alcuni di costoro venuti a visitarlo nell’Oratorio, dopo anni ed anni di lontananza, esclamavano nell’uscire dalla sua stanza: – È sempre lo stesso, quello di una volta, quando eravamo Chieri. – Così disse fra gli altri il Padre Eugenio Nicco dei Minori Osservanti. Tuttavia D. Bosco più volte si udì ripetere: – Finchè non fui posto al Convitto di S. Francesco d’Assisi, non ebbi mai una persona che si prendesse una cura diretta dell’anima mia. Feci sempre da me quel che mi pareva meglio; ma sotto un’assidua e accurata direzione mi sembra che avrei potuto fare più che non feci.
CAPO XXXVI.
Lettura e studio dei classici italiani e latini – Amicizia di Giovanni coll’ebreo Giona – Lo converte al Cristianesimo
PARLANDO di questi anni di sua vita, D. Bosco così si esprime: “Nel vedermi passare i giorni in tanta dissipazione qualcuno potrà pensare che io trascurassi lo studio. Non nascondo che avrei potuto studiare di più, ma posso assicurare che l’attenzione nella scuola mi bastava per imparare quanto era necessario. Tanto più che in quel tempo io non faceva distinzione tra il leggere e lo studiare e con facilità poteva, ripetere la materia di un libro letto o udito a leggere più, essendo stato abituato da mia madre a dormire assai poco, poteva impiegare due terzi della notte sui libri a piacimento, alla fiammella di una mia lucernetta, e spendere quasi tutta la giornata in cose di libera elezione, come fare ripetizioni, scuole private, cui sebbene spesso mi prestassi per carità o per amicizia, da parecchi però era pagato. Era allora in Chieri un libraio ebreo, di nome Elia, col quale contrassi relazione, associandomi alla lettura dei classici italiani, un soldo ogni volumetto che gli ritornava dopo di averlo letto. Dei volumetti della biblioteca popolare ne leggeva uno al giorno. L’anno di quarta ginnasiale l’impiegai nella lettura [318] degli autori italiani. L’anno di rettorica mi posi a far studi sui classici latini, cominciando da Cornelio Nepote e andando a Cicerone, Sallustio, Quinto Curzio, Tito Livio, Cornelio Tacito, Ovidio, Virgilio, Orazio Flacco ed altri. Io leggeva quei libri per divertimento e li gustava come se li avessi capiti interamente. Soltanto più tardi mi accorsi che non era
vero ch’io li gustassi; perciocchè, fatto sacerdote e messomi a spiegare ad altri quelle classiche celebrità, conobbi che appena con grande studio e con molta preparazione riusciva a penetrarne il giusto senso e la bellezza loro. Ma i doveri di studio, le occupazioni delle ripetizioni, la molta lettura richiedevano il giorno ed una parte della notte. Più volte accadde che giungeva l’ora della levata, ed io mi trovava tuttora colle decadi di Tito Livio tra le mani, di cui avevo intrapresa la lettura la sera antecedente. Tal cosa mi rovinò talmente la sanità, che per più anni la mia vita sembrava ognora vicina alla tomba. Laonde io darò sempre per consiglio ai giovani di fare quel che si può e non di più. La notte è fatta pel riposo. Eccettuato il caso di necessità, dopo cena niuno deve applicarsi in cose scientifiche uomo robusto reggerà alquanto, ma cagionerà sempre qualche a detrimento alla sua salute”.
Tanta tenacità di memoria adunque in Giovanni era un dono non ordinario, che Iddio aveagli fatto; ed egli non lasciollo irrugginire questo tesoro, ma acuivalo viemmaggiormente col continuo esercizio, studiando non solo i punti più salienti dei libri, ma questi stessi tutti intieri dalla prima all’ultima riga, e fissandosi specialmente su testi assai difficili o per lingua, come la latina e poi la greca, o per costruzione di periodi, o per oscurità di senso, non mai stancandosi finchè non se ne fosse pienamente impossessato. Leggeva pure i più celebri commentatori degli stessi classici latini [319] e italiani e tutte le grammatiche allora conosciute che potè avere tra mano.
E questa facoltà non parve punto in lui illanguidirsi coll’avanzare dell’età, chè nell’ultimo anno di sua vita, dopo le udienze di parecchie ore, soleva ricreare i suoi due segretari recitando qualche terzina di Dante o qualche ottava del Tasso quindi ad un tratto taceva, come se più non ricordasse i versi seguenti, ed invitava i suoi ascoltatori a continuarne la recita il che questi non sempre sapevano fare; e allora egli dava loro l’imbeccata, suggerendo il primo verso, e se tuttavia restavano incagliati, senza più continuava l’intero canto sino alla fine, come se avesse innanzi agli occhi il poema. Era questo il suo divertimento; il che essendo noto ai segretari, talora essi stessi incominciavano la recita di stanze poste negli ultimi canti o a mezzo del libro, ma D. Bosco non si trovava mai impacciato a proseguire. Due mesi prima della sua morte, accompagnandolo D. Rua e il suo segretario in vettura, cadde il discorso su certi tratti della storia sacra, che al Metastasio servirono di tema per qualche suo dramma. Ed egli, il venerando Padre, si pose a declamare con gusto, senza fallire, scene intiere e più commoventi di quest’autore. Eppure, dopo i corsi di ginnasio, non aveva più aperti quei libri.
Da ciò D. Bosco prendeva argomento per incoraggiare i giovani suoi chierici a studiare molto e mandare molte cose a memoria anche alla lettera: Se acquisterete svariate cognizioni, egli diceva, avrete un grande aiuto per fare del bene specialmente alla gioventù; ma, senza l’esercizio della memoria, a nulla gioverà averle imparate; perchè troppo facilmente dimenticherete. Queste parole spiegano il fine della continua sua lettura; ed infatti la sua memoria, unita ad una grande intelligenza e risolutezza di volontà, fu causa di bene ad ogni genere di persone. [320] Abbiamo già accennato come Giovanni trattasse con molta benevolenza i giovanetti ebrei suoi condiscepoli; or è qui il luogo di accennare alle felici conseguenze della sua carità.
L’anno di umanità, dimorando nel caffè dell’amico Pianta, Giovanni contrasse relazione con un giovanetto ebreo di nome Giona. Era questi sui diciotto anni, di bellissimo aspetto cantava con una voce rara fra le più belle; giuocava assai bene al bigliardo, ed avendo già conosciuto Giovanni presso al libraio Elia, appena giungeva in bottega, domandava tosto di lui. Giovanni gli portava grande affetto; e Giona era folle per amicizia verso Giovanni. Ogni momento libero veniva a passarlo con l’amico, e si trattenevano a cantare, a suonare il pianoforte posto; nella sala del bigliardo, a leggere, e Giona ascoltava con diletto le mille storielle che gli andava raccontando Giovanni.
Un giorno al giovane ebreo accadde un disordine susseguito da rissa, che poteva avere tristi conseguenze; laonde corse da Giovanni per avere consiglio. – Se tu o caro Giona fossi cristiano, gli disse Giovanni, vorrei tosto condurti a confessarti; ma ciò non ti è possibile.
– Ma anche noi, se vogliamo, andiamo a confessarci.
– Andate a confessarvi, ma il vostro confessore non è tenuto al segreto, non ha potere di rimettervi i peccati, nè può amministrare alcun Sacramento.
– Se mi vuoi condurre, io andrò a confessarmi da un prete.
– Io ti potrei condurre, ma ci vuole molta preparazione.
– Quale?
– Sappi che la confessione rimette i peccati commessi dopo il Battesimo; perciò se tu vuoi ricevere qualche Sacramento, bisogna che prima di ogni altra cosa riceva il Battesimo. [321]
– Che cosa dovrei fare per ricevere il Battesimo?
– Istruirti nella cristiana religione, credere in Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo. Fatto questo, tu puoi ricevere il Battesimo.
– Quali vantaggi mi darà poi il Battesimo?
– Il Battesimo ti scancella il peccato originale ed anche i peccati attuali, ti apre la strada a ricevere tutti gli altri Sacramenti, ti fa insomma figliuolo di Dio ed erede del Paradiso.
– Noi Ebrei non possiamo salvarci?
– No, mio caro Giona; dopo la venuta di Gesù Cristo gli Ebrei non possono più salvarsi, senza credere in Lui.
– Se mia madre viene a sapere che io voglio farmi cristiano, guai a me! – Non temere; Dio è padrone dei cuori, e se Egli ti chiama a farti cristiano, farà in modo che tua madre si contenterà o provvederà in qualche modo all’anima tua.
– Ma tu che mi vuoi tanto bene, se fossi al mio posto che faresti?
– Comincerei ad istruirmi nella religione cristiana; in tanto Dio aprirà la via a quanto si dovrà fare in avvenire. A questo scopo prendi il piccolo Catechismo e comincia a studiarlo. Prega Dio che ti illumini e che ti faccia conoscere la verità.
Giona da quel giorno cominciò ad essere affezionato alla fede cristiana. Recavasi al caffè, e fatta appena una partita al bigliardo, cercava tosto di Giovanni per discorrere di religione e di ciò che andava imparando dal Catechismo. Nello spazio di pochi mesi apprese a fare il segno della santa Croce, il Pater, l’Ave Maria, il Credo ed altre verità principali della fede. Egli ne era contentissimo, ed ogni giorno diventava migliore nel parlare e nell’operare. [322] Fin da fanciullo aveva perduto il padre. La madre sua, di nome Rachele, aveva già inteso qualche voce vaga, sulla possibilità che il figlio propendesse a cambiar di religione, ma non sapeva ancora niente di positivo. La cosa si scoprì in questo modo. Un giorno, assettandogli il letto, trovò il Catechismo che il figlio aveva inavvedutamente dimenticato tra il materasso ed il saccone. Si mise ella a gridare per casa, portò il Catechismo al Rabbino e sospettando di quello che era di fatto, corse frettolosa dallo studente Bosco, di cui aveva più volte udito a parlare da suo figlio medesimo.
Per aver un’idea della madre di Giona, bisogna immaginarsi il tipo della bruttezza. Era cieca da un occhio, sorda da ambe le orecchie; naso grosso; quasi senza denti, labbra esorbitanti, bocca torta, mento lungo ed acuto, voce simile al nitrito di un poledro. Gli Ebrei solevano chiamarla col nome di Maga Lili, col qual nome sogliono esprimere la cosa più brutta di loro nazione. La sua comparsa spaventò Giovanni, al quale l’Ebrea, senza dargli tempo di riaversi, prese così a parlare: – Affè che giuro, voi avete torto: voi, sì, voi avete rovinato il mio Giona; l’avete disonorato in faccia al pubblico; io non so che sarà di lui. Temo che finisca col farsi cristiano, e voi ne siete la causa. – Giovanni, che non conosceva ancora la madre dell’amico, dalle parole comprese chi fosse e di chi gli parlasse; e con tutta calma rispose che ella doveva essere contenta e ringraziare chi faceva del bene a suo figlio.
– Che bene è mai questo? Sarà un bene a far rinnegar la propria religione?
– Calmatevi, buona signora, le disse Giovanni ed ascoltate. Io non ho cercato il vostro Giona, ma ci siamo incontrati nella bottega del libraio Elia. Siamo diventati amici, senza saperne la cagione. Egli porta molta affezione a me; io lo [323] amo assai, e da vero amico desidero che egli si salvi l’anima e che possa conoscere quella religione, fuori di cui niuno può salvarsi. Notate bene, o madre di Giona, che io, sì, ho dato un libro a vostro figlio, ma gli dissi soltanto d’istruirsi nella religione e che facendosi cristiano non abbandonerebbe la religione ebraica, ma la perfezionerebbe.
– Se per disgrazia egli si facesse cristiano, dovrebbe abbandonare i nostri Profeti, perchè i cristiani non credono ad Abramo, Isacco e Giacobbe, nè a Mosè ed ai Profeti.
– Anzi noi crediamo a tutti i santi Patriarchi e a tutti i Profeti della Bibbia. I loro scritti, i loro detti, le loro profezie formano il fondamento della fede cristiana.
– Se mai fosse qui il nostro Rabbino, egli saprebbe che rispondere. Io non so nè il Misna, nè il Gema (sono le due parti del Talmud). Ma che ne sarà del mio povero Giona?
Ciò detto se ne partì. Qui sarebbe lungo riferire le molestie che ebbe a soffrire Giovanni, e gli attacchi fatti più volte al povero Giona dalla madre, dal Rabbino, dagli altri parenti. Non fu minaccia, violenza, che non siasi usata contro al coraggioso giovinetto ebreo. Egli tutto soffrì e continuò ad istruirsi nella fede. Siccome in famiglia non era più sicuro della vita, così si dovette allontanare da casa e vivere quasi mendicando. Molti però gli vennero in aiuto; e affinchè ogni cosa procedesse colla dovuta prudenza, Giovanni raccomandò il suo allievo ad un dotto sacerdote, che si prese di lui cura paterna. Allorchè fu a dovere istrutto nella religione, mostrandosi impaziente di farsi cristiano, fu battezzato con grande solennità, che tornò di buon esempio a tutti i Chieresi e di eccitamento ad altri Ebrei, di cui parecchi abbracciarono più tardi il Cristianesimo. Il padrino e la madrina furono Carlo ed Ottavia coniugi Bertinetti, i quali provvidero a quanto occorreva al neofito, che divenuto [324] cristiano, potè col suo lavoro procacciarsi onestamente il pane della vita. Il nome imposto al neofito fu Luigi. Egli condusse vita veramente cristiana e conservò sempre per Giovanni Bosco grande affetto e viva riconoscenza. Non di rado si recava a visitarlo in Torino, e, chi scrive queste pagine, lo incontrò verso il 1880 nell’Oratorio di S. Francesco di Sales.
Erano le primizie dell’apostolato di Giovanni, caparra di grazie celesti senza numero. Dice infatti l’Apostolo S. Giacomo: Fratelli miei, dovete sapere che quegli che indurrà a conversione uno che devia dalla verità, come pure chi farà che uno peccatore si converta dal suo traviamento, salverà l’anima propria dalla morte e cuoprirà la moltitudine dei peccati”[80].
CAPO XXXVII.
L’onomastico del professor Banaudi ed una disgrazia – Con uno splendido esame Giovanni finisce il corso di umanità – Suo incontro col Teol. Antonio Cinzano – Paterna affezione del nuovo prevosto di Castelnuovo per Giovanni.
GRANDI erano i progressi che Giovanni andava facendo nella lingua italiana, latina e greca, sotto la guida del professore Sac. Pietro Banaudi, vero modello di insegnante. Senza mai infliggere alcun castigo, questi era riuscito a farsi temere ed amare da tutti i suoi allievi. È li amava tutti quei figli, ed essi d’altrettanto amore lo ricambiavano qual tenero padre. Per dargli un segno d’affezione, fu deliberato fra tutti di solennizzare il suo giorno onomastico con una opportuna accademiola, in cui si declamarono prose e poesie e gli si presentarono alcuni doni di suo speciale gradimento. La festa riuscì splendida, ed il maestro ne fu arcicontento, tanto che per manifestare la sua piena soddisfazione volle condurre tutti i suoi discepoli a fare un pranzo in campagna. Amenissima fu la giornata; fra professore ed allievi eravi un cuor solo ed un’anima sola, ed ognuno studiava modi per esprimere la gioia che provava. Prima di rientrare nella città di Chieri il professore incontrò un forestiere, con cui si dovette accompagnare, lasciando soli gli allievi per un [326] breve tratto di via. In quel momento si avvicinarono a costoro alcuni compagni di classi superiori per invitarli ad un bagno nel sito detto la fontana rossa, canale largo e profondo che allora conduceva le acque ad un mulino, distante circa un miglio da Chieri. Giovanni con alcuni discepoli si oppose, ma inutilmente; parecchi con Giovanni vennero in città, altri vollero andare a nuotare. Triste deliberazione. Poche ore dopo l’arrivo a casa dei più giudiziosi, giunge un compagno, poi un altro, spaventati ed ansanti, dicendo: – Oh se sapeste mai! se sapeste mai! Filippo N., quello che insistette tanto perchè andassimo a nuotare, è rimasto morto. – Come! – tutti domandarono – egli era così famoso a nuotare!! – Che volete mai? – continuò l’altro – per incoraggiarci a sommergerci nell’acqua, confidando nella sua perizia e non conoscendo i vortici della pericolosa fontana rossa, si gettò per primo. Noi aspettavamo che ritornasse a galla, ma fummo delusi. Ci siamo messi a gridare, venne gente, si usarono molti mezzi, e non fu senza pericolo altrui che dopo un’ora e mezzo si riuscì a trarne fuori il cadavere. L’infortunio cagionò in tutti tristezza profonda, nè per quell’anno, nè per l’anno seguente si è mai più udito a dire che alcuno abbia anche solo espresso il pensiero di andare a nuoto.
Frattanto l’anno di umanità volgeva al suo termine e nell’agosto 1834 il prof. Lanteri venne da Torino a Chieri per dare l’esame finale. Il nostro Giovanni fu subito a visitarlo. Che cosa volete, mio caro? gli chiese Lanteri. Una cosa sola: che mi dia buoni voti. Guarda un po’ con quale franchezza parla costui! esclamò Lanteri sorridendo. Certamente, perchè io sono molto amico del professore Gozzani. Davvero? Allora saremo anche noi amici! Ben volentieri! Ma sappia che Gozzani mi ha dati buoni voti. Venuto il giorno dell’esame, Giovanni fu trovato [327] preparatissimo. Interrogato su Tucidide, rispose a meraviglia. Allora Lanteri prese in mano un volume di Cicerone:
– Che cosa vuoi che prendiamo a spiegare di Cicerone?
– Ciò che crede. – Lanteri apre il libro e gli cadono sott’occhi i Paradossi. – Vuoi tradurre? – Come desidera, e se permette sono pronto a recitarli a memoria. – Possibile? – Giovanni senz’altro incominciò a recitare il titolo in greco e quindi proseguiva. – Basta! esclamò stupito ad un certo punto il professor Lanteri, dammi la mano; voglio che siamo amici davvero. – E prese a parlare famigliarmente di cose estranee alla scuola.
I suoi professori, specialmente il dottor Banaudi, lo avevano consigliato di chiedere l’esame per la filosofia, cui venne difatti promosso. Ma siccome amava lo studio delle lettere, dopo aver riflettuto, giudicò bene di continuare regolarmente le classi e fare retorica, ossia quinta ginnasiale. Alcuni professori suoi amici, ai quali aveva chiesto consiglio, approvarono la sua deliberazione, specialmente perchè avrebbe potuto perfezionarsi nello scrivere, acquistando purità e proprietà di lingua. Non prevedeva ancora Giovanni che il Signore voleva essere da lui servito eziandio colla penna e che i suoi scritti, così gradevoli al popolo, avrebbero procurata la salvezza di migliaia di anime!
Ringraziando Iddio per l’esito felice degli esami, Giovanni era tornato presso la madre, e secondo la sua abitudine costante prestava aiuto in quel che poteva al fratello Giuseppe nella cascina del Susambrino, continuando però lo studio de’ suoi libri prediletti e le radunanze de’ suoi giovani amici. In uno di quei primi giorni di vacanza, mentre con un libro in mano conduceva una vacca al pascolo, incontrò nella via che attraversava la valle D. Cinzano, l’economo spirituale di Castelnuovo, che andava a visitare ammalati. Ammirato dal [328] contegno di quel giovane, che vedeva per la prima volta, D. Cinzano gli dimandò chi fosse, a che cosa aspirasse; e udito essere quel Giovanni Bosco, del quale aveagli parlato Evasio Savio, s’intrattenne alquanto con lui, interrogandolo sugli studi fatti e sul desiderio che nutriva di essere un giorno sacerdote. Fu così soddisfatto dalle risposte di Giovanni che, ritornando poco dopo in quei dintorni, lo fece chiamare a sè, e dopo brevi interrogazioni, meravigliando del suo spirito pronto e profondamente cristiano, concepì le più liete speranze. Quindi gli disse: – Io non tengo ancora casa aperta in Castelnuovo, dovendo sovente assentarmi Se tu vuoi venire in canonica per custodirla, quasi in qualità di portinaio, io ti concedo l’alloggio in essa. Ti somministrerò il pane e Maria Febraro ti preparerà un po’ di minestra. Quivi avrai tutta la comodità di studiare. Chiedi licenza a tua madre e vieni presto. – Giovanni accettò colla massima contentezza la proposta e fu puntuale al suo nuovo ufficio.
Questo incontro provvidenziale troncò un nuovo ordine di idee, che Giovanni andavasi formando nella sua mente. Benchè fosse ossequente al consiglio di D. Cafasso, tuttavia vagheggiava il disegno di consacrarsi alle missioni straniere, tanto più che allora in Piemonte, benchè appena incominciata, già giganteggiava l’Opera della Propagazione della Fede, fondata in Lione. Le Lettere edificanti dell’Opera, che descrivevano le fatiche e i martiri dei Missionari, erano lette con avidità. Senza la sicurezza che il Teol. Cinzano ed altri benefattori lo avrebbero aiutato, egli si sarebbe fatto missionario. Così egli stesso confidava al prof. D. Giovanni Turchi. Tuttavia non è a credersi che fossero velleità. Dio benedetto servivasi delle umane contrarietà per fargli concepire ed aumentare in cuore un desiderio che conserverà perennemente, finchè non l’abbia mandato in esecuzione. Egli è destinato non solo ad essere [329] religioso e missionario, ma fondatore di Congregazioni religiose e di estese Missioni nei paesi stranieri ed infedeli.
- Cinzano, ottenuta la parrocchia di Castelnuovo per concorso, nel mese di agosto ne prese solennemente possesso. E Giovanni in tutto il tempo delle vacanze continuò a frequentare la canonica, prestando tutti quei servigi che poteva. Il prevosto ammirava la pietà del suo protetto, ed essendo uomo di lettere, si intratteneva spesse volte con lui sulle materie studiate, sulla bellezza della lingua e dello stile degli autori spiegati, sul modo d’interpretarli e aperse a Giovanni, direi quasi, nuovi orizzonti. Più tardi, D. Cinzano, rammentando con entusiasmo i primi mesi, nei quali ebbe con sè Giovanni, fra le altre cose narrava, alla presenza di venti e più persone da lui convitate, tra le quali Giuseppe Buzzetti e molti giovani dell’Oratorio, come nel 1834 gli fosse stato detto dai terrazzani che il giovanetto Bosco era dotato di memoria così pronta e tenace, da facilmente ritenere e ripetere a’ suoi compagni le prediche e le istruzioni ascoltate in chiesa; che egli perciò una domenica, discendendo dal pulpito, lo volle intrattenere per interrogarlo e accertarsi della verità di quanto si diceva, e che Giovanni gli ripetè, con sua meraviglia, tutta intiera la predica da lui fatta, senza esitare un solo istante. E lo descriveva come fornito di grande ingegno, di straordinaria costanza nello studiare, pieno di virtù e zelante del bene morale e religioso de’ suoi compagni, rappresentandolo quale un piccolo missionario. Soggiungeva come più volte gli manifestasse vivo desiderio di farsi prete, per occuparsi in modo speciale della gioventù, verso la quale sentiva un’irresistibile inclinazione.
D’allora in poi tra D. Cinzano e Giovanni Bosco fu stretta una relazione vivissima, quale tra padre e figlio. Più volte lo presentò a D. Cafasso, pregandolo ad interessarsi [330] di lui. Non era necessaria, ma però sempre utilissima la raccomandazione di questo buon pastore.
Dopo tanti anni di contraddizioni, la Provvidenza dava tregua alle prove. Giovanni, colla sua eroica costanza e fiducia, erasi mostrato degno della missione, che gli aveva preparato. L’opera sua però non è ancora compiuta: la statua ha bisogno ancora di qualche colpo di martello: la pianta, già cresciuta e che si apparecchia a produrre abbondantissimi frutti, ha qualche ramo, che tolto le darà più bellezza e vigore. Ma questo lavoro non è più un dolore, è un premio. L’amicizia cristiana avrà per compito questo perfezionamento.”L’amico fedele è balsamo di vita e d’immortalità, e quelli che temono il Signore lo troveranno. Chi teme Iddio avrà una buona amicizia, perchè il suo amico sarà simile a lui”[81]. Finite le vacanze e andando Giovanni a Chieri pel corso, di retorica, il vicario stesso lo collocò a dozzina presso un tal Cumino sarto, a lire 8 al mese, che egli si industriava di pagare coll’aiuto pure di persone benefiche e specialmente dei signori Pescarmona e Sartoris. I coniugi Cumino, presso i quali era pur stato in pensione per quattro anni lo studente, Cafasso, avevano la loro abitazione vicino alla spaziosa piazza di S. Bernardino, accanto alla quale sorge la chiesa di S. Antonio. Una stanza a pianterreno, che serviva di rimessa ad una carrozzella o di stalla, fu destinata per dormitorio Giovanni, il quale vi pernottò vari mesi, come ci affermavano il signor Pianta ed altri anziani della città. Ma la mano benefica di D. Cafasso, che largheggiava in sovvenzioni col suo antico albergatore, gli ottenne alloggio più conveniente ed altri non disprezzabili vantaggi.[331]
La notizia dell’incontro di Giovanni col teol. Cinzano e delle prime beneficenze di questo buon sacerdote verso il povero studente l’ebbimo in iscritto e a voce da D. Febraro. Castelnovese, parroco in Orbassano, il quale l’apprese dalla bocca stessa del vicario di Castelnuovo, presso cui stette vicecurato per parecchio tempo.
Giovanni a Chieri trovò che il prof. Banaudi, stanco dai molti anni d’insegnamento, erasi ritirato dalla scuola e gli era succeduto il giovanissimo teol. Giovanni Bosco, che incominciava allora la sua carriera d’insegnamento.
CAPO XXXVIII.
La classe di retorica – Luigi Comollo e sua relazione con Giovanni – Questi lo difende contro alcuni insolenti – Umile confessione – Begli esempi dell’amico.
BEATO Chi trova un vero amico. L’amico fedele è una protezione possente; e chi lo trova, ha trovato un tesoro. Nessuna cosa è da paragonarsi all’amico fedele; e non è degna una massa d’oro e d’argento di essere messa in bilancia colla bontà della fede di lui[82]. Questa felicità l’ebbe il nostro caro Giovanni, nel suo anno di retorica. È un tratto invidiabile della sua vita, e noi lo lasceremmo raccontare da lui medesimo.
“Sul cominciare dell’anno scolastico 1834 – 35, tempo in cui io frequentava la scuola di retorica nella città di Chieri, mi trovai casualmente in una casa di pensione del fu Marchisio Giacomo, ove si andava parlando delle buone qualità di alcuni studenti: – Mi fu detto, prese a narrare il padrone di casa, mi fu detto che a casa del tale vi deve andare uno studente santo. – Io feci un sorriso, prendendo la cosa per facezia. – È appunto così, soggiunse il padrone, ci deve essere il nipote del prevosto di Cinzano, giovane di segnalata virtù. Suo zio sacerdote è pure assai rinomato per santità di vita. [333]
Non feci gran caso allora di queste parole, ma fra i miei compagni di retorica questa notizia aveva accesa una viva aspettazione. Io desiderava far conoscenza di questo giovane, ma ne ignorava il nome. Un fatto molto notevole però melo fece ben presto conoscere. Era già più giorni che io vedeva uno studente, sui quindici anni, che dimostrava tanta compostezza nella persona, tale modestia camminando per le vie, e tanta affabilità e cortesia con chi gli parlava, che io ne era, del tutto meravigliato. Crebbe questa meraviglia allorchè ne osservai l’esattezza nell’adempimento de’ suoi doveri e la puntualità, colla quale interveniva alla scuola. Ivi appena giunto si metteva al posto assegnato, nè più si muoveva, se, non per fare cosa che il proprio dovere gli prescrivesse.
Egli è costume degli studenti di passare il tempo d’ingresso in scherzi, giuochi e salti pericolosi. I più dissipati e meno amanti dello studio ne sono avidissimi e ordinariamente sono quelli che si rendono più celebri. A ciò pure era invitato il modesto giovinetto, ma egli si scusava sempre con dire che non era pratico, non aveva destrezza. Nulla di meno un giorno un suo compagno insolente, gli si avvicinò, mentre, senza badare agli schiamazzi altrui, era occupato a leggere o a studiare. Presolo per un braccio, colle parole con importuni scuotimenti, pretendeva costringerlo a prendere parte a quei salti smoderati che nella scuola si facevano – No, mio caro, non so, rispondeva l’altro dolcemente, e tutto umiliato; non so; non ho mai fatto questi giuochi; non sono esperto, mi espongo a far brutta figura. – Io voglio che tu venga assolutamente, altrimenti ti fo venire a forza di calci e di schiaffi. – Puoi battermi a tuo talento, ma non so, non posso, non voglio….
Il maleducato e cattivo condiscepolo, quando vide che non voleva arrendersi, lo strinse al braccio, lo urtò e poi gli [334] diede due schiaffi, che fecero eco in tutta la scuola. A quella vista io raccapricciai, mi sentii bollire il sangue nelle vene e temeva che l’offeso rendesse la pariglia a quell’impertinente; tanto più che l’oltraggiato era di molto superiore all’altro in forze ed età. Ma l’offeso aveva ben altro spirito. Quale non fu la mia meraviglia, quando il buon giovinetto, colla sua faccia rossa e quasi livida, dando un compassionevole sguardo al maligno compagno che l’aveva percosso, dissegli soltanto:
– Se questo basta per soddisfarti, vattene pure in pace, che io sono contento e ti ho già perdonato. – Quell’atto eroico mi fece ricordare di quanto avevo udito, che doveva venire alle scuole un giovanetto santo, e chiestone la patria ed il nome, conobbi essere quello appunto il giovane Luigi Comollo, nipote del prevosto di Cinzano, di cui si erano uditi tanti encomi nella pensione del Marchisio”.
Luigi Comollo era nato il 7 aprile 1817, nella borgata detta Apra del paese di Cinzano, ove era parroco. D. Giuseppe Comollo, suo zio paterno, santo e dotto ecclesiastico. Da bambino aveva mostrato grande inclinazione alla pietà; fanciulletto, nei giorni festivi raccoglieva nelle ore di ricreazione alcuni suoi coetanei per raccontar loro qualche esempio, edificante in sui dieci anni si era acquistata tale stima dai terrazzani, che, se qualcuno avesse osato pronunciare, lui presente, parole oscene: – Zitto, dicevano, gli altri: c’è Luigi che sente – Conducendo i bestiami al pascolo, leggeva sempre libretti spirituali da solo o cogli altri pastorelli e talora li invitava a pregare o a cantare laudi sacre. Per onorare la Madonna si asteneva di qualche porzione di cibo o di frutta che gli si dava, dicendo: – Questo bisogna regalarlo a Maria. Il giorno della sua prima Comunione aveva donato, col suo piccolo peculio, un vestito ad un fanciulletto povero. Amatissimo delle funzioni di chiesa, erasi deciso per lo stato [335] ecclesiastico, dicendo: – Essendo i preti quelli che aprono il Paradiso agli altri, spero che lo potrò poi aprire anche a me stesso. – I primi rudimenti di lingua latina avevali appresi dallo zio parroco. A Caselle, presso il sacerdote Strumia, compiva la terza ginnasiale. Luigi Comollo era stato sempre la consolazione e la gioia della casa paterna. Ed egli era l’amico, che la Provvidenza divina aveva preparato pel nostro Giovanni.
Simile in tutto a lui in quanto a virtù, benchè di indole diversa, Giovanni sentissi attratto verso di questo giovanetto da una viva affezione, che mai diminuì finchè visse, venendo da lui pienamente corrisposto. I modi verecondi ed umili di Comollo, quel non osare prevalersi della confidenza che gli era data, quel non ardire trattare con libertà, furono per Giovanni argomento di ringraziare il Signore. “Se l’amico si umilia dinanzi a te e si ritira dalla tua presenza, avrai un’amicizia buona e leale”[83]. “Egli faceva umanità, e quindi era a me inferiore di un corso, continua a scrivere D. Bosco; ma eravamo in una stessa scuola ed avevamo il medesimo professore. Da quel tempo l’ebbi sempre per intimo amico, e posso dire che da lui ho cominciato ad imparare a vivere da cristiano. Ho messa piena confidenza in lui; egli in me. L’uno aveva bisogno dell’altro: io di aiuto spirituale, l’altro di aiuto corporale; perciocchè il Comollo per la sua grande timidità non osava nemmeno tentare la difesa contro gli insulti dei cattivi, mentre io da tutti i compagni, anche maggiori di età e di statura, era temuto pel mio coraggio e per la mia forza gagliarda. Ciò aveva un giorno fatto palese verso di taluni, che volevano disprezzare e percuotere il medesimo Comollo ed un altro, di nome Antonio Candelo, modello di bonomia. [336]
Vedendo quegli innocenti maltrattati, io volli intervenire in loro favore, ma non si voleva badare. – Guai a voi, dissi allora ad alta voce, guai a chi fa ancora oltraggi a costoro. – Un numero notabile dei più alti e dei più sfacciati si misero in atteggiamento di comune difesa e di minaccia contro di me, mentre due sonore ceffate caddero sulla faccia del Comollo. In quel momento io mi dimenticai di me stesso ed eccitando in me non la ragione, ma la mia forza brutale, non capitandomi tra mano nè sedia, nè bastone, strinsi colle mani un condiscepolo alle spalle e di lui mi valsi come bastone a percuotere gli avversari, pronti a continuare le offese. Quattro caddero stramazzoni a terra, gli altri fuggirono gridando e dimandando pietà. Ma che? In quel momento entrò il professore nella scuola, e mirando braccia e gambe sventolare in alto in mezzo ad uno schiamazzo dell’altro mondo, si pose a gridare dando spalmate a destra ed a sinistra. Il temporale stava per cadere sopra di me, quando, fattosi raccontare la cagione di quel disordine, volle fosse rinnovata quella scena o meglio sperimento di forze. Rise il professore, risero tutti gli allievi, ed ognuno meravigliandosi, non si badò più al castigo che mi era meritato”.
Ammiriamo qui l’umiltà di Giovanni nell’esporre questo fatto. È difficile persuadersi che nel suo animo generoso non vi sia stata una forte commozione nel veder trattato così brutalmente un innocente fanciullo. Chi trovandosi in simile caso non avrebbe fatto altrettanto, anche avendo poco cuore? “Libera dalla mano del superbo colui che soffre l’ingiuria, e non sia ciò gravoso all’anima tua”, ha detto lo Spirito Santo[84]. Del resto Giovanni senza dubbio esagera il fatto. Tutti i suoi [337] compagni di ginnasio, che ci narrano gli anni della sua giovinezza, convengono nel dipingerlo quale modello di mansuetudine. E noi sappiamo che egli, battuto ed insultato, sopportò pazientemente l’ingiuria senza difendersi. D’altronde, il professore non avrebbe fatto ripetere quella scena, se avesse avuto carattere non di giusta difesa, ma di smoderata vendetta, e se fosse stata in qualche modo di danno o pericolo alla clava vivente o a coloro che erano percossi. D. Bosco stesso, raccontando talora questo aneddoto a’ suoi preti nelle ore di ricreazione, gli dava un tale aspetto mescolato comicamente di scherzevole e di serio, da far smascellare dalle risa chi lo ascoltava. Tuttavia, se questo fu un lampo del suo naturale ardente, dimostra quali eroici sforzi facesse continuamente per tenersi a freno, in maniera da essere giudicato da quanti lo conobbero nella lunga sua vita come il più mite degli uomini. In lui vediamo realmente avverarsi ciò che dice lo Spirito Santo dell’uomo giusto: “Il giusto è primo ad accusare se stesso; vien poi il suo amico e lo tiene a sindacato”[85]; perchè il giusto è contento che l’amico lo rimproveri.
Dopo la descrizione del fatto suesposto, leggiamo ancora nel manoscritto di D. Bosco: “Ben altre lezioni mi dava Comollo: – Mio caro, dissemi appena mi potè parlare tra noi soli, la tua forza mi spaventa; ma credimi, Dio non te la diede per massacrare i compagni. Egli vuole che ci amiamo, ci perdoniamo e che facciamo del bene a quelli che ci fanno del male. – Egli infatti d’indole dolcissima, non si vide mai altercare con alcuno de’ suoi compagni, ma alle ingiurie ed alle derisioni rispondeva sempre colla pazienza [338] e coll’affabilità. Io ammirai la carità del venerato mio collega, e mettendomi affatto nelle sue mani, mi lasciava guidare dove e come voleva egli. D’accordo coll’amico Garigliano, andavamo insieme a confessarci, comunicarci, fare la meditazione, la lettura spirituale, la visita al SS. Sacramento, a servire la santa Messa. Comollo sapeva invitare con tanta bontà, dolcezza e cortesia, che era impossibile rifiutarsi ai suoi inviti”. È proprio vero che “l’unguento e la varietà degli odori rallegrano il cuore, e i buoni consigli dell’amico dando conforto all’anima”.[86]
Mi ricordo che un giorno, chiacchierando con lui, passai davanti ad una chiesa senza scoprirmi il capo. Egli mi disse tosto in modo assai garbato: – Giovanni mio, tu sei così attento a discorrere cogli uomini, che dimentichi perfino la casa del Signore. – Altra volta accadde che, scherzando, mi servii sbadatamente parole della S. Scrittura, udite da persone di chiesa. Comollo vivamente mi riprese dicendomi non doversi faceziare colle parole del Signore.
Interrogandolo un giorno sui monumenti più ragguardevoli di Chieri, e vedendo come egli non ne fosse punto informato, gli dissi: – Tante persone partono da lontano per venirli a vedere, e tu che dimori in Chieri non ti dai nemmeno pensiero di visitarli. – Eh, mio caro, rispose scherzando; ciò che non giova per domani, mi do poca premura di cercarlo oggi – volendomi con ciò significare che se tali rarità avessero contribuito ai beni eterni, che formavano il suo domani, non le avrebbe trascurate.
In un giorno di vacanza, mentre ritornavamo da una passeggiata, traversando Chieri e giunti alla piazza detta [339] del Piano, ci siamo trovati vicino ad un saltimbanco, che con giuochi e salti tratteneva i buontemponi e gli oziosi. – Guarda qui un momento, dissero due compagni al Comollo; ascolta che belle cose! costui ne dice tante, che fa ridere assai – Il Comollo con una strappata si licenziò dai due poco delicati amici, dicendo: – Costui dirà dieci parole per farvi ridere, ma l’undecima è cattiva e vi darà scandalo; d’altronde mio zio mi ha molto raccomandato di non mai fermarmi ad assistere nè ai ciarlatani, nè ai saltimbanchi, nè ai giocatori di bussolotti, nè ad altri pubblici spettacoli; perchè egli diceva: In questi luoghi uno può andare coll’anima innocente, ma sarà un miracolo se ne ritorna nel medesimo stato”. Quest’ultimo aneddoto, che D. Bosco stesso stampò nella biografia di Comollo, sembra a prima vista quasi un indiretto rimprovero per lui, che a simili giuochi fin da giovinetto soleva intervenire; ma ponderando attentamente le cose, non lo ferisce menomamente. La sua semplicità ed innocenza di costumi, la sua retta coscienza ed il fine santo onde accorreva a quei divertimenti, ben giustificano quanto egli aveva fatto ne’ suoi primi anni, senza alcun danno della sua anima, e con grande vantaggio di quelle del prossimo. In tutto il tempo della sua vita ebbe per norma il gran detto: Ama et fae quod vis. Da ciò quel suo modo di agire franco, senza angustie di spirito, e colla piena libertà dei figliuoli di Dio. La carità espelle il timore. Appena ebbe appreso quanto reputava necessario, tralasciò di assistere agli spettacoli sulle piazze; rinunzierà ai giuochi di ginnastica, quando vedrà questi repugnanti al contegno necessario nello stato di persona che si vuol consacrare al Signore; continuerà però nei giuochi di prestigio per più anni ancora, essendo essi mezzo acconcissimo per attirargli l’affezione dei giovani e causa di onesta ricreazione agli amici. Per lui contadinello erano anzi [340] una indispensabile scuola per formarlo alla sua missione, rendendolo disinvolto, gioviale, padrone delle assemblee, conservando sempre modi convenienti, riservati, improntati a virtù. Un aspetto di asceta e di penitente sarebbe stato ributtato dalla società, che si andava allora formando e in mezzo alla quale egli doveva vivere.
È cosa commovente vedere come D. Bosco conservasse religiosamente i consigli dell’amico suo, e ciò è prova della sua grande umiltà. Afferma aver egli da Luigi Comollo imparato a vivere da cristiano; ma il fatto si è, come ce ne assicura D. Giacomelli loro compagno ed intimo, che Bosco e Comollo reciprocamente si ammonivano per correggersi dei propri difetti, si animavano l’un l’altro a progredire nella perfezione, si eccitavano ad impiegare utilmente tutto il tempo e s’invitavano ad accostarsi con molta frequenza e regolarità ai SS. Sacramenti. Comollo aveva in Giovanni un compagno di speciale confidenza per conferire di cose spirituali. “Il trattare e parlare di tali argomenti con lui, scrive D. Bosco, tornavagli di grande consolazione. Ragionava con trasporto dell’immenso amore di Gesù nel darsi a noi in cibo nella santa Comunione. Quando discorreva della B. Vergine, si vedeva tutto compreso di tenerezza, e dopo aver raccontato o udito raccontare qualche grazia concessa a favore del corpo, egli, sul finire, tutto rosseggiava in volto ed alle volte rompendo anche in lagrime, esclamava – Se Maria favorisce cotanto questo miserabile corpo, quanti non saranno i favori che sarà per concedere a pro delle anime di chi la invoca? Oh! Se tutti gli uomini fossero veramente divoti di Maria, che felicità ci sarebbe in questo mondo!” – Tali espansioni di cuore non si fanno, se non a quelli che sono capaci di intenderle e gustarle. E tale era Giovanni, il quale per modestia tace il suo nome. [341] Luigi Comollo poteva essere proposto per esemplare ad ogni giovane per l’intemerata condotta, per l’ubbidienza e la docilità sua. In un’età, che è tanto vaga di mutazioni si manteneva uniforme e costante nella pratica di ogni virtù. Amantissimo del ritiro, non usciva mai senza licenza dei padroni di casa, ove stava in pensione, ed era di grande stimolo per gli altri pensionanti a vivere virtuosamente. D’umore sempre eguale ed allegro, non dava mai a conoscere quello che fosse di speciale suo gusto. Giovanni, che era con lui in tanta famigliarità, non l’udì mai querelarsi del caldo o del freddo delle stagioni, del cibo, del troppo lavoro o del troppo studio; anzi, qualora avesse avuto un po’ di tempo libero, tosto correva da qualche compagno per farsi schiarire alcune difficoltà. Volentieri discorreva di storia, di poesia, di lingua italiana o latina, e questo in maniera umile e gioviale sì, che, mentre proferiva il proprio sentimento, mostrava sempre di sottometterlo all’altrui.
Come studente primeggiava per ingegno tra i giovani più distinti. Era così diligente nello studio, che il suo professore ebbe a dire di non ricordarsi di averlo mai avuto a rimproverare della benchè minima negligenza.
Assiduo alle congregazioni delle scuole, compostissimo, sempre attento alla divina parola, devotissimo nell’assistere alla santa Messa, professava la massima riverenza e rispetto ai sacri ministri, e non permetteva che nessuno, con ischerzi o narrazioni, mancasse loro di ossequio.
Nei giorni festivi, terminate le funzioni nella cappella della congregazione, per lo più gli studenti andavano al passeggio od a qualche altro divertimento; ma il Comollo, persuaso di poter fare a meno di questi passatempi, tosto recavasi con Giovanni al catechismo dei fanciulli, solito a farsi nella chiesa di S. Antonio. [342] Ogni giorno Comollo andava puntualmente al duomo a visitare il SS. Sacramento, e Giovanni per varii mesi colà recavasi appunto in quell’ora per riceverne edificazione. Così egli ce lo descrive: “Di solito ponevasi in qualche canto più vicino all’altare, ginocchioni, colle mani giunte, col capo mediocremente inclinato, cogli occhi bassi e tutto, immobile della persona; insensibile a qualunque voce o rumore. Non di rado mi avveniva, che, compiuti i miei doveri, voleva invitarlo a venir meco per essere da lui accompagnato a casa; ma aveva un bel far cenno col capo, passandogli vicino, o tossire, perchè egli si movesse; era sempre lo stesso, immobile, finchè io accostandomi non lo scuoteva. Allora, come risvegliato dal sonno, si moveva, e sebbene a malincuore aderiva al mio invito. Egli serviva molto volentieri alla santa Messa anche nei giorni di scuola, quando poteva; ma nei giorni di vacanza servirne quattro o cinque era per lui cosa ordinaria. Se il tempo glielo permetteva, interveniva ad ogni religiosa funzione, che si celebrasse nelle chiese della città. Benchè fosse così concentrato nelle cose di spirito, non vedevasi mai rannuvolato in volto o tristo, ma sempre ilare e contento. Colla dolcezza del suo parlare rallegrava tutti quelli, con cui trattava, ed era solito a dire che gli piacevano grandemente quelle parole del Profeta David: Servite Domino in laetitia Servite il Signore in santa allegrezza”.
CAPO XXXIX.
Giuochi di prestigio – Giovanni è accusato di magia – Come si discolpa.
COME negli anni precedenti, così anche in questo, Giovanni è sempre apportatore di allegrezza in tutti i luoghi, nei quali mette piede. La sua urbanità contegnosa, schietta, cordiale, ilare, innamora. Nelle case di Chieri, nei ritrovi dei giovani appartenenti alla Società dell’Allegria, egli è desideratissimo, invitato e bene accolto eziandio per le meraviglie che sa operare coi giuochi di destrezza. L’onesta ricreazione è sempre lecita in tempo opportuno. Que’ giuochi talmente interessano coloro che vi assistono, da non aver tempo a pensare o parlare di altro. Giovanni colle sue parole s’impadronisce così delle loro menti, da trarle dove vuole.
Uccidere un passero, pestarlo nel mortaio, metterlo in una canna di pistola, sparare e vederlo volar via vivo e sano, era uno dei prestigi che facea più sovente. Dalla stessa bottiglia traeva vino bianco o nero, a richiesta dei convitati. Un giorno scommise di far scomparire un largo piatto di agnellotti preparati in cucina e mandarli in un’altra casa della borgata. Gli uni nascostamente facevano segno sul piatto: tutti curiosamente stavano all’erta; ma dopo segni, parole incomprese [344] e lunghe questioni, Giovanni annunzia che il prestigio è fatto ed invita tutti ad andare nella casa indicata ad accertarsi. Tutti prendono la corsa per quella volta e vi trovano infatti la vivanda identica promessa. Si capisce come può essere andata la cosa; ma ci vuole una presenza di spirito non comune, per assorbire i pensieri, preoccupare tanto le intelligenze dei testimoni, che non si avvedano del modo e del momento del giuoco. Era valentissimo nel maneggiare i bussolotti. Il veder uscire da un piccolo bussolotto tante palle tutte più grosse di quello, da un piccolo taschetto tirar fuori mille uova, erano cose che facevano trasecolare. Quando però lo videro raccogliere pallottole dalla punta del naso degli astanti, indovinare i denari che si trovavano nella saccoccia altrui; quando al semplice tatto delle dita si riducevano in polvere monete di qualsiasi metallo, o si faceva comparire l’udienza intera di orribile aspetto ed anche senza testa, allora si cominciò da taluno a dubitare che Giovanni fosse un mago, che non potesse operare quelle cose senza l’intervento di qualche diavolo.
Accresceva credenza il suo padrone di casa, di nome Tommaso Cumino. Era desso un fervoroso cristiano, che amava però molto lo scherzo, e, Giovanni sapeva approfittarsi del suo bel carattere o meglio della sua dabbenaggine, per far gliene di tutti i colori. Un giorno, avendo preparato con grande cura una buona gelatina con un pollo da regalare a’ suoi pensionari nel suo dì onomastico, quando si portò in tavola il piatto e lo si ebbe scoperto, con meraviglia di tutti ne saltò fuori un gallo, che, svolazzando, si diede a cantarellare. Altra volta, volendo apprestare una pentola di maccheroni, dopo averli fatti cuocere assai lungo tempo, nell’atto di versarli nel piatto trovò altrettanta crusca asciutissima. Più volte, dopo aver empita la bottiglia di vino, versandolo nel bicchiere [345] trovò limpida acqua; e quando voleva bere acqua, trovavasi invece il bicchiere pieno di vino. Le confetture convertirsi in fette di pane; il danaro della borsa tramutarsi in inutili e rugginosi pezzetti di latta; il cappello divenire cuffia; noci e nocciuole cangiarsi in sacchetti di minuta ghiaia erano cose assai frequenti. Talora Giovanni gli facea sparire gli occhiali, che poi ritrovava nelle sue saccocce, dove pure avea prima frugato e rifrugato fino a rinversarle. Un oggetto gelosamente riposto, come sarebbe un portafoglio, gli compariva d’innanzi; e un altro, che avea sott’occhio, in un momento si rendea irreperibile ad un cenno del suo pensionante. Sovente erangli presentate varie carte da giuoco, perchè ne scegliesse una qualunque, e poi si veniva ad indovinare quale avesse preso. Altre volte gli si diceva di pensare una cifra, sommarla, moltiplicarla e diminuirla, finchè gli si scopriva quale avesse pensato. Egli rimaneva stordito. Accadde che, fatta scommessa di far venir presente una chiave, che sapeasi certamente essere altrove, questa si trovò in fondo alla zuppiera appena fu scodellata la minestra.
Il buon Tommaso a simili scherzi, che si, può dire accadevano ogni giorno, non sapeva dire altro fuorchè: – Gli uomini non possono fare queste cose; Dio non perde tempo in tali inutilità; dunque è il demonio che fa tutto ciò. – E già aveva quasi deliberato di congedare Giovanni da sua casa. Non osando parlare con quei di casa, pensò di consigliarsi con un vicino sacerdote, D. Bertinetti. Andò quindi un bel giorno a visitarlo e quasi esterrefatto: – Signore, gli disse, vengo da lei per un affare serio di coscienza. Credo di avere in casa un mago! – E narrò al buon prete una filatessa di cose, che avea viste e di cose che non avea viste, cioè che sospettava, e le dipinse con tanta vivezza di colori, che trasfuse la sua persuasione in D. Bertinetti. Il quale, scorgendo anche [346] esso in quei trastulli una specie di magia bianca, decise di riferire la cosa al delegato delle scuole, che era in quel tempo un rispettabile ecclesiastico, il canonico Burzio, arciprete e curato del duomo. Fu incaricato il campanaro del duomo, Pogliano, presso il quale Giovanni continuava a ritirarsi per studiare, di avvertire il giovane che si recasse da lui per esaminarlo, non ostante che il medesimo campanaro conosceva a fondo, assicurasse al riguardo l’arciprete.
Il canonico Burzio era persona assai istrutta, pia, prudente. Giovanni giunse in sua casa mentre recitava il breviario e subito dopo che aveva dato alcune monete ad un poverello. Il buon canonico, guardandolo con sorriso, gli accennò di attendere alquanto; quindi gli disse di seguirlo nel gabinetto e prese ad interrogarlo sulla sua fede, cioè sul catechismo Giovanni rispose a meraviglia, ma prevedendo dove sarebbe andato a finire quell’esordio, a stento frenava le risa. Il sacerdote passò a domandargli come impiegasse la sua giornata e le risposte furono soddisfacentissime. Franco era il parlare del giovane, ragionevole l’esposizione, e non compariva ne’ suoi modi ombra d’inganno. L’esaminatore però non ancor pago, con parole cortesi, ma con aspetto severo, continuò ad interrogarlo: – Mio caro, io sono molto contento del tuo studio e della condotta che hai tenuto finora; ma ora si raccontano tante cose di te …..Mi dicono che tu conosci i pensieri degli altri, indovini il danaro che altri ha in saccoccia, fai vedere bianco, quello che è nero, conosci le cose da lontano e simili. Ciò fa parlare assai di te; e taluno giunse a sospettare che tu ti serva della magia, e che perciò in quelle opere vi sia lo spirito di Satana. Dimmi adunque: chi ti ammaestrò in questa scienza? dove l’hai imparata? dimmi ogni cosa in modo confidenziale; ti assicuro che non me ne servirò, se non per farti del bene. [347] Senza scomporsi di aspetto, Giovanni gli chiese cinque minuti di tempo a rispondere, e lo invitò a dirgli l’ora precisa. Il canonico mise la mano in tasca e più non trovò il suo orologio. – Se non ha l’orologio, soggiunse Giovanni, mi dia una moneta da cinque soldi. – Il canonico frugò in ogni saccoccia, ma non trovò più la sua borsa – Briccone, prese a dirgli tutto incollerito: o che tu sei servo del demonio, o che il demonio serve a te. Tu mi hai già involato borsa ed orologio. Io non posso più tacere, sono obbligato a denunziarti, e non so come mi tenga dal non darti un sacco di bastonate. – Ma, nel rimirare Giovanni calmo e sorridente, parve acquietarsi alquanto e ripigliò: – Prendiamo le cose in modo pacifico: spiegami questi misteri. Come fa possibile che la mia borsa e il mio orologio uscissero dalle mie saccocce, senza che io me ne sia accorto? dove sono andati questi oggetti?
– Signor arciprete, rispose Giovanni rispettosamente; io spiego tutto in poche parole. È tutta destrezza di mano, intelligenza presa, o cosa preparata.
– Che intelligenza vi potè essere pel mio orologio e per la mia borsa?
– Spiego tutto in breve. Quando giunsi in casa sua, ella dava elemosina ad un bisognoso, di poi mise, la borsa sopra un inginocchiato. Andando poi di questa in altra camera, lasciò l’orologio sovra questo tavolino. Io nascosi l’uno e l’altro, ed ella pensava di avere quegli oggetti con sè, mentre invece erano sotto a questo paralume. – Ciò dicendo, alzò il paralume, e si trovarono ambedue gli oggetti creduti dal demonio portati altrove. Rise non poco il buon canonico; gli fece dar saggio di alcuni atti di destrezza, e come potè conoscere il modo con cui le cose facevansi comparire e disparire, ne fu molto allegro, fece a Giovanni un piccolo regalo e in fine [348] conchiuse: – Va a dire a tutti i tuoi amici che ignorantia est magistra admirationis.
Giovanni pertanto, discolpatosi che ne’ suoi divertimenti non vi era magia bianca, continuò i suoi giuochi nella casa di pensione, ove accorrevano per ricrearsi eziandio parroci e canonici. Anzi, invitato, prestavasi nelle case dei signori e nelle abitazioni parrocchiali dei paesi circonvicini, ma sempre a puro titolo di amicizia. Era famoso specialmente nel fare andare gli oggetti in luoghi lontani o da luoghi lontani farli venire in mezzo all’assemblea. Per questa sua destrezza, gli amici al soprannome di sognatore gli aggiunsero quello di mago.
CAPO XL.
Le vacanze pasquali – Giovanni va a Pinerolo e di qui a Barge dal Prof. Banaudi – Viaggio verso Fenestrelle – Un temporale e ritorno a Pinerolo, poi a Chieri – Lettera al Sig. Strambio – Giovanni è invitato a dar consiglio sulla vocazione.
A CHIERI Giovanni si era pure stretto in amicizia col giovane Annibale Strambio di Pinerolo, suo compagno di scuola negli anni antecedenti. Ora, venute le vacanze pasquali, i parenti di quest’amico, i quali avevano conosciuto la illibatezza e la bontà di Giovanni, lo invitarono per qualche giorno in casa loro, e Giovanni di buon grado vi andò per respirare un po’ d’aria libera e passare alcuni istanti coll’amico.
Di questo viaggio Giovanni stesso ci ha lasciato la descrizione. È la prima e l’unica lettera che di lui, studente di ginnasio, possediamo e la prendiamo dalla brutta copia che sola ci rimane.
Dopo aver narrato del suo arrivo a Pinerolo, dell’accoglienza avuta dall’amico Annibale Strambio e dalla sua famiglia, presso cui fu ospitato, così continua a scrivere: “Il giorno seguente mi determinai ad andare a Barge, che è distante da Pinerolo otto miglia. Ascoltata la prima Messa, [350] presa colazione e incaricato di fare molti complimenti al nostro professor Banaudi, me ne partii il giorno 12 dello stesso mese, Domenica delle Palme, osservando, via facendo, molte belle valli e bei paesi, che quasi sembravano città, fra i quali annoverai Roseo, Bricherasio, S. Secondo, Bibiana, la quale ultima forma tre parrocchie. Ed eccomi giunto prosperamente a Barge.
Chiesto della casa del professore di retorica D. Banaudi, tosto mi fu indicata. Andai, ma mi venne detto che egli era in parrocchia. Recatomi alla chiesa lo vidi che cantava il Passio. Attentamente ascoltai la sua dilettevole voce, e dopo la funzione andai ad aspettarlo in piazza. Intanto stavo osservando quella gente tutta nuova per me, perchè erano quasi tutti pastorelli, ma di bell’aspetto e ben portanti della persona. Il professore fu il primo a vedermi, mi venne incontro, mi prese per la mano, mi baciò quasi lagrimando e tante cose voleva dirmi; ma non poteva profferir parola, vinto dalla contentezza che provava. Io ero egualmente commosso. Calmato quel primo sussulto del cuore, incominciammo con somma gioia a ragionare su varii argomenti e andammo intanto alla sua casa. Ivi fui ricevuto colla più grande cortesia e vi dimorai due giorni. Come io sia stato, non si può esprimere, soltanto dico che passai due giorni di paradiso. Dovunque andavamo a spasso o per qualche affare, tutti ci invitavano, alle loro case, e sè dicevamo di non voler andare, ci prendevano per mano e ci conducevano alle loro abitazioni con infiniti atti di cortesia. Fummo dal vicario e dal prefetto delle scuole, dal sindaco, dal vicesindaco e dall’albergatore Balbiano, parente di questo che è qui a Chieri. Fummo da tutti lautamente ricevuti.
Passati questi due giorni, deliberai di partire. Il mio professore voleva a tutti i costi ritenermi ancora, e mi nascose il [351] paracqua; ma vedendomi risoluto, si rassegnò, accompagnandomi per cinque miglia e mezzo. A questo punto della via messici a sedere sopra una ripa, discorremmo alquanto lietamente; ma allorchè accennai di volermi congedare, egli si mise a piangere e non parlava. Io volevo parlare e non poteva. Calmatici alquanto, dopo aver discorso di qualche cosa confidenziale, che doveva rimaner fra noi due soli, ci alzammo e ci dividemmo con una muta stretta di mano. Affrettando il passo, io giunsi a Pinerolo. Quivi ebbi nuovi complimenti e nuove domande intorno al viaggio ed al professore Banaudi.
In questi ragionamenti io ed Annibale stabilimmo di fare una passeggiata verso Fenestrelle. Per fare questo viaggio domandammo la carrozzella dell’illustre Alberto Nota, il più famoso scrittore di commedie ai nostri tempi. Egli ce la imprestò molto volentieri e ce la fece allestire e fornire di ogni cosa. Noi, poste sopra la carrozzella alcune provviste, salimmo e lentamente uscimmo da Pinerolo.
Il primo paese, che incontrammo, si chiama Porte, paese annidato fra le rupi, poi Floè, sempre sulla strada regia che costeggia il Chiusone. Questo fiume raddoppia le acque del Po. Dall’altro lato della via si innalzava un’alta catena di monti. Finalmente da lungi scoprimmo un’altissima montagna, che si chiama Malanagi o Malandaggio, la quale ci sembrava coperta di neve, ma non era; imperciocchè, fattici più da vicino, conoscemmo che era un monte di pietra bianca, alle falde del quale vi erano circa mille cinquecento uomini che lavoravano in quelle pietre.
Attaccate alla vetta, penzolavano, lunghissime corde fino al fondo, poichè le rupi sono così liscie e a picco, che neppure i gatti potrebbero arrampicarvisi. Gli operai si aggrappano a queste grosse funi e salgono fin dove si vuol fare una mina. Là giunti, piantano due ferri acuminati nella pietra viva, [352] perchè sostengano un asse, e su questi seduti fanno il loro foro per la mina e lo riempiono di polvere e lo muniscono di miccia che scende fino a terra. Preparata una mina, il suono della tromba avvisa tutti gli operai, perchè scendano e si allontanino e si dà fuoco. Sono enormi i massi che divelti precipitano nella valle. Le colonne tanto alte e tanto grosse, che sono a Torino alla Madonna del Pilone, furono staccate, da queste cave. Dieci botteghe da fabbro lavorano solamente a fare ed aggiustare pungoli, martelli e scalpelli. Stati alquanto ad ammirare quella meraviglia, seguitammo la nostra strada.
Dopo un miglio di viaggio sulla pietra viva, coperta di sabbia trasportata, trovammo un paese degno di speciale menzione. In questo paese hanno tutti il gozzo; i fanciulli ne hanno soltanto uno chi più grosso, chi più piccolo; e quelli più avanzati in età ne hanno chi tre e chi quattro, di maniera che per non soffrirne il peso li fasciano con fazzoletti e sembra veramente che portino sotto il collo un sacchetto pieno di pallottole. Costoro poi sono mezzi cristiani e mezzi barbetti, e perciò hanno due chiese; l’una pei cattolici, sulla quale campeggia la croce, l’altra pei valdesi senza croce. Sono tutti vestiti molto grossolanamente, bassi di statura, brutti in volto. Intorno a questo paese vi è una montagna, alta due miglia e mezzo, così ripida che nessuno vi si potrebbe arrampicare. È però tutta abitata, ed ecco in qual modo. Collo scalpello formano scalini nella pietra viva, e su questi pianerottoli innalzano i loro tugurii e dintorno vi portano terra dalla valle, e vi seminano patate, fagiuoli ed altre cose simili.
Preso adunque riposo in questo misero paese, procedemmo verso Fenestrelle. Eravamo già a quel gran monte, che si chiama Monviso, vedevamo già di fronte Fenestrelle, quando si levò un vento così furioso, che respingeva il cavallo, ci toglieva le forze di reggerlo e persino la parola. Turbinoso [353] si sollevava il polverio della strada, mescolato a pietruzze, che battendo nei nostri volti ci faceva molto male. Un buio spaventevole si stendeva su tutta la strada. Il cavallo urtava or qua or là, e sbuffando non voleva più andare avanti. Noi a tal vista sbigottiti fermammo il cavallo e lo rivoltammo indietro per ritornare a Pinerolo. Ma calando noi giù dal monte, ci assalse un nuovo timore. Quel vento precipitoso minacciava di rovesciare noi, il cavallo e la carrozzella giù per la china del monte fra le rupi e là in fondo farci perdere miseramente la vita. Ma la Provvidenza venne in nostro aiuto. Accanto alla strada scorgemmo un incavo nel monte, che ci offriva un sicuro rifugio. Quivi stentatamente menammo il cavallo, aspettando che passasse la bufera. Dopo circa un’ora e mezzo, il vento cessò, ma la notte sopraggiungeva. La luna però ci illuminava la via ed entrammo in Pinerolo verso le 11.
Stetti ancora due giorni a Pinerolo e sempre allegramente e mi determinai di venire a Chieri il giorno 16. Incaricato di diverse commissioni e di salutare il sig. Valimberti, il dì prefisso salii sulla diligenza, e giunto a Torino, di qui feci ritorno a Chieri. In questo viaggio impiegai sette giorni, che a me sembrarono sette ore, poichè tanto a Barge come a Pinerolo, quantunque indegno, fui trattato onorevolmente quanto mai dire si possa. Scusatemi, sono ancora un misero il quale” ecc. ecc.
E non fu questo il solo viaggio che fece a Pinerolo. Anticipiamo i fatti per non complicare i racconti. Annibale Strambio era un eccellente giovane ed aveva dimostrato desiderio di abbracciare la carriera ecclesiastica. Quindi l’anno seguente 1836 Giovanni scriveva al padre di lui:
“Avendo già più volte scritto al suo figlio Annibale amico mio prediletto, e non sapendo se abbia ricevuto lettera [354] o no, poichè non ebbi mai, risposta, giudicai bene scrivere a V. S. pregandola favorirmi nel fargli avere questa lettera.
Non so se Annibale studii la gita a Pinerolo o dove neppure so se sia chierico o secolare: disse però che sarebbe andato a prendere l’esame di vestizione chiericale e che avremmo parlato insieme in tal tempo; ma a cagion del coléra, che in allora minacciava le nostre contrade, non potei più parlare ad Annibale e non seppi più nulla se abbia preso l’esame di vestizione o no. Io studio il primo anno di filosofia nel seminario di Chieri. Bramo molto saper nuova di V. S. come pure di Madama Strambio, di cui non posso dimenticare la generosità usatami allora che andai a Pinerolo. Seppi che Domenico era ammalato e non so se siasi ristabilito bene. Desidero insomma di saper nuove di tutta la sua famiglia….”
La risposta fu che Annibale aveva indossato l’abito talare. Ma questa non era la via, per la quale lo voleva il Signore. Si trovava già innanzi nello studio della teologia, quando incominciò a venirgli dubbio sulla sua vocazione. Per un chierico di buona condotta e di delicata coscienza è oltremodo dolorosa questa incertezza; tanto più se non trova un consigliere di tale dottrina, esperienza e pietà, da giudicare senza esitanza sul partito da prendere. Peggio se avendolo trovato, non ha in lui intera confidenza ed abbandono. Aggiungi che il presentarsi a lui lo stato chiericale com’è il maggior bene assoluto, del quale si è fatto un abituale pensiero, mentre ora incomincia a ripugnargli il timore di far contro la volontà di Dio, vagheggiando altri ideali; il non sentire in sè il coraggio di retrocedere da quella via, dopo più anni di veste chiericale, la ripugnanza di palesare ai superiori le sue lotte interne, che potrebbero essere giudicate mosse da velleità irragionevoli; il riguardo ai parenti, per non disgustarli dopo tante spese e disegni sopra il suo avvenire assicurato; il rispetto umano [355] verso i compagni, per non comparire leggiero e volubile nelle sue deliberazioni; sono sentimenti che a volta a volta si affacciano alla sua mente, lo turbano e mantengono angosciosa la sua vita. Non sono molti coloro che Dio soggetta a simile prova; perchè i candidati al sacerdozio, prima di ascriversi al clero, hanno per la sapienza della Chiesa mezzi sicuri per aver certezza morale della loro vocazione. In generale la defezione di coloro, che furono promossi agli ultimi anni degli studii sacri, è dovuta ad irregolare condotta o a spensieratezza colpevole. Che l’amico di Giovanni non fosse di questi lo dimostrò la sua vita splendidamente cristiana sino all’ultimo de’ suoi giorni nelle cariche onorevoli da lui occupate: vita che egli sostenne colle teologiche discipline studiate in seminario. Egli adunque in questo tempo era divenuto pensieroso, preferiva trovarsi solo e per timidezza non si apriva con alcuno.
I suoi parenti, che erano eccellenti cristiani, essendosi nelle vacanze accorti del cambiamento, scrissero a Giovanni, perchè venisse a Pinerolo e s’intrattenesse col figlio sull’argomento che loro stava a cuore, cioè del suo avvenire. “Chi è amico, ama in ogni tempo; e il fratello (per amicizia) si sperimenta nelle afflizioni[87]”. Giovanni, lasciato ogni affare che aveva per le mani, e sottostando all’incomodo del viaggio, volò dall’amico, si fermò più giorni, parlò lungamente con lui, senza insistenze inopportune, come in simili casi era solito fare, quando non appariva evidente la volontà del Signore; e dalle risposte affermative, ma non risolute, potè conoscere che probabilmente non avrebbe continuata la carriera ecclesiastica. Lo incoraggiò quindi a lasciar da parte ogni melanconia, [356] gli suggerì le norme opportune per procedere con sicurezza nella risoluzione che avrebbe presa, e lasciollo consolato. Infatti, l’anno seguente, securo di sè, depose tranquillamente l’abito chiericale.
Annibale Strambio fu poi console a Marsiglia, conservò sempre una tenera affezione per D. Bosco, e nel tempo dei famosi decreti d’espulsione contro i religiosi, cooperò grandemente alla salvezza delle Case Salesiane di Francia.
CAPO XLI.
L’affetto dei professori – Maravigliosa mutazione nei giovani, ai quali Giovanni fa ripetizione – Testimonianze di sua virtù- Sobrietà nel vitto Festa della riconoscenza- Ancora dubbio sulla vocazione – L’esame d’ammissione come chierico nel seminario – Le vacane – Caritatevole gara tra D. Cafasso, D. Cinzano ed altri Castelnovesi nel provvedere a Giovanni il necessario per entrare in seminario.
NE’’ CAPITOLI precedenti si è visto quanto il nostro Giovanni fosse ben voluto da’ suoi professori di Chieri. Non menò portato per lui fu in quest’anno il dottor Sac. Giovanni Bosco, il quale, benchè non gli fosse legato con vincoli di parentela, era pur contento di avere un allievo che cotanto onorava il suo nome e cognome, coll’ottima condotta, colla pietà e diligenza nello studio. Ei nella sua lunga carriera mai si dimenticò di questo suo discepolo e più cose diceva in lode della sua condotta, del suo ingegno e della sua memoria, specialmente quando alcuni sacerdoti e professori dell’Oratorio, passando per Chieri, si recavano a visitarlo. Dal suo labbro udimmo a narrare il seguente aneddoto. Un bel mattino di primavera, in giorno di vacanza, andando a passeggiare pei colli, ad un certo punto gli parve di sentire una voce alta [358] e monotona, come di uno che recitasse qualche brano d’autore mandato a memoria, e nel tempo stesso il cadenzato ripetersi di certi colpi che gli sembravano di zappa maneggiata da braccia vigorose. Maravigliato, per un sentiero si avviò a quella volta, desideroso di conoscere chi fosse quel lavoratore, e vi trovò il giovane Bosco che zappava la vigna del Cumino, suo padrone di casa; mentre tenendo un libro aperto, sostenuto da un tralcio, studiava la lezione. A quella vista stupito il professor Bosco concepì maggior stima ed affetto pel suo allievo, che pure già amava teneramente.
Da varii indizi avuti in seguito, possiamo argomentare che fosse questo un lavoro ordinario di Giovanni per più ore nei giorni di vacanza: perchè sovente noi l’udimmo lodare i lavori manuali come mezzo per conservare la sanità e la moralità. Ed ecco ancora in lui, insiem collo studente, il contadino e l’operaio; giacchè si esercitava pure nel radere le barbe e tagliare i capelli, come egli stesso ci narrava, essendosi fatto ammaestrare in questa professione per risparmiare a se stesso la spesa del barbiere e poter rendere servigio agli amici.
Contuttociò egli nulla smetteva del suo ardore per gli studii, e continuava a dare ripetizioni a’ giovani chieresi. La signora Giuseppina Valimberti, vedova Radino, narrava a D. Bonetti nel 1889: “Mio fratello sacerdote parlava sempre in casa con ammirazione di un certo suo scolaro, di nome Giovanni Bosco. Benchè egli fosse professore, pure consegnò a questo, suo allievo un altro nostro fratello, perchè gli facesse ripetizione. Nostro fratello era l’ultimo nella classe di umanità, disattento e causa di fastidi alla famiglia; ma colla buona volontà e coll’istruzione, che il suo ripetitore seppe infondergli, cambiò interamente condotta. Divenne serio, studioso, attento, amante del suo dovere. Mio padre ne era consolatissimo, e [359] mia madre non faceva che ringraziare la divina Provvidenza di aver loro condotto in casa quell’aureo giovane. In quell’anno il fratello fu promosso alla retorica, prendendo lodevolmente gli esami. Anche il figlio del pretore, signor Plebano, fu migliorato dalla ripetizione che gli faceva Giovanni Bosco, e molte altre famiglie, informate di queste cose, lo desideravano nelle loro case a maestro dei loro fanciulli. Sovente egli era invitato a pranzo a casa Valimberti ed era quello per tutti un giorno di festa. Alla domenica era sempre nostro commensale. Agli ultimi tocchi della campana, tutti ci alzavamo e ci mettevamo in via per andare alla chiesa; ma Giovanni, invece di venir con noi, scompariva. Le prime volte una delle mie sorelle, la Giuseppina, sospettò che Giovanni fosse men buono di quello che si diceva, credendo che non si affrettasse ad andare alle sacre funzioni e forse ne stesse lontano; ma non tardò a disingannarsi. Giovanni aveva fatto un giro più lungo, per raccogliere i fanciulli dispersi qua e là per le vie, i quali per non andare al catechismo si ritiravano a giuocare e divertirsi nei luoghi più deserti. Noi, passando pel giardino di casa alla piazza del duomo, giungevamo a tempo per vedere Giovanni Bosco già attorniato da un bel numero di ragazzi, che egli guidava in chiesa. In famiglia lo stimavamo davvero un santo, pel suo contegno garbato, modesto, divoto, specialmente nel tempo delle preghiere. Sovente, alla sera, quando veniva a visitarci, guidava egli il rosario, ed era per noi scuola di buon esempio. Eravamo tre sorelle e non sempre obbedienti alla mamma e attente a far con diligenza i doveri di scuola e i lavori domestici: – Bene, diceva la mamma, bene: stasera lo dirò a Giovanni; farò vedere questo lavoro a lui e sentirai ciò che ti dirà! Per noi era tutto questa minaccia, e piccoline come eravamo, per questo timore facevamo il possibile per contentare la [360] mamma. Troppo ci premeva che Giovanni Bosco avesse di noi un concetto più mite e più favorevole. Eppure egli non trattava con noi, se non indirizzandoci qualche rara parola, quando non poteva farne a meno. Nostro padre, uomo di codice e di tribunale, ebbe a dire più volte in famiglia che egli non sapeva proprio che cosa desiderare di meglio nello studente Bosco. In lui ritrovava ogni virtù, studio, giudizio, a ingegno, religione ed amore sincero per il benessere della società”.
Qui è opportuno notare una virtù singolare di Giovanni, altrove appena accennata, che rapiva tutti di ammirazione: la sua mortificazione nel cibo, specialmente quando era invitato a mensa presso qualche signore di Chieri o presso qualche parroco. Il suo vitto ordinari o era sempre stato molto parco e talora insufficiente: pane, minestra e no sempre un po’ di frutta. Sembra naturale che, data l’occasione, secondando il bisogno e il gusto, un poveretto non riesca a stare entro certi limiti e quindi si mostri ingordo e privazione in smoderato. Nulla di questo in Giovanni. La privazione in lui era divenuta virtù volontaria. Gli occhi degli ospiti nulla trovavano nel suo contegno disinvolto, ma riservato, che fosse meritevole di critica. Pareva non si accorgesse se l’imbandigione fosse abbondante o scarsa. Non incominciava a prender cibo, se gli altri non gliene avessero dato l’esempio, e servivasi frugalmente di quanto gli era messo dinnanzi. Finiva il suo pasto prima degli altri. Pochissimo vino gli bastava e questo adacquato. Serbava un rispettoso silenzio: non interrompeva chi parlasse: se alcuno interrogavalo, colla sua amabilità e lepidezza era la gioia dei commensali. E tale sempre si mantenne dalla fanciullezza fino alla più tarda età! Pareva che avesse scolpito in cuore gli ammonimenti dell’Ecclesiastico: “Sei tu assiso a splendida mensa? Non [361] essere il primo a stendere la mano. Nel prendere le vivande, non urtare cogli altri. Vergógnati di mettere il gomito sul pane. Giudica del genio del tuo prossimo dal tuo. Sérviti da uomo frugale di quelle cose che ti sono messe davanti, affinchè non avvenga che, col molto mangiare, tu ti renda odioso. Sii il primo a finire per verecondia, e non essere smoderato per non disgustare veruno. E se siedi in mezzo a molti, non istendere la mano prima di quelli, e non essere il primo a chiedere da bere. Quanto poco vino è sufficiente ad un uomo bene educato! E in dormendo non ne sarai inquietato e non ne sentirai incomodo. Le vigilie, la colica, i dolori sono per l’uomo intemperante. Il sonno salubre è per l’uomo parco: egli dorme sino al mattino, e l’anima di lui sarà lieta con esso”[88].
Eravamo nel mese di giugno. La carità, la pazienza e le belle maniere, con cui il professore Giovanni Bosco trattava gli allievi, e la sua sollecitudine per farli progredire nello studio e nella pietà, gli avevano attirata la stima e l’affezione di tutta la scolaresca, la quale con impazienza aspettava il giorno suo onomastico per fare quanto la gratitudine poteva suggerire. Giovanni era alla testa di quella dimostrazione: egli aveva preparato un bel sonetto. Però anzi tutto, al mattino del giorno 24 giugno, con Luigi Comollo e con altri compagni andò a far la santa Comunione pel professore. La sua tenerezza riconoscente per quanti gli facevano del bene fu sempre uno dei caratteri più salienti della sua vita. Egli stesso ci ha lasciato memoria di questa festa, come pure di quella fattasi l’anno precedente in onore del professor Banaudi. Ed anche il professor Bosco non volle dal canto suo cederla in generosità, [362] e fissò egli pure pel giovedì seguente una passeggiata fina ai così detti Prati di Palermo, che distano tre chilometri da Chieri, con una munificentissima refezione per tutti gli allievi. Si lessero varie composizioni, cui rispose commossa il professore. Gli applausi e i battimani furono indicibili. Seguì poscia la merenda, in cui ciascuno mangiò e bevve a piacimento. Ognuno poi si diede a saltare, correre e cantare: insomma fu per tutti un’allegria da non potersi descrivere. Senonchè ad un certo punto della ricreazione si spande la voce che Comollo è scomparso. Si teme siagli accaduta qualche disgrazia, tanto più che ciascuno ricorda come l’anno precedente, nella medesima circostanza, era morto annegato un compagno nelle acque della fontana rossa a pochi passi distante di colà. Tutti pertanto rimangono pieni di spavento e si pongono a fare indagini tutt’all’intorno, ma inutilmente. In fine lo ritrovano in un sito, che niuno si pensava: era nascosta presso la vicina cappella, tra un cespuglio ed un pilastro, della medesima. Comollo, gli disse Giovanni, che fai tu qui? Tutti sono inquieti sulla tua sorte e ti cercano con ansietà. Vieni. – Egli volse uno sguardo, come chi è disturbato da una cara occupazione, e rispose: – Mi rincresce la vostra inquietudine, ma oggi io non aveva ancora recitato il S. Rosario e desiderava pagare questo tributo alla Beata Vergine. – Tranquillizzati così tutti i compagni, ringraziarono il professore e partirono ciascuno alla volta di Chieri. E qui noi, mentre ammiriamo la ingenua divozione di Comollo degna per certo di ogni lode, argomentando dalle parole del nostro Giovanni, notiamo come egli in simile caso avrebbe rimandato ad altro tempo quella preghiera, nè si sarebbe appartato dalla compagnia del professore e degli amici, per non sembrare scortese e recare loro dispiacere, imitando in, ciò quel caro S. Francesco di Sales, che più tardi prenderà [363] per protettore della pia sua Congregazione, il quale non, voleva essere schiavo delle divozioni supererogatorie.
Frattanto volgeva al suo termine anche quest’anno scolastico, ed il nostro Giovanni, per la lettura di qualche libro sulla vocazione, rimase così atterrito dai pericoli che si incontrano nel mondo, da ricadere nel dubbio sulla scelta o del seminario o del convento. Dopo molte riflessioni, pensò di nuovo di entrare in qualche altro convento dei Francescani, Ordine di tanti meriti, gloria e sostegno della Chiesa, persuaso che ciò non potrebbe impedire lo svolgimento dei destini, che Dio gli aveva fissati. Ma, come narra egli stesso nelle sue memorie, dovette mutare ancora divisamento: “In quel tempo succedette un caso, che mi pose nell’impossibilità di effettuare il mio progetto; e siccome gli ostacoli erano molti e duraturi, così io ho deliberato di esporre tutto all’amico Comollo. Egli mi diede per consiglio di fare una novena a Maria SS. per ottenere lume in affare di tanta importanza, e nel frattempo egli avrebbe scritto al suo zio prevosto.. L’ultimo giorno della novena, in compagnia dell’incomparabile amico feci la Confessione e la Comunione; di poi udii una Messa e ne servii un’altra in duomo all’altare della Madonna delle Grazie. Andati poscia a casa, trovammo di fatto una lettera di D. Comollo, concepita in questi termini: – Considerate attentamente le cose esposte, io consiglierei il tuo compagno di soprasedere dall’entrare in un convento. Vesta egli l’abito chiericale, e mentre farà i suoi studi, conoscerà vie meglio quello che Dio vuole da lui. Non abbia alcun timore di perdere la vocazione, perciocchè colla ritiratezza e colle pratiche di pietà egli supererà tutti gli ostacoli.
Egli aveva eziandio manifestata la presa deliberazione a D. Cafasso ed al suo parroco teologo Cinzano, i quali pure furono d’avviso che entrasse in seminario, aspettando a [364] decidersi per un Ordine religioso in età più matura. Giovanni esperimentò quanto giovi, nell’affare della vocazione, prendere consiglio da persone dotte e pie ed obbedì, come narra egli stesso: “Ho seguito quel savio suggerimento, mi sono seriamente applicato in cose che potessero giovare a prepararmi alla vestizione chiericale. Subito l’esame di retorica, sostenni quello dell’abito di chierico in Chieri e precisamente nelle camere attuali della casa di Carlo Bertinetti, che morendo ci lasciò in eredità e che erano tenute a pigione dall’arciprete canonico Burzio. In quell’anno l’esame non ebbe luogo, secondo, il solito, in Torino a motivo del colèra – morbus, che minacciava i nostri paesi. Tuttavia la capitale ne andò immune e con un triduo solennissimo in onore del nuovo Beato Sebastiano Valfrè, celebrato nella chiesa di S. Eusebio, coll’intervento della famiglia reale e dell’università, se ne rendevano grazie al Signore, supplicandolo per l’avvenire.
E qui voglio notare una cosa che fa certamente conoscere quanto lo spirito di pietà fosse coltivato nel collegio di Chieri. Nello spazio di quattro anni, che frequentai quelle scuole, non mi ricordo di avere udito un discorso od una sola parola, che fosse contro ai buoni costumi o contro alla religione. Compiuto il corso di retorica, di 25 allievi, di cui componevasi quella scolaresca, abbracciarono lo stato ecclesiastico; tre medici: uno mercante”.
Preso adunque l’esame di vestizione chiericale, che gli riuscì ottimamente, Giovanni andò a congedarsi dai superiori, del collegio. Il dottore Teol. Bosco ed altri cospicui personaggi ci narravano essere stata cosa meravigliosa il vedere, come Giovanni avesse saputo guadagnarsi non solo i cuori dei compagni, ma eziandio quelli del prefetto degli studi, del direttore spirituale e di tutti i suoi professori: i quali ultimi gli conservarono il più grande affetto, in modo da desiderarlo [365] sempre come amico e confidente. Il suo professore di retorica, dottore di belle lettere e aggregato, appena terminato il corso, volle che Giovanni lo tenesse come amico e gli desse del tu. Ciò basti per dimostrare in quale stima fosse tenuto il povero contadino de’ Becchi. E di questa fu causa non solo la sua virtù, ma una specie di contrasto che spiccava in tutte le sue azioni e lo rendeva ancor più amabile. Affermo quanto già dissi, perchè il lettore non formi erroneo giudizio. Egli, di un’attività continua e intraprendente, era lento e posato nell’operare: di una ricchezza meravigliosa di idee e di grande facilità nel comunicarle a tempo opportuno, era parco di parole, specialmente con quelli che erano a lui superiori. Tale l’abbiamo conosciuto per tanti anni e tale fu da giovane. Le mille volte osservandolo o ascoltando i suoi coetanei a parlare di lui, ricordavamo le parole dell’Ecclesiastico, come se queste recassero il suo vivo ritratto: “Giovanetto, parla al bisogno a mala pena. Interrogato due volte, restringi in poco la tua risposta. In molte cose dipórtati come ignorante e ascolta tacendo e domandando. In mezzo ai grandi non ti azzardare: e dove sono vecchi non parlare molto. Il tuono è preceduto dal lampo, e la verecondia è preceduta dalla buona grazia e la tua ritenutezza farà che tu sii benveduto”[89].
Ritornato al suo paese, udiamo da lui stesso qual fosse il suo tenore di vita. “Andato a casa per le vacanze, cessai di fare il ciarlatano e mi diedi alle buone letture, che debbo, dirlo, a mia vergogna, fino allora avea trascurate. Ho però continuato ad occuparmi dei giovanetti, trattenendoli in racconti, in piacevoli ricreazioni, in canti di laudi sacre; anzi, [366] osservando che molti erano già inoltrati negli anni, ma assai ignoranti nelle verità della fede, mi sono dato premura di insegnare loro anche le preghiere quotidiane, il modo di prepararsi a ricevere i Santi Sacramenti ed altre cose più importanti per quella età. Fra quello una specie di Oratorio cui intervenivano circa cinquanta fanciulli, che mi amavano e mi obbedivano come se fossi stato loro padre”.
E doveva essergli ben caro questo piccolo campo evangelico; poichè da ben quattro e più anni egli nei mesi di settembre e di ottobre lo coltivava collo zelo di un apostolo. Egli si umilia dicendo che fin allora aveva trascurato le buone letture, vale a dire la lettura de’ libri ascetici. Ma chi potrà crederlo? Certamente che in mezzo alle sue svariate occupazioni non poteva farne oggetto di diuturna meditazione, come nei tempi che solo occupavasi della pastorizia; ma è egli mai possibile che un giovane, nelle condizioni del nostro Giovanni, manifestasse in sè tanta abbondanza di vita spirituale, da trasfonderla continuamente negli altri, se avesse veramente trascurato questo nutrimento dell’anima?
Intanto, avvicinandosi il tempo della vestizione chiericale, Giovanni, mancando di mezzi materiali, si vedeva innanzi gravi difficoltà per entrare in seminario. Ciò eragli pure necessario per andar esente dalla leva militare, essendo egli ora entrato negli anni ventuno. Ma D. Cafasso, che fu poi sempre il suo benefattore, amico e consigliere, abboccatosi con D. Cinzano, stabilì con lui il da farsi, per ottenere a Giovanni l’ingresso in seminario, senza grave spesa di pensione; al qual intento fu deciso di ricorrere alla generosità del teologo Luigi Guala, direttore e fondatore del Convitto Ecclesiastico di S. Francesco d’Assisi in Torino, il quale aveva eziandio una grande influenza sull’animo dell’Arcivescovo Fransoni. E un bel mattino il Teol. Cinzano, chiamato a sè Giovanni, senza comunicargli [367] il suo pensiero, lo condusse a Rivalba dal sullodato Teol. Guala, che quivi villeggiava in una sua possessione di trecento giornate. Ricchissimo signore, era di una carità incomparabile nel soccorrere ogni sorta di persone, che avessero bisogno di aiuto. Ed il Teol. Cinzano, fattogli esaminare il giovane, tanto disse, che gli venne promesso di farlo entrare per quell’anno gratuitamente in seminario. Ed ecco vinto il punto più difficile. Restava a provvederlo degli abiti chiericali, che la sua povera madre non avrebbe potuto comprargli. D. Cinzano ne parlò ad alcuni suoi parrocchiani, che accettarono premurosamente di concorrere a questa opera buona. Il Sig. Sartoris lo provvide della veste talare, il Cav. Pescarmona del cappello, il vicario gli diede il suo proprio mantello, altri gli comprò il colletto e la berretta, altri le calze, e una buona donna raccolse i denari necessarii per fornirlo, credo, di un paio di scarpe. Questa è la maniera che la divina Provvidenza terrà poi in seguito col nostro Giovanni, servendosi cioè dell’aiuto di molti per sostenere il suo fedel servo e le opere tutte, cui egli darà mano. E noi udimmo D. Bosco più d’una volta ripetere: – Io ebbi sempre bisogno di tutti!
- Cinzano adunque, vicario foraneo di Castelnuovo, il quale fu vero padre di tutti quei giovani che vestirono poi l’abito chiericale, fra i quali va notato Mons. G. B. Bertagna, lo fu in modo speciale per Giovanni Bosco suo primo chierico. Per lui ebbe sempre, con affezione paterna ed intuizione di ciò che sarebbe un giorno divenuto, una cura tutta particolare. Parlando di lui spesse volte gli uscivano dalle labbra queste profetiche parole: – Vedrete, vedrete: questo giovane riuscirà qualche cosa di grande. Io morirò, non potrò vedere la sua riuscita, ma voi vedrete che farà parlare di sè tutto il mondo. – Così ci raccontava D. Febbraro di Castelnuovo, priore [368] di S. Giovanni Battista in Orbassano e compagno di D. Bosco nell’ultimo anno di seminario.
Giovanni era adunque omai sicuro della riuscita della sua vocazione e poteva, ringraziando Iddio, esclamare: “La sorte è caduta per me sopra le cose migliori; e certamente la mia eredità è preziosa per me”[90].
CAPO XLII.
Vestizione cbiericale – Una festa poco gradita – Regolamento di vita – Entrata nel seminario di Chieri.
DELIBERATO di entrare in seminario, Giovanni Bosco andava preparandosi a quel giorno di massima importanza, nel quale avrebbe indossato l’abito sacro. Egli era ben persuaso che dalla scelta dello stato ordinariamente dipende l’eterna salvezza o l’eterna perdizione; laonde raccomandò a varii amici di pregare per lui, premise una novena con particolari esercizii di pietà, ed il giorno 25 ottobre si accostò ai SS. Sacramenti; di poi il teologo Michele Antonio Cinzano, prevosto e vicario foraneo di Castelnuovo d’Asti, prima della Messa solenne, gli benedisse l’abito e lo vestì da chierico.
In chiesa (come narrò a D. Secondo Marchisio il Cav. Prof. A. Francesco Bertagna di Castelnuovo d’Asti) eravi un numero straordinario di giovani, venuti eziandio da borgate e paesi circonvicini, e tutti ammiravano la compostezza, la grande divozione e l’umiltà di Giovanni nell’atto della vestizione. E qui crediamo far cosa ottima nel cedere la penna a D. Bosco stesso, il quale ci descrive pure i sentimenti che provò in quel solenne momento ed in tutto quel primo giorno della sua vita chiericale. [370] “Quando il prevosto mi comandò di levarmi gli abiti secolareschi con quelle parole: Exuat te Dominus veterem bominem cum actibus suis, dissi in cuor mio: – Oh quanta roba vecchia c’è da togliere. Mio Dio, distruggete in me tutte le mie cattive abitudini. – Quando poi nel darmi il collare aggiunse: Induat te Dominus novum bominem, qui secundum Deum creatus est in justitia et sanctitate veritatis! mi sentii tutto commosso e aggiunsi tra me: – Sì, o mio Dio, fate che in questo momento io vesta un uomo nuovo, cioè che da questo momento io incominci una vita nuova, tutta secondo i divini voleri, e che la giustizia e la santità siano l’oggetto costante dei miei pensieri, delle mie parole e delle mie opere. Così sia. O Maria, siate la salvezza mia.
Compiuta la funzione di chiesa, il mio prevosto volle farne un’altra tutta profana, volle cioè condurmi alla festa di S. Raffaele Arcangelo, che si celebrava a Bardella, borgata di Castelnuovo. Egli con quel festino intendeva usarmi un atto di benevolenza, ma non era cosa opportuna per me. Quale figura avrei fatto io? Quella d’un burattino vestito di nuovo, che si presenta al pubblico per essere veduto. Inoltre, dopo più settimane di preparazione a quella sospirata giornata, trovarmi poi ad un pranzo in mezzo a gente di ogni condizione, di ogni sesso, colà radunata per ridere, chiacchierare, mangiare, bere, divertirsi, gente che per lo più va in cerca di giuochi, balli e partite di tutti i generi, era proprio un controsenso: io mi sarei trovato fuori di posto: quale società poteva mai formare quella gente, con uno che il mattino dello stesso giorno aveva vestito l’abito di santità per darsi tutto al Signore? Perciò rispettosamente gli risposi:
– Ma a Bardella si fa la festa del paese!
– È per questo che io sono invitato; vieni, vieni anche tu. [371]”
– Oh! io non sono capace a diportarmi onorevolmente in queste feste; se permette, me ne sto qui in canonica a pranzo.
– Ma qui in casa non si accende neppure il fuoco; siamo invitati tutti là.
– Ed io me ne andrò a casa mia a pranzate con i miei parenti.
– Sei troppo lontano per andare a casa tua, e poi i tuoi parenti non ti attendono. Vieni senz’altro; ti conduco, perchè c’ è anche da servire alla benedizione e c’ è sempre da fare qualche cosa in segrestia e in chiesa.
Andai per non dare dispiacere al parroco, che mi portava tanto affetto, ma a malincuore, perchè sapevo che nei tumulti e nei grandi pranzi vi è sempre pericolo dell’offesa di Dio. Assistei a tutte le funzioni nella cappella, fui al pranzo: vidi tutto quello che si costuma fare in queste feste; ma per me quello fu un giorno di malinconia.
Il mio prevosto se ne accorse, e nel ritornare a casa mi chiese perchè in quel giorno di pubblica allegria io mi fossi mostrato cotanto ritenuto e pensieroso. Con tutta sincerità risposi che la funzione fatta al mattino in chiesa discordava in genere, numero e caso con quella della sera, e soggiunsi: Anzi l’aver veduto coloro, che meno avrei creduto, fare i buffoni in mezzo ai convitati, pressochè brilli di vino, mi ha quasi fatto venire in avversione la mia vocazione. Se mai sapessi di venire un prete come quelli, amerei meglio deporre quest’abito e vivere da povero secolare, ma da buon cristiano, ovvero ritirarmi dal mondo e farmi Certosino o Trappista.
– Il mondo è fatto così, mi rispose il prevosto, e bisogna prenderlo com’è. Bisogna veder il male per conoscerlo ed evitarlo. Niuno divenne valente guerriero, senza conoscere il maneggio delle armi. Così dobbiamo fare noi, [372] che abbiamo un continuo combattimento contro al nemico delle anime. Tacqui allora, ma nel mio cuore ho detto: Non andrò mai più in pubblici festini, fuori che sia obbligato per funzioni religiose.
Dopo quella giornata io doveva occuparmi di me stesso. La vita fino allora tenuta doveva essere radicalmente riformata. Negli anni addietro non era stato uno scellerato, ma dissipato, vanaglorioso, occupato in partite, giuochi, salti, trastulli ed altre cose simili, che rallegravano momentaneamente, ma che non appagavano il cuore. Per farmi un tenore di vita da non dimenticarsi ho scritto le seguenti risoluzioni:
l° Per l’avvenire non prenderò mai più parte ai pubblici spettacoli sulle fiere, sui mercati: nè andrò a vedere balli o teatri: e per quanto mi sarà possibile, non interverrò ai pranzi, che si sogliono dare in tali occasioni.
2° Non farò mai più i giuochi dei bussolotti, di prestigiatore, di saltimbanco, di destrezza, di corda: non suonerò, più il violino, non andrò più alla caccia. Queste cose le reputo tutte contrarie alla gravità ed allo spirito ecclesiastica.
3° Amerò e praticherò la ritiratezza, la temperanza nel mangiare e nel bere: e di riposo non prenderò se non le ore strettamente necessarie alla sanità.
4° Siccome nel passato ho servito al mondo con letture profane, così per l’avvenire procurerò di servire a Dio dandomi alle letture di cose religiose.
5° Combatterò con tutte le mie forze ogni cosa, ogni lettura, pensiero, parole ed opere contrarie alla virtù della castità. All’opposto praticherò tutte quelle cose, anche piccolissime, che possono contribuire a conservare questa virtù.
6° Oltre alle pratiche ordinarie di pietà, non ometterò mai di fare ogni giorno un poco, di meditazione ed un poca di lettura spirituale. [373]” 7° Ogni giorno racconterò qualche esempio o qualche massima vantaggiosa alle anime altrui. Ciò farò coi compagni, cogli amici, coi parenti, e, quando nol posso con altri, il farò con mia madre.
Queste sono le cose deliberate allorchè ho vestito l’abito chiericale; ed affinchè mi rimanessero bene impresse, sono andato avanti ad un’immagine della Beata Vergine, le ho lette, e, dopo una preghiera, ho fatto formale promessa a quella Celeste Benefattrice di osservarle a costo di qualunque sacrifizio.
Il giorno 30 ottobre di quell’anno 1835 doveva trovarmi in seminario. Il piccolo corredo era preparato. I miei parenti eran tutti contenti: io più di loro. Mia madre soltanto stava in pensiero e mi teneva tuttora lo sguardo addosso come volesse dirmi qualche cosa. La sera precedente la partenza ella mi chiamò a sè e mi fece questo memorando discorso: Giovanni mio, tu hai vestito l’abito ecclesiastico; io ne provo tutta la consolazione che una madre può provare per la fortuna di suo figlio. Ma ricordati che non è l’abito che onora il tuo stato, è la pratica della virtù. Se mai tu venissi a dubitare di tua vocazione, ah per carità! non disonorare quest’abito. Deponilo tosto. Amo meglio di avere per figlio un povero contadino, che un prete trascurato ne’ suoi doveri. Quando sei venuto al mondo, ti ho consecrato alla Beata Vergine: quando hai cominciato i tuoi studi ti ho raccomandato la divozione a questa nostra Madre: ora ti raccomando di essere tutto suo: ama i compagni divoti di Maria; e se diverrai sacerdote, raccomanda e propaga mai sempre la divozione di Maria. – Nel terminare queste parole mia madre era commossa: io piangeva: – Madre, le risposi, vi ringrazio di tutto quello che avete detto e fatto per me; queste vostre parole non saranno dette invano e ne farò tesoro in tutta la mia vita. [374]” Al mattino per tempo mi recai a Chieri, e la sera dello stesso giorno entrai in seminario, stabilito nell’ampio convento dei Padri Filippini, soppresso dal governo francese ed acquistato per radunarvi i chierici nel 1828 da Mons. Chiaverotti. Rettore del seminario era il Teol. Sebastiano Mottura, Can. Arciprete della Collegiata di Chieri: direttore spirituale D. Giuseppe Mottura, poi canonico dell’insigne Collegiata di Giaveno. Salutati i superiori e aggiustatomi il letto, con l’amico Garigliano, che aveva pur esso vestito l’abito chiericale, mi sono messo a passeggiare pei dormitori, pei corridoi e in fine pel cortile. Alzando lo sguardo sopra una meridiana, lessi questo verso: Affictis lentae, celeres gaudentibus hora. Ecco, dissi all’amico, ecco il nostro programma: stiamo sempre allegri e passerà presto il tempo.
Il giorno dopo incominciò un triduo di esercizi, ed ho procurato di farli bene per quanto mi fu possibile. Sul finire di quelli mi recai dal professore di filosofia, che allora era il Teol. Ternavasio di Bra, e gli chiesi qualche norma di vita per riuscire un buon chierico ed acquistarmi la benevolenza de’ miei superiori. Una cosa sola, rispose il degno sacerdote: coll’esatto adempimento dei vostri doveri.
Ho preso per base questo consiglio e mi diedi con tutto l’animo all’osservanza delle regole del seminario. Non faceva distinzione tra quando il campanello chiamava allo studio, in chiesa, oppure in refettorio, in ricreazione, al riposo. Questa esattezza mi guadagnò l’attenzione dei compagni e la stima dei superiori, a segno che sei anni di seminario furono per me una piacevolissima dimora. Tanto più che gli studi vi erano ben coltivati.
Oltre a ciò, affezionavami a quel luogo il nome di D. Cafasso. Il buon odore delle sue virtù rimaneva ancora in quel sacro recinto. La carità verso i compagni, la sommessione [375] ai superiori, la pazienza nel sopportare i difetti degli altri, la cautela di non mai offendere alcuno, la piacevolezza nell’accondiscendere, consigliare, favorire i suoi compagni, l’indifferenza negli appressamenti di tavola, la rassegnazione nelle vicende delle stagioni, la prontezza nel fare il catechismo ai ragazzi, il contegno ovunque edificante, la sollecitudine nello studio e nelle cose di pietà sono le doti, ‘che adornarono la vita chiericale di Cafasso; doti che, praticate in grado eroico, fecero diventare famigliare ai suoi compagni ed amici il dire che il chierico Cafasso non fosse stato affetto dal peccato originale”. Il chierico Giovanni Bosco volle prendere per modello questo suo compatriota. La virtù straordinaria di Cafasso fu quella di praticare costantemente e con fedeltà meravigliosa le virtù ordinarie. Questo fu pure il proposito preso da Giovanni Bosco nell’entrare in seminario, proposito ch’egli poi sempre mantenne in tutto il corso di sua vita.
CAPO XLIII.
La vita del seminario – I compagni – La frequenza dei SS. Sacramenti Tempo bene impiegato – Un altro sogno – Ricreazioni.
IL SEMINARIO è tempio di Dio, nel quale il giovane levita, ode più chiaramente la voce del Signore, che lo chiama al servizio degli altari: è l’atrio santo, ov’egli si accende alla più tenera devozione ed allo zelo più ardente per la salute delle anime e stringe quei forti vincoli di carità, che unir debbono tutti i membri della chiesa fra di loro: è il campo di esercitazione, ove colla virtù e colla scienza, fortifica la volontà e la mente per vincere le battaglie del Signore: è il giardino di Dio, dove sono raccolti i fiori più eletti delle diocesi, che un giorno trapiantati spanderanno il profumo della santità in mezzo alle popolazioni. In questo sacro recinto adunque entrava il chierico Giovanni Bosco, con animo volonteroso per conseguire tutte quelle grazie, che il Signore quivi apprestavagli.
Ed ecco come egli descrive questo nuovo periodo di sua vita: “Io amava molto i miei superiori, ed essi mi hanno sempre usato molta bontà; ma il mio cuore non era soddisfatto, perchè essi difficilmente si rendevano accessibili ai chierici. Il rettore e gli altri superiori solevano visitarsi all’arrivo dalle vacanze e quando si partiva per le medesime. Niuno andava [377] a parlare con loro, se non nei casi di ricevere qualche strillata. Uno dei superiori veniva per turno a prestare assistenza ogni settimana in refettorio e nelle passeggiate, e poi tutto era finito. Fu questa l’unica pena che ebbi a provare in seminario. Quante volte avrei voluto parlare e chiedere loro consiglio o scioglimento di dubbi e non poteva: anzi accadendo che qualche superiore passasse in mezzo ai seminaristi, senza saperne la cagione ognuno fuggiva precipitoso a destra ed a sinistra, come da una bestia nera. Ciò accendeva sempre più il mio cuore del desiderio di essere presto prete per trattenermi in mezzo ai giovanetti, per assisterli, venire a conoscerli bene, sorvegliargli sempre, metterli nell’impossibilità di fare il male ed appagarli ad ogni occorrenza.
In quanto ai compagni, mi sono tenuto al suggerimento dell’amata mia genitrice, vale a dire associarmi ai compagni divoti di Maria, amanti dello studio e della pietà. Debbo dire per regola di chi frequenta il seminario, che in esso vi sono molti chierici di specchiata virtù, ma ve ne sono anche dei pericolosi. Non pochi giovani, non badando alla loro vocazione, vanno in seminario senza avere nè spirito, nè volontà di buon seminarista. Anzi io mi ricordo d’aver udito cattivissimi discorsi dai compagni. Ed una volta, fatta perquisizione ad alcuni allievi, furono trovati libri empii ed osceni di ogni genere. È vero che simili compagni o deponevano volontariamente l’abito chiericale, oppure venivano cacciati dal seminario, appena scoperti per quello che erano; ma, mentre dimoravano in seminario, erano peste pei buoni e pei cattivi. Per evitare il pericolo di tali condiscepoli, io mi scelsi alcuni, che erano notoriamente conosciuti per modelli di virtù, e fra questi Guglielmo Garigliano.
Le pratiche di pietà si adempivano assai bene. Ogni mattino Messa, meditazione la terza parte dei Rosario; a [378] mensa lettura edificante. In quel tempo leggevasi la storia ecclesiastica del Bercastel. La Confessione era obbligatoria ogni quindici giorni, ma chi voleva, poteva anche accostarsi tutti i sabati. La Santa Comunione però potevasi soltanto fare la domenica od in altra speciale solennità. Qualche volta si faceva lungo la settimana, ma per ciò fare bisognava commettere una disubbidienza. Era d’uopo scegliere l’ora di colazione, andare di soppiatto all’attigua chiesa di S. Filippo, che aveva comunicazione interna col seminario, fare la Comunione, e poi venire a raggiungere i compagni al momento che tornavano allo studio e alla scuola. Questa infrazione di regolamento era proibita; ma i superiori ne davano tacito consenso, perchè lo sapevano, e talvolta vedevano e non dicevano niente in contrario. Con questo mezzo ho potuto frequentare assai più la Santa Comunione, che posso chiamare con ragione il più efficace alimento della mia vocazione. A questo difetto, di pietà si provvide quando, per disposizione dell’Arcivescovo Gastaldi, furono ordinate le cose in modo da poter ogni mattina accostarsi alla S. Comunione, purchè uno siane preparato”.
Per chi ama veramente N. S. Gesù Cristo è questa per certo una dolorosa privazione. Gesù è la sua consolazione, il suo conforto, il sostegno, la vita della sua vita; senza di lui gli par di venir meno. Egli è il centro de’ suoi desideri, e, però ardentemente brama di riceverlo con frequenza, e ne ha pena grande, ogni volta non gli è dato d’unirsi al diletto del suo cuore. Così avveniva al chierico Giovanni Bosco:, gli pareva proprio di non poter vivere senza comunicarsi. E però egli, con altri suoi compagni, più volte alla settimana, volentieri faceva sacrificio della ricreazione e della collezione, rimanendo digiuno in un’età, nella quale sentesi così vivo, il bisogno di nutrimento, pur di potersi cibare delle carni [379] immacolate di Gesù Sacramentato. Il confessore suo per tutto il tempo che visse in seminario fu il Can. Maloria, il quale già lo era stato eziandio prima durante i quattro anni di ginnasio.
Giovanni si era pur fatta una legge di non perdere briciolo di tempo, e per le materie filosofiche non si contentava delle ore di scuola e di studio.
“Le ricreazioni, così scrive egli, nei giorni di scuola erano molto limitate: per la colazione senza caffè o altro companatico non si concedeva che mezz’ora. Ad un’ora e mezzo dopo il pranzo, che imbandivasi a mezzo giorno, si andava a studio. Mezz’ora di divertimento dopo la scuola della sera. Di sanità tutti i chierici stavano abbastanza bene. Quando la ricreazione era più lunga dell’ordinario, veniva rallegrata da qualche passeggiata, che i seminaristi facevano spesso nei luoghi amenissimi, che circondano la città di Chieri. Quelle passeggiate tornavano anche utili allo studio; perciocchè ciascuno procurava di esercitarsi in cose scolastiche, interrogando il suo compagno o rispondendo alle fatte dimande. Fuori del tempo di pubblica passeggiata, ognuno si poteva anche ricreare passeggiando cogli amici pel seminario, discorrendo di cose amene, edificanti e scientifiche. Nelle lunghe ricreazioni spesso ci raccoglievamo in refettorio per fare il così detto circolo scolastico. Ciascuno colà faceva quesiti intorno a cose che non sapesse, o che non avesse ben intese nei trattati o nella scuola. Ciò piacevami assai e mi tornava molto utile allo studio, alla pietà ed alla sanità. Per la mia età e più per la benevolenza de’ compagni, io era in questo circolo presidente e giudice inappellabile. Siccome nei nostri famigliari discorsi mettevansi in campo certe quistioni, certi punti scientifici, cui talvolta niuno di noi sapeva dare esatta risposta, così ci dividevamo le difficoltà. Ciascuno entro un tempo determinato [380] doveva preparare la risoluzione di quanto era stato incaricato”.
Ma ciò non bastava alla smania che Giovanni aveva di acquistare sempre nuove cognizioni. Al mattino egli era sempre il primo a balzar in piedi, affrettandosi a vestirsi, lavarsi, assestare il letto e ordinare le cose sue, secondo il regolamento; quindi si ritirava nel vano di una finestra e attendeva alla lettura di qualche libro per circa un quarto d’ora, finchè la campana non lo chiamasse alla cappella. Per quanto fosse opera voluminosa quella che aveva tra mano, non la metteva da parte e non prendeva altro libro, finchè non l’avesse letta interamente. In ciò poneva la massima attenzione, non leggendo per solo diletto o curiosità, ma per imparare e ritenere. Le stesse prefazioni erano da lui meditate, perchè reputava necessario conoscere il disegno dell’autore e i motivi che lo avevano indotto a scrivere; e incominciava sempre col dare uno sguardo all’indice per avere una sintesi del libro. Alla lettura di buone e sode opere consecrava eziandio ogni altro ritaglio di tempo, i minuti di aspettazione prima dell’entrata del maestro nella scuola, l’ultimo quarto d’ora delle ricreazioni ordinarie, tutto il tempo delle ricreazioni straordinarie, quando non tenevasi circolo, una parte della mezz’ora destinata per la preparazione al passeggio e all’andata al duomo per le sacre funzioni: in tali circostanze egli era spiccio nel mettersi all’ordine, e considerava come sciupato quel tempo che alcuni impiegavano nell’attillarsi; tuttavia nelle sue vestimenta nulla si vedeva che non fosse tenuto con grande proprietà. Con tale industria ei si faceva a poco a poco padrone di varie opere. In questo primo anno lesse tutte quelle del Cesari, del Bartoli e d’altri, ancora. E tale diligenza nell’impiego del tempo la usò poi sempre ne’ sei anni intieri che stette in [381] seminario, accumulando così col suo ingegno e colla sua memoria tesori di sapienza.
La sua temperanza nell’uso dei cibi e delle bevande era qualche cosa di sorprendente, ispirata da due grandi virtù: dall’amore alla mortificazione e dall’amore allo studio per rendersi atto all’opera divina della salute delle anime. Egli voleva che, venti minuti dopo aver, pranzato, la digestione non gli impedisse di riprendere le sue occupazioni. Quindi, è che mai si lagnava degli apprestamenti di tavola e manifestava gran dispiacere quando udiva a mormorare sulla qualità delle vivande, o veniva a sapere che taluno cercava di provvedersi dalla cucina o dalla dispensa del seminario, senza il permesso dei superiori: in questi casi egli ed i suoi intimi amici si adoperavano risolutamente ad impedire simili mancanze coll’esempio e colla disapprovazione. Se qualche volta sua madre o alcuno degli amici gli portavano in regalo qualche commestibile, non sapeagli buono mangiarselo da solo; chiedevane perciò la debita licenza e facevane parte ai compagni. Di queste cose hanno fatto fede D. Palazzolo e D. Giacomelli.
In mezzo all’esercizio delle virtù più sode ed agli studii serii della filosofia, Giovanni Bosco sentiasi sempre più crescere in cuore una brama ardentissima di giovare ai fanciulli, che continuava a radunare intorno a sè pel catechismo e per le orazioni, quando i superiori lo mandavano a questo fine nel duomo. E la divina bontà, che teneva sopra di lui i suoi occhi amorosi, prese a fargli conoscere in modo più, particolare qual fosse il genere di missione che gli riserbava in mezzo ai giovanetti. D. Bosco lo raccontò nell’Oratorio ad alcuni in privato, tra i quali era presente D. Giovanni, Turchi e D. Domenico Ruffino. – Chi può immaginare, disse, il modo, nel quale, io mi vidi quando faceva il primo. [382] corso di filosofia! – Venne interrogato: – Dove si vide? In un sogno o in altro luogo? – Questo non importa saperlo. Io mi vidi già prete, con rocchetto e stola: e così vestito lavorava in una bottega da sarto, ma non cuciva cose nuove, bensì rappezzava robe logore e metteva insieme un gran numero di pezzi di panno. Subito non potei intendere che cosa ciò significasse. Di questo ne feci motto allora con qualcheduno; ma non ne parlai chiaramente finchè fui prete, e solo col mio consigliere D. Cafasso. Questo sogno o visione rimase indelebile nella memoria di D. Bosco. Esso indicava come egli non fosse solo chiamato a fare scelta di giovani santi e ad adoperarsi a perfezionarli e custodirli, sibbene a radunare intorno a sè giovanetti fuorviati e guasti dai pericoli del mondo, i quali per le sue cure si rifacessero buoni cristiani e cooperassero alla riforma della società.
Frattanto i giorni del nostro Giovanni continuavano a scorrere tranquilli e rallegrati da quella gioia vera di chi, vivendo sotto obbedienza, osserva con esattezza i proprii doveri. Chi fu buon seminarista ricorderà sempre con soddisfazione quanto fece, vide, passò negli anni de’ suoi studi chiericali. È perciò che il nostro Giovanni lasciò memoria perfino delle ricreazioni, che godette tra quelle mura di pietà e pace. “Il trastullo più comune in tempo libero era il noto giuoco della bara rotta. In principio vi presi parte con molto gusto, ma siccome questo giuoco s’avvicinava assai a quello dei ciarlatani, cui avevo rinunziato, così pure ho voluto da quello cessare.. In certi giorni era permesso il giuoco dei tarocchi con qualche piccolo interesse, e a questo ci ho preso parte per qualche tempo; ma anche qui trovai il dolce misto coll’amaro. Sebbene non fossi valente giuocatore, tuttavia era così fortunato, che guadagnava quasi sempre: in fine delle partite io aveva le mani piene di soldi; ma al vedere i miei [383] compagni afflitti perchè avevano perduto, io diveniva più afflitto di loro. Si aggiunge che nel giuoco io fissava tanto la mente, che in seguito per alcun tempo non poteva più nè pregare, nè studiare, avendo sempre l’immagine travagliata dal re da coppe e dal fante da spada, dal tredici o dal quindici di tarocchi. Ho pertanto presa la risoluzione di non prendere più parte neanche a questo giuoco, come avea già rinunziato ad altri. Ciò feci alla metà del 1836”. Ne fu precipua causa l’aver egli vinto un giorno ad un suo competitore una somma non grossa, se si vuole, ma considerevole per l’esiguo borsellino del compagno. Giovanni, al vederlo mesto e quasi piangente, ne provò tanta compassione, che gli restituì quanto aveagli guadagnato, e da quel punto propose di non maneggiar più carte da giuoco e fermamente mantenne il suo proponimento.
Il giuoco delle carte non sembrava a D. Bosco un passatempo da ecclesiastici, perchè talora appassiona, talora è cagione di notevoli perdite di tempo, tal’altra è sconveniente per le circostanze. Trovandosi egli già sacerdote, non so in qual paese, per dettare gli esercizi spirituali, ed essendo ospitato dal parroco, una sera dopo cena fu invitato da alcuni preti giovani a giuocare ai tarocchi. Egli rispose che non era tanto pratico di quel giuoco. Si meravigliarono gli altri di questa sua ignoranza e dissero essere quello un giuoco così semplice, così innocuo, che da tutti si dovrebbe imparare. – Quando avrò nient’altro da fare, replicò D. Bosco, allora giuocherò ai tarocchi. – Quei reverendi per rispetto alla sua persona rimisero nel cassettino i tarocchi, che già avevano tra mano e si trattennero in assai utili discorsi. D. Bosco in questo frattempo, colla sua destrezza più che straordinaria, senza che nessuno se ne accorgesse, tirò fuori le carte da giuoco dal cassettino e se le mise in saccoccia. Poco dopo [384] dimandò licenza di ritirarsi in camera, avendo ancora qualche faccenda da disbrigare; ed avuto da tutti la buona notte, si ritirò. Alcuni ne imitarono l’esempio e andarono nelle loro camere. Due soli rimasero, che più degli altri erano desiderosi di giuocare: – Eccoci liberi, dissero; fuori i tarocchi, e facciamo almeno tra noi una partita. Ma aprono il cassettino, frugano, guardano in terra e non trovano le carte de’ tarocchi. – Chi sa dove siano andate? – diceva l’uno. – Le abbiamo pur messe qui! esclamava l’altro. Ma intanto più non trovandole, se ne andarono essi pure alle proprie stanze, benchè dolenti di non aver potuto fare la loro partita. Passando pel corridoio, ove era la camera di D. Bosco, discorrevano fra di loro sotto voce e si lagnavano di quella contrarietà. Quand’ecco uno si ricorda di avere un giuoco di carte nella propria camera. Contento, svela la scoperta al compagno; ma mentre si avviavano a prenderle, si sentono D. Bosco alle spalle, il quale, in tono semifaceto, li manda a dormire immediatamente, dando loro un’assai utile lezione.
CAPO XLIV.
Prontezza di Giovanni nel rendere servigio ai compagni – Sua piacevole compagnia – Gli antichi amici del ginnasio – Vigoria di Giovanni Gravissimo pericolo corso.
L’ASPETTO sempre ilare di Giovanni, le sue piacevoli maniere di trattare, la condiscendenza nel prestare servigio a chiunque abbisognasse dell’opera sua, ben presto gli attirarono pur l’affezione di tutti i seminaristi. Ed egli era felice della nuova vita, precisamente come chi vive in continui e squisiti banchetti[91].
Sempre pronto a scopare, trasportare oggetti da una camera all’altra, accomodare bauli, far berrette, radere barbe, tagliare capelli, rattoppare abiti stracciati e persino accomodare scarpe sdruscite, egli sembrava divenuto l’umile servo di tutti, e ciascheduno andava a gara nel dargli prova di riconoscente affetto. Fra le molteplici abilità sue, ei possedeva pur quella di assistere e medicare gl’infermi con non comune esperienza; inoltre, avendo da giovanetto imparato a cavare i denti con tanta destrezza da non far soffrire dolore di sorta, in simili casi tutti i compagni a lui ricorrevano.
Eziandio nelle dubbiezze, nelle malinconie, nelle difficoltà scolastiche, si veniva a cercare in lui il consigliere, l’amico [386] ed il ripetitore delle lezioni non bene capite. E questa era pur una gran carità per i tardi di mente, pei quali soleva ancora fare sunti sugli autori, allorchè doveano subire gli esami e per l’ampiezza dei trattati si trovavano alquanto imbrogliati. Imprestava generosamente i suoi libri, che pure gli costavano tante privazioni, a chiunque glieli avesse richiesti. Non di rado preparava le prediche per quelli che, invitati dai parroci a recitarle nelle loro chiese in tempo di vacanza, o non avevano agio a scriverle, o non ancora abilità a comporle. D. Giacomelli narrava infatti che qualche anno dopo un compagno era stato incaricato di due panegirici, e Giovanni, vedendolo imbarazzato, si offerse a scriverglieli, come di fatto fece, e poi glieli diede perchè li mandasse a memoria. Nè solo finchè fu in seminario, ma eziandio più tardi in Torino ad una semplice richiesta imprestava i suoi quaderni e le sue prediche agli amici, perchè se ne giovassero come meglio loro piacesse; il che fu causa che molti suoi manoscritti andassero dispersi.
La virtù dell’eutrapelia, che in lui era connaturata, manifestava la tranquillità inalterabile della sua anima. Nel tempo della ricreazione tratteneva i suoi condiscepoli in ischerzi e burle oneste e piacevoli. Talvolta proponeva loro l’interpretazione di certi detti in lingua latina, che generalmente contenevano un pensiero morale. Tal’altra dava di mano al giuoco del bastone, che, appoggiato semplicemente sopra il dito pollice, maneggiavalo in tutti i sensi e facevalo saltare, roteare rapidamente e in fine ritornare immobile sopra il suo dito. Di quando in quando, cedendo alle insistenze dei compagni, nei primi anni, faceva eziandio alcuni giuochi di prestigio. Su questo punto D. Cafasso non aveva approvato il proponimento assoluto da lui fatto nel giorno della vestizione chiericale. [387] Aveva poi sempre nuove invenzioni per destar l’allegria. Un giorno annunzia ai suoi camerati come egli sia capace di farsi la barba con un rasoio di legno. I compagni, benchè assuefatti a sempre nuove sorprese, rispondono essere impossibile. Giovanni afferma assolutamente. Corrono scommesse, e vien fissata l’ora per farne la prova. Tutti corrono in sua stanza e lo trovano occupato con un vero rasoio a radersi. – E dov’è il rasoio di legno? – Oh bella! Il mio nome qual è? – Bosco! – Questo rasoio a chi appartiene? – È tuo! – Dunque è rasoio di Bosco, e voi avete perduto la scommessa. – Scommessa e dialogo erasi fatto in piemontese e in tale dialetto bosco risponde alla parola legno. I compagni sulle prime restarono sorpresi di non aver capita cosa tanto facile, ma finirono con dargli ragione e scoppiare tutti in una forte risata.
Nel raccontare le storielle Giovanni era di una gaiezza sì attraente, da non potersi immaginare: sapeva contarle tanto bene, da destare sempre l’ilarità di chi l’udiva. Però, d’indole e carattere serio qual era, anche nelle cose più ridicole, egli mai si vide ridere sgangheratamente.
Nel giorno onomastico del rettore del seminario egli veniva di solito incaricato di fare la poesia in greco. Una volta, mentre tutti aspettavano da lui un argomento serio, uscì fuori con un sonetto bernesco. Il primo verso era latino, il secondo francese, il terzo italiano, il quarto piemontese, e così via discorrendo. Fu una risata inestinguibile, sicchè non c’era verso continuar la lettura degli altri componimenti.
Egli era divenuto oggetto di meraviglia ai compagni per la facilità, colla quale componeva ed anche improvvisava a poesie. Ei possedeva nella sua memoria un tesoro inesauribile di versi e di rime. Le sue strofe, piene di brio, talora erano veramente disciplinate secondo le regole; in generale però, [388] ispirate dall’estro, non erano troppo accurate in quanto a rime, misure o tronche, fatte solo per l’effetto del momento, che ottenevano colla bellezza dell’idea. Giustamente perciò egli era chiamato poeta estemporaneo. I suoi carmi erano sempre ispirati da argomenti religiosi e morali e sovente da gratitudine verso i benefattori.
Gli antichi amici del ginnasio civico di Chieri non lo dimenticavano Al giovedì la porteria del seminario si riempiva di giovanetti studenti, i quali venivano a portargli i loro quaderni e le loro pagine da esaminare. Ed egli, tutto lieto, correggeva, notava gli errori, spiegava le frasi, ripeteva loro le lezioni udite in iscuola. Non lasciava però mai che partissero da lui, senza qualche salutare pensiero. Così ci narrava D. Giacomo Bosco.
Ma aspettato con maggior desiderio da Giovanni era sempre Luigi Comollo, che in quell’anno faceva retorica. Comollo era ben degno di essere amato da ogni anima cristiana. Di ingegno svegliato, di indole dolcissima, esatto fino allo scrupolo ne’ suoi doveri, illibato nei costumi, costante Del bene, amantissimo della preghiera e dei Sacramenti, era un vero angiolo, che attraeva i compagni a specchiarsi nella sua condotta. Spesse volte veniva in seminario a visitare Giovanni, e come rapida passava quell’ora, nella quale i due cuori amanti di Dio si palesavano i progetti di una vita che aveano consacrata alla salute delle anime! Giovanni non aveva segreti per Comollo, nè questi per Giovanni. E però in quell’anno che Giovanni stette diviso da Comollo, parte dall’amico stesso, parte dai compagni, venne a conoscere tutto ciò che operava o diceva l’amico, e ogni cosa conservava gelosamente nel suo cuore.
Anche i condiscepoli, collocati dai parenti in collegi lontani, o rimasti alle loro case, tenevano corrispondenza epistolare [389] col nostro Giovanni. L’amicizia non si estingue per la lontananza, quando ha per alimento la carità. La maggior parte di quelle lettere vennero da Giovanni stesso distrutte. Fra alcune però che si conservarono, una ne trovammo nel suo scrittoio, che crediamo pregio dell’opera qui trascrivere. Gli fu spedita da un compagno, che studiava filosofia non si sa in quale altra casa di educazione. Eccola:
“26 gennaio 1836.
Carissimo amico,
Io ti avrei con piacere risposto molto più presto, se avessi potuto da qualcheduno farti avere la lettera nelle proprie mani, avendo inteso nella tua che ciò molto più ti gradisce. Per questo dovetti aspettare con mio dispiacere che mi si presentasse l’occasione.
Nulla di nuovo mi occorre da annunziarti, perchè, essendo chiuso fra quattro miserabili e strette mura, è cosa impossibile il poter sentire, oppure vedere di quando in quando qualche avvenimento, che mi molcisca quella nauseante noia e fastidio che di continuo ho indosso.
Sono, lasciami dir così, tra i martirii ed i fulmini, vale a dire che i professori nostri di continuo ci perseguitano. Quello di logica ha sempre in bocca i suoi castighi ed ha già castigati alcuni: l’altro di geometria vuole continuamente scagliare fulmini. Tutti e due poi ci contano due o trecento volte al giorno che non pochi di noi alla fine dell’anno saranno rimandati: dimodochè tutti i giorni siamo sempre sgridati or dall’uno, or dall’altro; e ci dicono che non hanno mai avuto da insegnare a tavole tanto rase quanto siamo noi, soggiungendo non sapere essi se siamo caduti dalla luna, o soltanto [390] venuti l’altro giorno al mondo. Da ciò puoi intendere come ce la possiamo passare, perseguitati a questo modo continuamente.
Sono a salutarti per parte di Burzio, e ti prego a salutare tutti gli amici nostri, che teco convivono.
Di vivo cuore mi protesto e sono
Il tuo aff.mo servo ed amico
- A.
Al Sig. Giovanni Bosco, Chierico nel Seminario di Chieri”.
Una lettera non si conserva a caso e non si custodisce gelosamente fra le altre carte d’importanza per tanti anni. Io credo quindi di mal non mi apporre dicendo ch’essa non sia stata distrutta unicamente perchè ricordavagli la necessità di trattare sempre i giovani con dolcezza e di cercar ogni mezzo per rendere loro gradita una casa di educazione. Non vi ha dubbio che la risposta di Giovanni sia stata conforme alla virtù dell’obbedienza e pazienza cristiana, perchè era suo sistema costante quello di sostenere l’autorità, ma senza ledere la carità, consolando chi soffriva, secondo l’avviso di S. Paolo: “Rallègrati con chi si rallegra, piangi con chi piange”[92]. L’autore di questa lettera, fatto chierico, l’anno seguente, lo troviamo compagno di Giovanni nello stesso seminario di Chìeri.
Intanto Giovanni, mentre andava crescendo nello spirito di pietà, come ci attestano quanti lo conobbero in seminario, sei, bene non sentisse un gran miglioramento nella sanità [391] corporale, tuttavia conservava quella forza straordinaria, che avealo fatto ammirare più volte dai suoi condiscepoli. Solamente usando le dita spezzava piastrelle di rame o di ferro. Un giorno, suonata l’ora dello studio, non si potè rinvenire la chiave della sala. La porta era robusta. I seminaristi tentavano con mille maniere e con grimaldelli di sforzare la serratura, ma non ci riuscivano. Il prefetto finalmente diè l’ordine di far venire il fabbro. Giovanni, che fino a quel momento era stato in disparte, si fece avanti e chiese: – Volete che apra io? – Tu? E con qual mezzo? È impossibile! – Se il prefetto mi dà licenza, io l’aprirò di un colpo. – Fa la prova – esclamò incredulo il prefetto. Giovanni allora assestò alla porta un pugno con uno spintone così formidabile, che la sfondò, e, svelta la serratura, lasciò libera l’entrata. I compagni restarono senza parola, contemplandolo stupefatti.
Ma questa stessa forza poco mancò che non gli cagionasse la morte, o almeno gli producesse gravi lesioni nelle viscere. Una sera, non so per qual motivo, lasciata la ricreazione, saliva le scale e, contro il suo costume, correndo con rapidità imboccava uno stretto ed oscuro corridoio. Un compagno, che calzava scarpe di panno, scendeva pur egli a precipizio, persuaso di non incontrare ostacoli in quel buio. L’uno non si avvide dell’altro e accadde un terribile scontro. Il compagno di rimbalzo fu gettato alcuni passi indietro, e Giovanni, rimasto in piedi ancora per qualche istante, esso pure stramazzò per terra. I seminaristi, notando la loro prolungata assenza, ne andarono in cerca e li trovarono ambedue immobili, fuori de’ sensi, col sangue che loro colava dalla bocca, dalle orecchie e dal naso. Sollevati sulle loro braccia, li portarono nell’infermeria. Ci vollero più ore prima che Giovanni rinvenisse. Più sfortunato il compagno, in sul far dell’alba era ancor privo de’ sensi, e quando ritornò in sè, [392] pareva divenuto fatuo, sicchè temevasi che il suo cervello fosse rimasto stravolto. Solo in sulla sera, con gaudio di tutti, passava quell’intronamento, e senza averne alcuna conseguenza, ambedue poterono ritornare fra i compagni.
Nel corso di questa storia incontreremo altri fatti di simil genere, cagionati vuoi da infermità, vuoi da cause fisiche esterne, vuoi dalla malizia degli uomini, nei quali per certo Giovanni Bosco, senza il soccorso speciale della divina Provvidenza, avrebbe dovuto rimaner morto. Ma il Signore nei suoi misericordiosi disegni, aveva stabilito di concedergli ancora cinquantadue anni di vita, che egli spese tutti alla sua maggior gloria ed al bene delle anime.
CAPO XLV.
Giovanni riporta il premio – Visita i suoi antichi padroni alla Moglia – È proposto come assistente e ripetitore di lingua greca ai giovani del Collegio Reale ritirati a Montaldo – Si perfeziona nel greco – Ritorna in seminario Sua povertà.
IL FELICE risultato del primo anno di seminario così è compendiato da D. Bosco nel suo manoscritto: “Nel seminario sono stato assai fortunato, ed ho sempre goduto l’affezione de’ miei compagni e quella di tutti i miei superiori. All’esame semestrale si suole dare un premio di L. 60 in ogni corso a colui, che riporta i migliori voti nello studio e nella condotta morale. Dio mi ha veramente benedetto e pei sei anni che passai in seminario sono sempre stato favorito di questo premio”. Egli partiva da Chieri lasciando nei compagni vivo desiderio di riunirsi a lui dopo le vacanze, come più volte alcuni di essi ci affermarono.
I primi suoi passi li rivolse alla Moglia di Moncucco, per far visita a quella cara famiglia, dalla quale per due anni aveva ricevuto tante prove di affezione e procurare loro una dolce sorpresa. Ed ecco infatti, mentre i signori Moglia stavano battendo il grano, vengono venire alla loro volta in mezzo ai campi un prete, il quale si ferma in fondo all’aia quasi per prendere respiro. I lavoratori cessano di battere e guardano meravigliati quell’improvvisa comparsa, desiderosi [394] di conoscere chi sia e qual motivo l’abbia là condotto. Quegli si avanza; e qual non fu il loro stupore e il gran piacere che provarono quando lo riconobbero. Il chierico Bosco, fatti i primi complimenti co’ suoi antichi padroni, che per la commozione avevano le lagrime agli occhi: – Vedete, disse, che io mi faccio prete? – Quei buoni contadini lo tennero qualche giorno con loro facend6gli mille feste. E il figlio Giorgio, che allora contava già i suoi undici anni e osservava curiosamente tutti i passi e le azioni del chierico ospite, affermava che lo vedeva sempre occupato o nella preghiera o nello studio ed assiduo nel recarsi alla chiesa.
Giunto presso sua madre, Giovanni vi dimorò poco tempo, per la ragione che egli qui espone: “Uno studio, che mi stava molto a cuore, così egli, era quello del greco: aveva già appreso i primi elementi nel corso classico, avea studiata la grammatica ed eseguite le prime versioni coll’uso dei lessici. Una buona occasione mi fu a tale uopo assai vantaggiosa. L’anno 1836, per la minaccia di coléra, che faceva ben 5000 vittime nella sola Napoli e serpeggiava pur nella Liguria, i Gesuiti di Torino anticiparono la partenza dei convittori dal collegio del Carmine per Montaldo, ove essi tenevano una magnifica villeggiatura. Quell’anticipazione richiedeva doppio personale insegnante, perchè dovevansi tuttora coprire le classi degli esterni, che intervenivano al collegio. D. Cafasso che ne era stato richiesto, propose me per una classe di greco. Ciò mi spinse ad occuparmi seriamente di questa lingua, per rendermi idoneo ad insegnarla. Di più, trovandosi nella stessa Compagnia un sacerdote di nome Bini, profondo conoscitore del greco, di lui mi valsi con molto vantaggio. In soli quattro mesi mi fece tradurre quasi tutto il Nuovo Testamento, i due primi libri di Omero, con parecchie odi di Pindaro e di Anacreonte. Quel degno sacerdote, [395] ammirando la mia buona volontà, continuò ad assistermi e per quattro anni ogni settimana leggeva una composizione greca o qualche versione, che io gli spediva e che egli puntualmente correggeva e poi mi rimandava colle opportune osservazioni. In questa maniera potei giungere a tradurre il greco quasi come si farebbe del latino”. Infatti nel 1886, precisamente il 10 febbraio, alla presenza nostra andava recitando per intero alcuni capitoli delle lettere di S. Paolo in greco ed in latino; poichè ci sapeva a memoria, nelle due lingue, tutto il Nuovo Testamento.’
A Montaldo Giovanni fece scuola per circa tre mesi, sostenendo pure la carica di assistente ad una camerata in tutto quel tempo di vacanza. Quivi ebbe campo di fare conoscenza con parecchi giovani di distinte famiglie, che conservarono sempre di lui ottima memoria e della cooperazione dei quali seppe poi giovarsi, quando ne venne il bisogno. Potè eziandio conoscere, colla sua pietà e collo zelo che l’ardeva per la salute delle anime, i difetti, i pericoli di questa classe di fanciulli, fra i quali era la prima volta che si trovava, e la difficoltà di acquistare su di essi quel pieno ascendente che è necessario per far loro del bene. Quindi si persuase non essere egli chiamato ad occuparsi de’ giovani di famiglie signorili. Più tardi infatti, il 5 aprile 1864, diceva a D. Ruffino, che gli parlava di alcuni progetti, tra gli altri quello di avere poi col tempo un collegio di nobili giovani: Questo no; non sarà mai; finchè vivrò io e per quanto dipenderà da me, non sarà mai. Ciò sarebbe la nostra rovina, come lo fu per varii Ordini religiosi, che avevano per primo scopo l’educazione della gioventù povera, cui poi abbandonarono per appigliarsi ai nobili. Eppure egli dovette poi accettare il collegio di Valsalice, per le vive istanze della Commissione dirigente, pel comando di Monsignor Gastaldi e per tutelare [396] l’onore del clero torinese, sottomettendosi a sacrifizii dolorosi, che Dio solo avrà saputo ricompensare.
Durante il tempo delle vacanze, Giovanni non potè ripassare, nè studiare nulla di ciò che doveva portare all’esame dei Santi, causa la continua e coscienziosa occupazione a Montaldo. Tuttavia, ritornato a novembre nel seminario di Chieri, nei pochi giorni precedenti agli esami prese i libri, tagliò i fogli al trattato di metafisica, su cui doveva rivolgersi l’esame, benchè non fosse stato spiegato, si presentò agli esaminatori e superò felicemente la prova.
Nè questo studio ne’ suoi risultati può condannarsi come superficiale; poichè Giovanni Bosco facilmente riteneva a memoria i trattati, nè si stancava poi dal meditarli in tutte le loro parti, prove, distinzioni ed obbiezioni. La sua mente matematica era così ordinata, che procedeva sempre ne’ suoi ragionamenti per via di definizioni esatte, quali le recano i migliori autori. E di ciò noi, che udimmo parecchi anni le sue istruzioni in chiesa, possiamo far ampia testimonianza; giacchè egli soleva premettere sempre la definizione della verità, del vizio, o della virtù, che formava oggetto del suo dire, ordinatamente poi procedendo alle varie molteplici prove. A questo modo restavano incancellabili le verità che da lui si apprendevano.
Più volte inoltre dovemmo stupire, dopo tanti anni che egli avea lasciato gli studii di filosofia, della prontezza delle sue risposte. D. Ciattino, uomo molto dotto, filosofo che vantavasi seguace di Rosmini, fuggito da Venezia nel 1856 per cause politiche, era stato raccomandato a D. Bosco e per circa un anno ospitato nell’Oratorio. Un giorno, sul finire del pranzo, si venne a parlare dell’origine delle idee e di altre quistioni filosofiche. D. Ciattino espose la sua opinione. D. Bosco tranquillamente trasse dalla proposizione di lui la [397] prima conseguenza, e poi con una sequela di dunque dunque stringati, precisi, schiaccianti, che non ammettevano replica, venne a questa conclusione: – Ma dunque lei è panteista? D. Ciattino, balbettò qualche risposta, ma siccome non era possibile svincolarsi dalle ragioni addotte da D. Bosco e gli pesava scomparire in faccia ai commensali, si sdegnò e uscì dal refettorio sbattendo fragorosamente la porta. Tutti i giovani presenti non sapevano darsi ragione di quella insolita vivacità di modi. Alla sera a cena D. Ciattino era al suo posto e mangiava tutto musorno. D. Bosco lo guardava sott’occhi sorridente, e a un tratto prese a dirgli: Senta, D. Ciattino; forse, stamattina io senza volerlo l’ho offeso. Sono entrato in un argomento, in un campo che non mi appartiene. Io non son filosofo e quindi mi compatirà, se l’ho contraddetto. – D. Ciattino alzò il viso, si rasserenò e poi graziosamente minacciandolo colla mano: – Lei non è filosofo? Dice di non essere filosofo?… – A questa scena era presente D. Francesia.
Verso il 1875 D. Clemente Bretto domandava a D. Bosco: – Gli animali non possono aver demeritato e non possono meritare: perchè dunque il Signore permette che siano infelici e li lascia soffrire? – D. Bosco, senza alcuna esitanza, rispose subito press’ a poco così: – Sebbene soffrano, gli animali non sono infelici, perchè la felicità o l’infelicità esigono la ragione, che gli animali non hanno; quindi nulla se ne può inferire contro la bontà o provvidenza di Dio. Un giorno fu interrogato: – Che cosa è il timore? – Tosto rispose: – Il timore altro non è che la privazione degli aiuti della ragione[93].[398]
In molte altre occasioni, che noi lasciamo qui di accennare per non andare troppo in lungo, Giovanni diede prova del suo profitto negli studi filosofici. E noi, allargando l’àmbito del nostro presente giudizio, dobbiamo dire che solo da un attento e fortunato osservatore poteva essere giudicata la molteplice e sincera sua scienza ed erudizione filosofica, teologica, biblica, storica, casistica morale, ascetica, di diritto canonico, fisica, matematica e via discorrendo. Ei conosceva bene quanto gli era necessario per occupare quel posto che la Provvidenza gli aveva affidato nella sua Chiesa. Però non ne faceva mai pompa; anzi il suo umile contegno non permetteva neanco di sospettarla: e solo quando ve ne era bisogno o convenienza ne’ famigliari discorsi, essa scattava fuori all’improvviso come un lampo di luce, che abbarbagliava e faceva rimaner stupito chi non lo conosceva. Questi lampi tuttavia non erano frequenti, poichè, fin dal principio del suo ministero involto In un vero turbine continuo d’affari, poco tempo rimanevagli per le dissertazioni scientifiche, e le parole che traeva dal, cuore erano principalmente dirette a far amare da’ suoi giovanetti la religione e la virtù.
Egli però in questi anni poneva con santa allegrezza il fondamento del suo sapere in mezzo alle spine di una grande povertà. Non pur lo stretto necessario egli aveva, ma qualche, cosa di meno. Mancavagli perfino il danaro per comprarsi i libri di scuola indispensabili, ed era costretto a farseli imprestare di quando in quando da qualche amorevole compagno. Con gelosa cura indossava l’unico suo vestito, perchè non si sciupasse e subito rammendava la minima scucitura, perchè non accadesse qualche strappo. Cinque centesimi di lucido per le scarpe gli durava un anno intero, e per annerirle ricorreva ne’ giorni feriali ad espedienti ancor più economici. Le sue scarpe talora per il lungo uso e per le troppe [399] rappezzature erano venute quasi inservibili e non convenienti per le uscite di casa, e Maurizio Cappella, portinaio del seminario tuttora vivente, afferma avergli egli più volte imprestate le sue calzamenta, perchè potesse recarsi a passeggio ovvero al duomo.
Non invano avrebbe egli potuto ricorrere per sussidio al suo prevosto D. Cinzano e a D. Cafasso; ma suo sistema prediletto era quello di S. Francesco di Sales di nulla chiedere e nulla rifiutare per se stesso, preferendo vivere nelle angustie, piuttosto che importunare i benefattori per cose ch’ei reputava non assolutamente necessarie. In ciò egli era certamente animato dall’amore nobilissimo alla povertà evangelica. Chi fu testimonio continuo della sua lunga vita può attestare come il suo cuore fosse alieno dalle comodità e dalle ricchezze. Maneggiò immensi tesori affidatigli dalla Provvidenza divina, ma tutto per gli altri, nulla per sè. La povertà di N. S. Gesù Cristo era il suo ideale, del quale il reale Salmista aveva profetato: “Povero sono io ed in affanni fin dalla mia gioventù”[94].
CAPO XLVI.
Luigi Comollo entra in seminario – Preziosi frutti di una santa amicizia Bontà, umiltà e pazienza di Giovanni coi compagni – Le visite degli studenti di Chieri – Il circolo scolastico e una santa lega per l’osservanza delle regole del seminario – Studii ne’ quali si occupa Giovanni – Stima ed affezione dei Chieresi – Due consolanti avvenimenti.
NELLE vacanze dell’anno 1836, indossò pur l’abito chiericale l’angelico giovane Luigi Comollo, ed al riaprirsi delle scuole entrò anch’esso nel seminario di Chieri, dove nuovamente s’incontrò con Giovanni Bosco, il quale, ottenuto il condono di mezza pensione che solevasi concedere ai giovani più studiosi e poveri, con maggior lena incominciava il secondo anno di filosofia. Quivi vieppiù si riannodarono fra i due compagni i vincoli dell’antica amicizia, sicchè la vita dell’uno si confonde con quella dell’altro, e, per parlar di Giovanni, è giuocoforza valerci della biografia ch’egli stesso scrisse del Comollo, celando il proprio nome sotto l’appellativo di intimo amico. Noi in servirci di essa metteremo a posto il benedetto suo nome e accenneremo qua e colà a qualcuna delle sue virtù, che egli sempre gelosamente nasconde.
Comollo fin dal principio dell’anno erasi scritto sopra un pezzo di carta, che teneva sempre nel libro o nel quaderno, [401] di cui giornalmente soleva servirsi, un motto come programma della sua condotta: Fa molto chi fa poco, ma fa quello che deve fare; fa nulla chi ha molto, ma non fa quello che deve fare. Egli era obbedientissimo in ogni circostanza e in ogni cosa, e, suonato il campanello, subito interrompeva qualsivoglia cosa facesse, per rispondere alla voce di Dio, rappresentatagli da quel suono. Abborriva dallo spirito di critica e di censura, e niuno mai lo intese proferir parola che fosse contraria a quel principio che teneva fisso nella mente: Degli altri o parlare bene, o tacere affatto. Nella ricreazione, ne’ circoli, ne’ tempi di passeggiata desiderava sempre parlare di cose scientifiche, anzi in tempo di studio soleva formarsi nella mente una serie delle cose che meno intendeva, per quindi tosto comunicarle in tempo libero a Giovanni, onde averne la spiegazione.
Tutte le volte che i seminaristi assistevano in duomo alle solenni funzioni, non solevano più recarsi a recitare la corona della B. V.; ma il Comollo non seppe mai astenersi da siffatta speciale divozione; perciò, terminate queste pubbliche funzioni, mentre ognuno passava il tempo nella permessa ricreazione, egli con Giovanni si ritirava in cappella a pagare, come soleva dire, i debiti alla sua buona Madre colla recita del santo Rosario.
Amante e devoto di Gesù, Sacramentato, approfittava di tutte le occasioni per comunicarsi. Giunta l’ora di accostarsi alla sacra mensa, Giovanni, che gli era al fianco, lo scorgeva tutto assorto ne’ più alti e divoti pensieri. Composta la persona in santo atteggiamento, a passo grave, cogli occhi bassi, dando anche in iscuotimenti di commozione, avvicinavasi al Santo dei Santi. Ritiratosi poscia a suo posto, pareva fosse fuor di sè, tanto vivamente vedevasi commosso e da viva divozione compreso. Pregava, ma ne era interrotto da [402] singhiozzi, da interni gemiti e da lagrime; nè poteva acquetare i trasporti di tenera pietà, se non quando, terminata la Messa, si cominciava il canto del mattutino. Avvertito più volte da Giovanni a frenare quegli atti di esterna commozione, come quelli che potevano offendere l’occhio altrui: “Mi sento, rispondevagli, mi sento tale piena di affetti e di contento nel cuore, che, se non permetto qualche sfogo, mi pare di essere soffocato”. “Nel giorno della Comunione, diceva altre volte, mi sento ripieno di dolcezza e di gaudio, che non so nè capire, nè spiegare”.
Giovanni rispettava questa ardente divozione di Comollo, ma sentivasi internamente avverso a quanto aveva apparenza di singolarità, che potesse destare ammirazione negli altri. La sua pietà non era meno ardente di quella di Comollo, ma aveva aspetto diverso. Giovanni, fatta la S. Comunione, si ritirava al suo posto, e qui colla persona diritta, col capo leggermente chino, cogli occhi chiusi e colle mani giunte innanzi al petto, restava immobile tutto il tempo del ringraziamento. Non udivi un sospiro; vedevi solamente di quando in quando tremar le labbra che proferivano una muta giaculatoria: ma sovra il suo sembiante appariva così viva l’espressione della fede, che rimanevasi incantato a mirarlo.
Le azioni più semplici e indifferenti divenivano per Comollo mezzi opportuni ad esercitar la virtù. Era assuefatto ad incrocicchiar l’una sull’altra le gambe ed appoggiarsi col gomito, quando gli veniva bene, a mensa, o nello studio, o nella scuola. Per amor di virtù, anche di questo si volle correggere, e per riuscirvi pregò istantemente Giovanni di ammonirlo ed anche di imporgli qualche penitenza ogniqualvolta l’avesse veduto nelle succitate posizioni. Giovanni non mancò di accontentarlo, tanto più che egli fin d’allora era veramente l’edificazione di tutti pel suo contegno. Mai si vide con una gamba a [403] cavalcioni sull’altra, mai sdraiato sulle sedie; ritto sulla persona, il suo dorso non toccava la spalliera, e, se non lavorava, le sue mani teneva sul petto colle dita incrocicchiate. Di qui procedeva in ambedue quella esteriore compostezza, per cui in chiesa, nello studio, in iscuola, in refettorio e altrove innamoravano ed edificavano chiunque li rimirasse.
Nelle sue memorie D. Bosco fa cenno dell’amico suo con termini, che svelano, senza volerlo, la bellezza del proprio cuore e l’umile sentire di sè: “La mia ricreazione era non di rado interrotta dal Comollo. Mi prendeva egli per un lembo dell’abito, e dicendomi di accompagnarlo, conducevami in cappella per far la visita al SS. Sacramento per gli agonizzanti; recitare il S. Rosario, o l’uffizio della Madonna in suffragio delle Anime del Purgatorio.
Questo meraviglioso compagno fu la mia fortuna. A suo tempo sapeva avvisarmi, correggermi, consolarmi con sì bel garbo e con tanta carità, che in certo modo era contento di dargliene motivo per gustare il piacere di esserne corretto. Trattava famigliarmente con lui, mi sentiva naturalmente portato ad imitarlo; e sebbene fossi mille miglia da lui indietro nella virtù, tuttavia se non sono stato rovinato dai dissipati e se potei progredire nella mia vocazione, ne sono veramente a lui debitore. In una cosa solo non ho nemmeno provato ad imitarlo: nella mortificazione. Il vedere un giovanetto sui diciannove anni digiunare rigorosamente l’intera quaresima ed altro tempo dalla Chiesa comandato; digiunare ogni sabato in onore della B. Vergine, spesso rinunziare alla colezione del mattino, talvolta pranzare a pane ed acqua, sopportare qualunque disprezzo ed ingiuria, senza mai dare minimo segno di risentimento, il vederlo esattissimo ad ogni più piccolo dovere di studio e di pietà, queste cose mi sbalordivano e mi facevano ravvisare in quel compagno un angiolo come [404] amico, un eccitamento al bene, un modello di virtù per chi vive in seminario”.
Non ostante queste umili espressioni di Giovanni, egli era ben degno di stare a pari e di godere dell’amicizia di Comollo. Ecco infatti come ne parlano alcuni suoi compagni. D. Giovanni Francesco Giacomelli di Avigliana, che fu sempre amico carissimo di D. Bosco e a lui sopravvisse, così raccontava il modo, onde strinse con lui famigliarità. “Entrai nel seminario di Chieri un anno dopo di Giovanni Bosco. La prima volta che mi assisi nella sala di studio tra gli alunni di filosofia, mi vidi avanti un chierico che mi pareva di età avanzata. Giudicai che avesse dieci anni più di me. Di assai bell’aspetto, coi capelli tutti ricciuti, era pallido, magro e sembrava sofferente. Si sarebbe detto che con difficoltà avrebbe resistito agli studi fino alla fine dell’anno; invece, sebbene sempre un po’ cagionevole di sanità, andò di giorno in giorno acquistando maggior vigoria. Era il caro, nostro D. Bosco. Io allora fui preso per lui da viva simpatia e compassione. Egli pure guardava me con occhio compassionevole per l’imbarazzo, nel quale mi trovava, essendo io fatto, segno ai motteggi di alcuni compagni.
Entrato in seminario un mese dopo gli altri, non conosceva quasi nessuno, e nei primi giorni ero come sperso in mezzo ad una solitudine. Fu il chierico Bosco, che si avvicinò a me la prima volta che mi vide solo dopo il pranzo, e mi tenne compagnia tutto il tempo della ricreazione, raccontandomi varie cose graziose, per divagarmi dai pensieri che potessi avere di casa o dei parenti lasciati. Discorrendo con lui, venni a sapere che durante le vacanze era stato, alquanto ammalato. Egli poi mi usò molte gentilezze. Tra le altre mi ricordo che, avendo io una berretta sproporzionatamente alta, per cui varii compagni mi davano un po’ [405] di baia, e ciò rincrescendo a me e a Bosco, che veniva sovente meco, me la aggiustò egli stesso, avendo seco l’occorrente ed essendo molto abile a cucire. D’allora in poi incominciai ad ammirare la bontà del suo cuore.
La sua compagnia era edificante. Varie volte mi condusse in chiesa a recitare il vespro della Madonna o qualche altra preghiera in onore della gran Madre di Dio. Parlava volentieri di cose spirituali. Un giorno in tempo di ricreazione mi condusse in iscuola e mi spiegò l’inno del nome di Gesù, invitandomi a recitare i cinque salmi in onore di questo nome adorabile e facendomi notare come dalle diverse iniziali dei singoli salmi si poteva appunto raccorre la parola Jesus. Restai ammirato di questa sua divozione, che per me era nuova. Un’altra volta si parlava dell’Ave Maris stella, e spiegando le parole tulit esse tuus: Questo versicolo, disse, riguarda Gesù Cristo, che nacque da Maria Vergine: ma dicendo tuus di Gesù, ricordiamo a Maria noi esser suoi. Essendo Gesù venuto per salvare il mondo col prendere umana carne nel suo purissimo seno, tutto il popolo cristiano è tenuto come fratello di Gesù e figlio di Maria SS. Dal primo istante dell’Incarnazione noi abbiamo incominciato ad essere popolo di Maria Vergine. Perciò le diciamo: Monstra te esse Matrem: Mostra di essere nostra Madre, nostro aiuto, nostra protettrice. – Non pare che egli avesse già formulato in mente tutto ciò che si vide poi operare per Maria Auxilium Christianorum?
Fin d’allora Giovanni Bosco amava immensamente i giovani ed era sua delizia trovarsi in mezzo di loro. Tutti i giovedì, attirati da’ suoi bei modi, moltissimi giovanetti di Chieri, varii dei quali erano stati due anni prima suoi condiscepoli nel ginnasio, venivano a visitarlo, e noi sentivamo sempre all’ora consueta la voce del portinaio che gridava:, [406] Bosco di Castelnuovo! – Egli scendeva, s’intratteneva allegramente con quei giovani, che lo attorniavano come figli il proprio padre, entrava in discorsi relativi alle scuole, allo studio, alle pratiche di pietà, non ometteva mai di dar loro qualche buon consiglio, li conduceva eziandio in cappella a fare una breve preghiera e loro dimostrava un affetto tutto speciale. Dopo di averli congedati, più di una volta mi disse: Bisogna sempre introdurre nelle nostre conversazioni qualche pensiero di cose sovrannaturali. E un seme che a suo tempo darà frutto. – È l’avviso dello Spirito Santo: “Il pensiero di Dio sia fisso nell’animo tuo e tutti i tuoi ragionamenti siano de’ comandamenti dell’Altissimo”[95].
Giovanni era chiamato Bosco di Castelnuovo, continua D. Giacomelli, per distinguerlo da un altro chierico avente lo stesso cognome, che poi fu direttore delle Rosine in Torino. Accadde fra questi due un piccolo fatto, cui allora non si badò, ma che io ben ricordo. I due chierici dallo stesso cognome faceziavano e si dimandavano qual soprannome dovessero imporsi per distinguersi quando fossero chiamati. Uno disse: – Io sono Bosco Nespola (in dialetto piemontese pucciu). – E con ciò indicava essere un legno duro, nodoso, poco pieghevole. – E il nostro D. Bosco rispondeva: – Ed io mi chiamo Bosco di Sales, cioè a dire di salice, legno dolce e flessibile. – Pare che fin d’allora prevedesse la futura Congregazione avente per Patrono S. Francesco di Sales, e perciò di questo Santo voleva imitare la dolcezza. Di natura sensibilissimo anche per piccole cose, si capiva come senza virtù si sarebbe lasciato sopraffare dalla collera. Nessuno de’ nostri compagni, ed erano molti, inclinava come [407] lui a tale difetto. Tuttavia era evidente la grande e continua violenza che faceva per contenersi.
In iscuola era un esemplare. Io ammirava in lui una gran diligenza ed amore allo studio ed alla pietà. Non lo vidi mai prendere parte a divertimenti anche leciti e permessi dai superiori; ma, eziandio in tempo della ricreazione, o leggeva, o studiava, o passeggiava conversando coi compagni, sempre raccontando cose edificanti, oppure andava in chiesa a fare una visita al SS. Sacramento. Non mancò mai, nei cinque anni che fui suo condiscepolo in seminario, alla risoluzione presa di raccontare ogni giorno un esempio tratto dalla storia ecclesiastica, dalla vita dei Santi, o dalle glorie di Maria, Madre nostra amorosissima.
I compagni lo amavano e lo tenevano come carissimo condiscepolo, e se talora qualcheduno mostravasi emulo indiscreto o prepotente, ei si faceva rispettare per la sua abilità e tenevalo a segno col suo contegno. Se qualche volta avveniva tra i compagni qualche disordine, quantunque leggiero, o qualche diverbio per disparità di opinioni, egli s’intrometteva e metteva sempre la pace fra essi”. Fin qui D. Giacomelli.
Altro compagno di Giovanni nel seminario fu Mons. Teodoro Dalfi, nativo di S. Maurizio Canavese, che fu poi prete secolare e parroco zelantissimo dell’Archidiocesi di Torino, quindi aggregato alla Missione di S. Vincenzo de’ Paoli e mori dopo D. Bosco. Era un giovane eccellente, ma vivace oltre ogni credere, quale doveva essere naturalmente chi la Provvidenza divina destinava a percorrere palmo a palmo per ben quattro volte la Palestina, l’Egitto e altre regioni dell’Asia Minore, innamorato degli studi biblici, e a dare alla luce su questo argomento quattro grossi volumi. Egli pure lasciò scritte di D. Bosco le seguenti memorie: “Era l’anno 1836, quando, dopo tre anni di corso farmaceutico, [408] deposto l’abito secolaresco per indossare la sacra sottana, alla vigilia d’Ognissanti feci ingresso nel seminario di Chieri e la prima conoscenza fu col caro chierico Bosco. Conobbi anche l’indivisibile suo compagno il chierico Comollo. Anzi, dovendo allora, nell’entrata del corso, fare la scelta di un compagno e capitato ivi appunto il Comollo, mi avvicinai a lui; ma, dopo pochi giorni lo abbandonai, perchè, tutto quiete e pace, sarebbe stato meco in penitenza.
Giovanni Bosco, amico di tutti, non fu famigliare mai con altri, fuorchè con una piccola cerchia di chierici del suo corso, o conoscenti dei paesi a lui vicini. Con questi aveva formato una società fin da principio, della quale il Bosco era il padre, il padrone e il maestro, perchè più attempatello. Fra di loro erano il chierico Comollo, cui feci io la veglia nella notte antecedente alla sua morte, il chierico Zucca di vicino paese, Picchiotino, Antonio Avataneo e Burzio Poirinesi e Ronco di Chieri, che con qualche altro, che ora non son più, passavano ordinariamente sempre l’intera ricreazione ad udire i suoi racconti e ciò principalmente dopo la cena.
Io per rivendicarmi dei tre anni di laboratorio farmaceutico e di bottega, godeva fino all’ultimo dei minuti la ricreazione chiassosa, capo fanatico di bara rotta, specie di mosse di finta battaglia a corsa di due parti contendenti. Quante volte andava a strappare il povero Bosco per trascinarlo in ballo, tormentando quel poveretto, uso sempre a far due passi su di una pianella. Ma non ci fu mai verso… nè si adirava: solo diceva: Tu Dalfi!… tu Dalfi!… e bisognava lasciarlo. Nessuno lo vide correre mai, nè ricordo che mischiasse carte o tarocchi, o leggesse romanzi, o libri di poesie.
Quanto poi alla ricreazione del pomeriggio, nei giorni feriali, dopo appena un quarto d’ora, era sempre chiamato alla porta, e con licenza de’ superiori faceva un po’ di ripetizione [409] ad alcuni fanciulli esterni, accettando qualche esiguo compenso per le sue piccole spese necessarie, non avendo altri mezzi per sopperirvi. Suonavasi alla porta, poi davasi il segno della tal camerata, quindi il richiamo di Bosch ‘d Castelneuv: e lì la musica de’ compagni che facevano eco alla voce del portinaio:- Bosch ‘d Castelneuv, Bosco di Castelnuovo, Bois de Chateau neuf!! – Ed egli a ridere, ma non accelerare mai d’un passo la sua andata. Perciò può dirsi che l’ora di libertà era per lui solo quella dopo cena, l’ora dei racconti.
Posso dire di non averlo mai veduto in collera, e talora ne avrebbe avuto ben donde di accendersi; ma egli rideva e prendeva tutto per bene, pensando essere quelle salire o facezie e baie, non già offese. Peccato che coloro, i quali avrebbero potuto dire infinite cose della sua vita intima, ed erano esatti ed immancabili alla sua scuola, già tutti l’abbiano preceduto o seguito nell’eternità”.
Mons. Dalfi nella surriferita testimonianza accenna ad una società di chierici, formata intorno al chierico Bosco. Era dessa come una santa lega per l’osservanza delle regole del seminario e per l’adempimento esatto de’ proprii doveri di pietà e di studio. I principali soci erano Guglielmo Garigliano, Giovanni Giacomelli e Luigi Comollo. “Questi tre compagni furono per me un tesoro, lasciò scritto D. Bosco. Il circolo scolastico, incominciato l’anno antecedente, era sempre in fiore, accresciuto in quest’anno di alcuni nuovi soci. Si discutevano le difficoltà filosofiche non ben intese in iscuola, facendo sempre uso della lingua latina, come aveva proposto Comollo. Ciò tornava a tutti di grande vantaggio, perchè si giunse a maneggiare questa lingua nelle materie scolastiche con molta speditezza e con una famigliarità meravigliosa. Celebre a fare domande era Comollo. Egli, di più, sapeva animare le conversazioni con varie [410] utili ricerche e racconti, ma osservava costantemente quel non mai abbastanza encomiato tratto di civiltà, di tacere quando altri parla. Pel che non di rado avvenivagli di troncare a mezzo la parola, per dar campo a che altri liberamente parlasse. Un certo Domenico Peretti, poi parroco di Buttigliera, era assai loquace e rispondeva sempre. Garigliano era eccellente uditore e faceva soltanto qualche riflesso”. Con queste dispute, che esigevano una preparazione attenta nell’imparare in iscuola le lezioni dettate dai professori, ne venne che Giovanni possedeva a perfezione la logica, la metafisica, l’etica, l’aritmetica e la fisica, come apparirà nel corso di questa storia. “Il ferro assottiglia il ferro e l’uomo assottiglia l’ingegno del suo amico”[96].
Ed ecco un’altra prova di quanto asseriamo. Nel secondo anno di filosofia corse pericolo di non conseguire per concorso il condono di due mesi di pensione. Avea un competitore di grandissimo ingegno. Ambedue riuscirono i migliori fra i varii concorrenti, avendo ottenuto egualmente pieni voti, tanto nel verbale, quanto nell’esperimento in iscritto. Fu loro proposto se volevano dividere il premio. Giovanni acconsentiva; ma il compagno, benchè fosse molto ricco, tentennava a decidersi. Allora il professore intimò un secondo esame: il lavoro fu assai difficile, ma Giovanni Bosco rimase vincitore. E questa fortuna l’ottenne pur negli anni seguenti.
Intorno agli studi, però Giovanni fu dominato da un errore che gli avrebbe prodotto funeste conseguenze, se un fatto provvidenziale non glielo avesse tolto. “Abituato alla lettura dei classici in tutto il corso secondario, così scrive egli, assuefatto alle figure enfatiche della mitologia e delle [411] favole dei pagani, non trovavo gusto nello stile semplice dei libri ascetici. Giunsi a persuadermi che la buona lingua e la eloquenza non si potesse imparare dai libri che trattano di religione. Le stesse opere dei SS. Padri mi sembravano parto di ingegni assai limitati, eccettuati i principii religiosi, che essi esponevano con forza e chiarezza. Ciò era conseguenza di discorsi uditi da persone eziandio ecclesiastiche, valenti nella classica letteratura, ma poco rispettosi verso questi grandi luminari della Chiesa, perchè non li conoscevano.
Sul principio del secondo anno di filosofia, andato un giorno a far la visita al SS. Sacramento e non avendo meco il libro di preghiera, mi feci a leggere De imitatione Christi: ne lessi alcuni capi intorno al SS. Sacramento. Considerando attentamente la sublimità de’ pensieri e il modo chiaro e nel tempo stesso ordinato ed eloquente, con cui si esponevano quelle grandi verità, cominciai a dire tra me stesso: L’autore di questo libro era un uomo dotto – Continuando altre e poi altre volte a leggere quell’aurea operetta, non tardai ad accorgermi che un solo versicolo di essa conteneva tanta dottrina e moralità, quanta non avrei trovata nei grossi volumi dei classici antichi. È a questo libro che son debitore di aver cessato dalla lettura profana. Mi diedi pertanto alla lettura di Giuseppe Flavio delle antichità giudaiche, della guerra giudaica; di poi presi i ragionamenti sulla religione di Mons. Marchetti; quindi Frassinous, Balmes, Zucconi, e molti altri scrittori religiosi e gustai pure la lettura della storia ecclesiastica del Fleury, che ignorava essere libro da evitarsi. Con maggior frutto ancora ho letto le opere del Cavalca, del Passavanti, del Segneri e tutta la storia universale della Chiesa dell’Henrion, che mi restò impressa nella memoria.”
Voi direte: Occupandomi in tante letture, non poteva attendere ai trattati. Non fu così. La mia memoria continuava [412] a favorirmi, e la lettura e spiegazione dei trattati fatta nella scuola mi bastavano per soddisfare ai miei doveri. Quindi tutte le ore stabilite per lo studio io le potevo occupare in letture diverse. I superiori sapevano tutto e mi lasciavano libertà di farlo”.
Noi aggiungiamo che con molto amore egli studiava eziandio i SS. Padri ed i Dottori della Chiesa, S. Agostino, S. Girolamo e specialmente S. Tommaso, tanto che giunse perfino a sapere a memoria alcuni volumi di quest’aquila della filosofia e della teologia. Nei quattro anni che rimase ancora nel seminario lesse e studiò tutta la Bibbia, i Commentarii sulla Santa Scrittura dì Cornelio Alapide e del Tirino e prese estesa cognizione anche dei Bollandisti. Questi libri e quanti altri desiderava ei li prendeva in imprestito dalla biblioteca del seminario, e quando era in vacanza ricorreva ai parroci. Del resto, pare disposizione della Provvidenza che D. Bosco per qualche tempo ignorasse in parte la bellezza dei libri che trattano di religione, studio che richiede maggior maturità d’ingegno di quella che aver possa uno studente di rettorica o del primo anno di filosofia. L’amore ai classici era necessario per quella scienza indispensabile a chi doveva essere fondatore di tante case d’istruzione. Ed il Teologo Prof. Mons. Pecchenino, che fu stretto per tanti anni a lui in intima amicizia, affermava essere cosa mirabile il vedere come D. Bosco fosse istrutto in ogni ramo della letteratura italiana e latina. Però ogni cosa ha il suo tempo. Lo stesso Ecclesiastico ci dice: “Il saggio indagherà la sapienza di tutti gli antichi e farà studio nei profeti”[97].
Il chierico Bosco intanto finiva il secondo anno di filosofia ricco di nuova scienza, dell’amore de’ suoi compagni ed anche [413] di molti amici che numerava in città. Una lettera di un certe Brosio a D. Bonetti così narra: “Mi ricordo, essendo io, ancor giovinetto in Chieri, che D. Bosco, allora chierico, non solo dai ragazzi, ma altresì dagli adulti e dagli uomini di matura età era stimato come fornito di grande virtù. Era caro a tutti, perchè amantissimo della gioventù. Di continuo si tratteneva con noi e con una affabilità ed amorevolezza unica al mondo. Si poteva dire che esso viveva per i fanciulli. Allorquando i chierici uscivano dal seminario diretti al duomo per le sacre funzioni, tutti si fermavano per vederlo e a vicenda segnavansi col dito il chierico dai capelli ricciuti, chè con questo appellativo tra noi ragazzi era chiamato il chierico Bosco. I suoi modi famigliari mi spinsero a desiderare di aver con lui più intima conoscenza, e la cosa mi riuscì facilissima. Nel detto seminario trovavasi pure quel chierico Luigi Comollo, amico inseparabile di D. Bosco, e coi parenti del quale io era in istretta relazione. Approfittai della circostanza e col visitare il Luigi Comollo, che trovavasi sovente in compagnia di D. Bosco, raggiunsi lo scopo prefissomi, poichè dopo non molto tempo ancor io era divenuto suo amico, e la nostra amicizia intima durò fino alla sua morte”.
In quest’anno avvenivano due consolanti fatti pel nostro Giovanni. Mons. Fransoni nell’aprile percorreva e visitava i distretti vicariali di Chieri e di Castelnuovo. È supponibile che D. Cinzano, esponendogli lo stato del suo clero, gli abbia pur parlato del chierico Giovanni Bosco. Di qui l’Arcivescovo passava alle vicarie di Gassino e di Casalborgone; ma rientrato in Torino per le sacre ordinazioni, cadeva gravemente infermo. Riavutosi presto, si ritirava in Chieri per ricuperare nella quiete di quelle vaghe colline la pristina sanità, ospitato da un ragguardevole ecclesiastico Chierese. E tanto più aveva bisogno di riposo, in quanto che continue [414] erano state in questi anni le sue occupazioni, molteplici i dispiaceri provati nella necessaria opposizione che dovette sostenere contro le esorbitanze dei cesaristi di corte. Gli uomini posti a capo delle varie amministrazioni del governo sembrava che mettessero ogni studio nel far sorgere dissidiì tra lo Stato e la Chiesa, affine di restringere sempre più la giurisdizione di questa. Nel 1836 un decreto reale aveva ordinato alle Opere pie di presentare i conti ad una Commissione nominata dal Re ed investita di molti diritti, negando essere queste opere ecclesiastiche, sibbene laicali, dipendenti in tutto dal potere civile: un’ordinanza aveva proibito alle monache della Visitazione di stabilirsi in Thonon, sebbene avessero il consenso della S. Sede: il ministro Barbaroux comandava l’annullamento di due fogli di stampa delle Costituzioni sinodali della Diocesi d’Aosta: il senato pretendeva spettargli diritti sui cimiteri, mentre, essendo questi luoghi sacri, erano naturalmente soggetti alla giurisdizione vescovile; nello stesso tempo si negava la forza obbligatoria di certe sentenze de’ tribunali ecclesiastici. Tuttavia Re Carlo Alberto ascoltava le ragioni dell’Arcivescovo, temperava certe decisioni de’ suoi ministri, ricorreva a Roma per ottenere le desiderate concessioni. Infatti il Consiglio di Stato aveva proposto di togliere dalle mani del clero gli atti dello stato civile; il Re vi ripugnava e aperse trattative colla santa Chiesa. Il Concilio di Trento era stato il primo a porre rimedio al disordine delle famiglie, prescrivendo che in ogni parrocchia si tenessero i registri degli atti di nascita, battesimo, matrimonio e morte di ogni parrocchiano: erano adunque cosa tutta sua. Il Sommo Pontefice, ritenendo incolume il suo diritto, compose le cose di maniera che il Re ne fu pienamente soddisfatto, e in questo anno 1837 faceva inserire fra le leggi dello Stato le decisioni papali. [415] Mentre Mons. Fransoni, stanco di queste lotte, riprendeva forza nella pace di Chieri, non vi ha dubbio che Giovanni andasse a visitarlo e gli porgesse i suoi primi ossequii figliali, e destasse in lui un vivo sentimento di affezione da non più dimenticarlo. Senza una previa conoscenza, non si può spiegare la facilità, colla quale poi Mons. Fransoni gli accordava, prima del tempo stabilito, l’ordinazione al presbiterato, favore che in allora di raro concedevasi e con grande difficoltà.
Un’altra consolazione ebbe il chierico Bosco in quel tempo. Mons. Fransoni, con lettera pastorale del 5 agosto, annunziava ai fedeli essersi degnato il Sovrano di approvare che ne’ suoi Stati si raccogliessero elemosine per la grande Opera della Propagazione della Fede, e ne esponeva lo scopo, i vantaggi e i favori spirituali concessi dal Sommo Pontefice a coloro che vi dessero il nome e ne adempissero le imposte obbligazioni. Ricordiamo come fra i desiderii del chierico Bosco vi fosse quello di dedicarsi alle Missioni e intenderemo come nuovi orizzonti di apostolato si aprissero innanzi alla sua mente, più vivi affetti per la salvezza eterna di milioni di anime accendessero il suo cuore, e così efficaci, che un giorno li vedremo aggiungere nuove pagine alle storie gloriose delle Cattoliche Missioni.
CAPO XLVII.
Le vacanze del chierico Giovanni Bosco – Festino di campagna – Il suono del violino – La caccia – Modello di chierico in vacanza – Ripetizioni ad alcuni studenti – Lo studio della storia sacra, della geografia, dell’ebraico e del francese – Si ripete il sogno fatto a Morialdo – Predizione avverata.
NELLO svolgere la nostra narrazione abbiamo ammirata più volte l’umiltà di D. Bosco, il quale nelle sue memorie si chiama in colpa di varii fatti, che pure in sè nulla presentano di veramente peccaminoso, o sono scusabili coll’inavvertenza e coll’ardore dell’età giovanile. Meditando noi però le sue pagine e trovandole in contraddizione per questo lato con quanto di lui dissero i suoi coetanei, siamo venuti a questa conclusione: aver cioè D. Bosco voluto eziandio rappresentare in sè, con tinte molto vive, i difetti, ne’ quali sogliono cadere e i pericoli che facilmente ponno incontrare i giovanetti, gli studenti, i chierici volonterosi di far bene, ma inesperti. Sono avvertimenti e lezioni dettate dal padre a’ suoi figli, acciocchè non iscoraggiati dalle continue lotte coll’amor proprio, colle tendenze di un’indole difficile, colle inclinazioni del cuore, cogli ostacoli che sorgono al conseguimento del retto fine, tendano [417] costantemente coll’umiltà, coll’obbedienza, colla pietà e collo studio alla perfezione e riescano finalmente servi fedeli del Signore, disposti ad ogni opera buona.
Ciò risulta ancora da alcuni aneddoti, che gli accaddero nelle vacanze e de’ quali scrive in questi termini: “Un gran pericolo pei chierici sogliono essere le vacanze, tanto più in quel tempo che duravano quattro mesi e mezzo, dalla festa di S. Giovanni Battista fin dopo quella d’Ognissanti. Io impiegava il tempo a leggere e scrivere; ma, non sapendo ancora trar partito dalle mie giornate, ne perdeva molte senza frutto. Cercava di ammazzarle con qualche lavoro meccanico. Faceva fusi, cavigliotti, trottole, boccie, pallottole al torno; cuciva abiti, tagliava e cuciva scarpe; lavorava nel ferro, nel legno. Era muratore e legatore da libri. Ancora presentemente avvi nella casa mia di Morialdo uno scrittoio, una tavola da pranzo con alcune sedie, che ricordano i capi d’opera di quelle mie vacanze. Ali occupava pure a falciare l’erba ne’ prati, a mietere il frumento nel campo, a spampinare, a smoccolare, a vendemmiare, a vineggiare, a spillare il vino e simili. In tutti questi lavori mi ero già esercitato nelle vacanze precedenti, prima che fossi chierico. Mi occupava pure de’ miei soliti giovanetti, ma ciò poteva solamente fare nei giorni festivi. Radunatili nel mio cortile alla sera, dopo alcuni giuochi, loro indirizzava una breve allocuzione. Provai però un gran conforto a fare catechismo a molti miei compagni, che trovavansi ai sedici ed anche ai diciassette anni digiuni affatto delle verità della fede. Mi sono eziandio dato ad ammaestrarne alcuni nel leggere e nello scrivere, con assai buon successo; poichè il desiderio, anzi la smania d’imparare mi traeva giovanetti di tutte le età. La scuola era gratuita, ma metteva per condizione assiduità, attenzione e la confessione mensile. In principio alcuni, per non sottoporsi [418] a queste condizioni, cessarono, la qual cosa tornò di buon esempio ed incoraggiamento agli altri.
Mentre poco fa diceva che le vacanze sono pericolose, intendeva parlare per me. Senza che se ne accorga, ad un povero chierico spesso accade di trovarsi in gravi pericoli. Io ne fui alla prova. Una volta venni invitato ad un festino in casa di alcuni miei parenti. Non voleva andare; ma, adducendosi che non eravi alcun chierico che servisse in chiesa, ai ripetuti inviti di un mio zio credei bene di accondiscendere e ci sono andato. Compiute le sacre funzioni, cui presi, parte a servire e cantare, ce ne andammo a pranzo. Sino ad una parte del desinare andò bene; ma, quando si cominciò ad essere un po’ brilli di vino, si misero in scena certi parlari, che non potevansi più tollerare da un chierico; provai a fare qualche osservazione, ma la mia voce fu soffocata. Mi alzai da mensa, presi il cappello per andarmene; ma lo zio si oppose; un altro si mise a parlare peggio e ad insultare tutti i commensali. Dalle parole si passò ai fatti: schiamazzi, minacce, bicchieri, bottiglie, piatti, cucchiai, forchette e poi coltelli si univano insieme a fare, un baccano orribile. In quel momento io non ho avuto più altro scampo che darmela a gambe. Giunto a casa, ho rinnovato di tutto cuore il proponimento già fatto più volte di stare ritirato, se non si vuole cadere in peccato”.
Oh! quanta ragione ha lo Spirito Santo di dire che: “il troppo vino fa le contese, l’ira e molte rovine; il vino bevuto in copia è l’amarezza dell’anima, fa ardito lo stolto ad offendere, snerva le forze ed è cagione di ferite: in un convito dove si beve, non riprendere il prossimo e nol disprezzare nella sua allegria, non dirgli parole d’ingiuria e nol pressare col chiedere restituzione di una cosa tua”[98]. Insomma [419] in tali circostanze bisogna o far come loro o tacere; e allora è meglio restar a casa propria. Non si deve quindi frequentare i convivii dei beoni![99].
“Fatto di altro genere, ma eziandio spiacente, mi succedette a Croveglia, frazione di Buttigliera; Volendosi celebrare la festa di S. Bartolomeo, fui invitato da altro, mio zio (di nome Matteo, il quale giunse poi all’età di 102 anni) ad intervenire per aiutare le sacre funzioni, cantare ed anche suonare il violino, che era stato per me un istrumento prediletto, al quale pero’ aveva di già rinunziato. Ogni cosa andò benissimo in chiesa. Il pranzo era a casa di quel mio zio, priore della festa, e fino allora eravi nulla da biasimare. Era intervenuto eziandio il parroco. Finito il desinare, i commensali m’invitarono a suonare qualche cosa a modo di ricreazione. Mi rifiutai. Gli altri insistettero che volevano una suonata dalla mia mano maestra. Risposi che avea lasciato a casa il mio violino e che qui presentemente non avea istrumento di sorta. – In quanto a ciò si trova presto il rimedio, saltò su a dire un convitato; il tale nel paese possiede un violino; andrò a prenderlo e tu suonerai. – E in un lampo andò e tornò col violino. Io voleva ancora scusarmi: Almeno, disse un musicante, mi farà l’accompagnamento. Io farò la prima, ella farà la seconda parte. Miserabile! non seppi rifiutarmi e mi posi a suonare e suonai per un tratto, quando odo un bisbiglio ed un calpestio che segnava moltitudine di gente. Mi faccio allora alla finestra, e miro una folla di persone, che nel vicino cortile allegramente danzava al suono del mio violino. Non si può esprimere con parole lo sdegno, da cui fui invaso in quel momento. – Come, dissi ai commensali, [420] io che grido sempre contro ai pubblici spettacoli, io ne sono divenuto promotore? Ciò non sarà mai più. Prendete, portate subito questo violino al suo padrone, ringraziatelo e ditegli che non ho più bisogno. Levatomi di là, tornai a casa, presi il mio violino, gli montai sopra coi piedi, lo feci in mille pezzi, nè me ne volli mai più servire, sebbene siansi presentate occasioni e convenienze nelle funzioni sacre. Di ciò avea fatta promessa solenne e la mantenni. Più tardi insegnai ad altri il modo di suonare questo istrumento, ma senza che io lo prendessi in mano.
Ancora un episodio avvenutomi alla caccia. Lungo, l’estate andava in cerca di nidiate, di autunno uccellava col vischio, colla trappoletta, colla passeriera, e qualche volta anche co1 fucile. Un mattino mi sono dato ad inseguire una lepre, e camminando di campo in campo, di vigna in vigna, trapassai valli e colli per più ore. Finalmente giunsi a tiro, di quel povero animale e con una fucilata gli ruppi le coste, sicchè la povera bestiolina cadde, lasciandomi in sommo abbattimento in vederla estinta. A quel colpo corsero i miei compagni, e mentre essi rallegravansi per quella preda, portai uno sguardo su di me stesso e mi accorsi che era in manica di camicia, senza sottana, con un cappello di paglia, per cui faceva la comparsa di un contrabbandiere e ciò in sito lontano, oltre a due miglia da casa mia. Ne fui mortificatissimo, chiesi scusa ai compagni dello scandalo dato con quella foggia di vestire, me ne andai tosto a casa e rinunciai nuovamente e definitivamente ad ogni sorta di caccia. Coll’aiuto del Signore questa volta mantenni la promessa. Dio mi perdoni quello scandalo.
Questi tre fatti furono per me una terribile lezione, e d’allora in poi mi sono dato con miglior proposito alla ritiratezza, e fui davvero persuaso che chi vuole dedicarsi [421] schiettamente al servizio del Signore bisogna che lasci affatto i divertimenti mondani. È vero che spesso questi non sono peccaminosi; ma è certo che pei discorsi che si fanno, per la foggia di vestire, di parlare, di operare contengono sempre qualche rischio di rovina per la virtù, specialmente per quella delicatissima della castità”.
Questi sono i giudizii, che umilmente D. Bosco pronunziava sulle sue vacanze; ma ben diversamente sentivano di lui quanti ne furono testimoni. Narrava il viceparroco D. Ropolo: “Nelle vacanze autunnali il chierico Bosco prendeva tutte le cautele per conservare il fervore e lo spirito del seminario, occupandosi continuamente nello studio ed anche in lavori manuali, che non erano sconvenienti alla solitudine del Susambrino e dei Becchi e che gli erano necessari per rinfrancare alquanto la indebolita sua salute. Non si permetteva mai un istante di ozio. Era fedele osservatore di tutte le pratiche divote proprie della vita chiericale: meditazione, letture spirituali, rosario, visita al SS.. Sacramento, assistenza giornaliera alla santa Messa e frequenza ai SS. Sacramenti. Essendo la sua casa lontana dalla parrocchia, e perchè trattenuto da qualche impedimento e specialmente dal suo stato infermiccio, in qualche giorno festivo non poteva assistere alla prima Messa. Allora egli veniva a far la sua Comunione alla Messa ultima, che si celebrava verso le undici, con grande edificazione dei fedeli. Si prestava con prontezza a servire ad ogni funzione religiosa. Tutte le domeniche faceva il catechismo in parrocchia alla classe dei giovanotti con grande zelo e con sua viva soddisfazione. Se la campana suonava i segni dei santo viatico, egli era sempre pronto ad avviarsi alla chiesa e si affrettava per arrivarvi in tempo, dovendo percorrere i tre chilometri che dividono il Susambrino dalla parrocchia. Là metteva la cotta, prendeva l’ombrello ed [422] accompagnava il SS. Sacramento, qualunque fosse la distanza alla casa dell’infermo. Non si dispensava dall’assistere alle predicazioni parrocchiali, alle quali prestava tanta attenzione, che le ripeteva letteralmente ai compagni chierici con somma loro meraviglia. Il suo contegno era composto e inappuntabile, perchè conosceva l’importanza del buon esempio. Per tutto ciò era tenuto in concetto straordinario da tutti i suoi conterrazzani”.
Egli passava intanto gran parte del suo tempo col teologo Cinzano, che volevagli un bene dell’anima, e col quale aveva contratto molta famigliarità. In canonica Giovanni era pronto ad ogni servizio, mentre tutti i libri della biblioteca erano stati messi a sua disposizione. Il buon vicario, ricco di scienza filosofica, teologica e storica, coltivava sempre con amore gli studi letterari. Singolarmente versato nelle lettere latine, ne possedeva l’intiera raccolta de’ classici, e, quel che è più, li leggeva, anzi li studiava anche quando era già maturo di anni. Quest’uomo, così intelligente e dotto, tanta stima aveva del nostro Giovanni, che soleva ripetere non aver mai, dal primo istante che lo conobbe, osservato in lui alcunchè di ordinario o comune, ma sempre qualche cosa di straordinario.
A dare questa opinione di lui concorreva anzitutto quella gran padronanza, che egli aveva acquistato sopra di se stesso. Giovanni Filippello infatti ricordava che un giorno il chierico Bosco, aspettando nella sala della canonica per avere udienza dal parroco, era messo in burla da due studenti, i quali pure attendevano per essere introdotti ed avere certe carte. Esortato a difendersi e a far stare a segno que’ due insolentelli, rispose: Lasciale che si divertano: sono giovani e d’altronde i loro scherzi non mi fanno male. Aggiunge il Prof. Francesco Bertagna: “Giovanni Bosco faceva ripetizione più volte alla [423] settimana a cinque o sei giovani studenti di Castelnuovo, i quali venivano a lui al Susambrino alcuni in gruppo, altri separatamente e in ore diverse, gli uni per esercitarsi nelle materie studiate nell’anno antecedente, gli altri per essere preparati a percorrere il nuovo corso, al quale erano stati promossi. Alcuni de’ loro parenti offrivangli una piccola somma mensile, onde provvedevasi del necessario per andare decentemente vestito. Altri ricevevano ripetizione per amicizia o per carità, senza dargli compenso di sorta. Ma la prima lezione era quella dell’amore di Dio e dell’obbedienza a’ suoi comandamenti, e non finiva mai la scuola senza esortarli alla preghiera, al timor del Signore ed a fuggire il peccato e le occasioni di peccare”.
Finchè non fu sacerdote, ogni giorno il chierico Giovanni Bosco soleva ascendere la cima della vigna proprietà Turco, nella regione detta Renenta, e passarvi molte ore della giornata all’ombra degli alberi che la incoronavano. Quivi si dedicava a quegli studi, cui non avea potuto attendere nel corso dell’anno scolastico: specialmente allo studio del Calmet, storia del Vecchio e del Nuovo Testamento, della geografia dei Luoghi Santi e de’ principii della lingua ebraica, acquistandone sufficienti cognizioni. Ancora nel 1884, ricordavasi dello studio fatto su questa lingua, e noi lo abbiamo udito in Roma, con nostro estremo stupore, entrar in quistione, con un sacerdote professore di lingua ebraica, sul valore grammaticale e sulla spiegazione di certe frasi originali dei profeti, facendo confronti coi testi paralleli di varii libri della Bibbia. Si occupava eziandio della traduzione dei Nuovo Testamento dal greco ed incominciava a prepararsi alcune prediche. Prevedendo il bisogno di conoscere eziandio le lingue moderne, si die’ in questo tempo ad imparare la lingua francese. Dopo il latino e l’italiano, egli ebbe sempre una predilezione speciale per le [424] tre lingue ebraica, greca, francese. Più volte abbiam sentito D. Bosco dire: – I miei studii li ho fatti nella vigna di Giuseppe Turco alla Renenta. E il fine de’ suoi studi era di rendersi degno della sua vocazione ed abilitarsi alla istruzione ed educazione della gioventù. Difatti un giorno avvicinatosi a Giuseppe Turco, col quale era stretto da grande amicizia, mentre lavorava intorno alle viti, questi prese a dirgli: – Ora sei chierico, ben presto sarai prete: e poi che cosa farai? – Giovanni rispose: – Non ho inclinazione a fare il parroco e neppure il vicecurato; ma mi piacerebbe raccogliere intorno a me giovani poveri ed abbandonati per educarli cristianamente ed istruirli. – Incontratolo un altro giorno, gli confidò come egli avesse fatto un sogno, dal quale aveva inteso come col volgere degli anni egli si sarebbe stabilito in un certo luogo, dove avrebbe raccolto un gran numero di giovanetti per istruirli nella via della salute. Non spiegò il luogo, ma sembra che alludesse a quanto raccontò per la prima volta nel 1858 a’ suoi figliuoli dell’Oratorio, fra i quali eravi Cagliero, Rua, Francesia ed altri. Aveva visto la valle sottostante alla cascina del Susambrino convertirsi in una grande città, nelle cui strade e piazze scorrevano turbe di fanciulli schiamazzando, giuocando e bestemmiando. Siccome egli aveva in grande orrore la bestemmia ed era di un carattere pronto e vivace, si avvicinò a questi ragazzi, sgridandoli perchè bestemmiavano e minacciandoli se non avessero cessato; ma non desistendo essi dal vociare orribili insulti contro Dio e la Madonna Santissima, Giovanni prese a percuoterli. Senonchè gli altri reagirono e, correndogli sopra, lo tempestarono di pugni. Egli si diede alla fuga; ma in quella ecco venirgli incontro un Personaggio, che gli intimò di fermarsi e di ritornare a quei monelli e persuaderli a state buoni e a, [425] non fare il male. Giovanni obbiettò le percosse avute e il peggio che gli sarebbe toccato, se fosse ritornato sopra i suoi passi. Allora quel Personaggio lo presentò ad una nobilissima Signora, che si faceva innanzi, e gli disse: Questa è mia Madre; consígliati con lei. La Signora, fissandolo con uno sguardo pieno di bontà così parlò: Se vuoi guadagnarti questi monelli, non devi affrontarli colle percosse, ma prenderli colla dolcezza e colla persuasione. E allora, come nel primo sogno, vide i giovani trasformati in belve e poi in pecorelle e in agnelli, ai quali egli prese a far da pastore per ordine di quella Signora. Era il pensiero del Profeta Isaia tradotto in visione: “Daranno gloria a me le bestie selvatiche, i dragoni, gli struzzoli (mutati in figliuoli di Abramo). Questo popolo l’ho formato per me; egli annunzierà le mie laudi (la mia possanza, la mia misericordia)”[100].
Forse è questa volta che egli vide l’Oratorio con tutti i caseggiati, che erano pronti ad accoglierlo coi suoi biricchini. Infatti D. Bosio, nativo di Castagnole, parroco di Levone Canavese, compagno di D. Bosco nel seminario di Chieri, venuto per la prima volta all’Oratorio nel 1890, arrivato in mezzo al cortile, circondato dai membri del Capitolo superiore della Pia Società di S. Francesco di Sales, girando lo sguardo attorno ed osservando i molteplici edifizii, esclamò: Di tutto ciò, che ora vedo qui, nulla mi riesce nuovo. D. Bosco in seminario mi aveva già descritto tutto, come se avesse veduto coi propri occhi ciò che narrava e come io vedo adesso con mirabile esattezza esistere. E parlando si impossessava di lui una tenerezza profonda al rammentare V. Martini [426] il compagno e l’amico, Eziandio il teologo Cinzano attestava a D. Gioachino Berto e ad altri avergli detto con sicurezza il giovane Bosco, quando era ancor chierico, che egli in tempo avvenire avrebbe avuto dei preti, dei chierici, dei giovani studenti, dei giovani operai ed una bella musica.
A questo punto non possiamo far a meno di fissare lo sguardo sul progressivo e razionale succedersi dei varii sorprendenti sogni. Ai 9 anni Giovanni Bosco viene a conoscere la grandiosa missione, che a lui sarà affidata; ai 16 ode la promessa dei mezzi materiali, indispensabili per albergare e nutrire innumerevoli giovani; ai 19 un imperioso, comando gli fa intendere non esser libero di rifiutare la missione affidatagli; ai 21 gli è palesata la classe de’ giovani, della quale dovrà specialmente curare il bene spirituale; ai 22, gli è additata una grande città, Torino, nella quale dovrà dar principio alle sue apostoliche fatiche e alle sue fondazioni. E qui, come vedremo, non si arresteranno queste misteriose indicazioni, ma continueranno ad intervalli fino che sia compiuta l’opera di Dio. Si dovran dir forse questi sogni mere combinazioni di fantasia? E una prova che Giovanni Bosco era accetto a Dio e che la protezione della Vergine SS. non gli mancava fin da quei tempi, in qualsivoglia, occasione a Lei ricorresse, è il fatto seguente. La regione di Castelnuovo era sovente devastata dalla tempesta, che per dieci anni di seguito aveva distrutto interamente il raccolto dell’uva. La famiglia Turco se ne lamentò col chierico Bosco ed egli rispose con umile sicurezza: – Finchè io sarò qui alla Renenta non temete: la tempesta non cadrà più: preghiamo solamente la Madonna ed Ella ci proteggerà. – E infatti dà quel punto per un certo numero di anni più non cadde la grandine. Sembrava che la presenza di Giovanni in quei luoghi portasse benedizione. Così affermava Giuseppe Turco.
CAPO XLVIII.
Prima predica di Giovanni ad Alfiano – Sua passeggiata a Cinzano per visitare Comollo – Sua politica per far apparecchiare un pranzo – Novelle prove di sua memoria.
MENTRE Giovanni passava così felicemente le sue vacanze, lavorando materialmente, studiando, facendo ripetizione e radunando giovanetti alla domenica, fu invitato a tenere il discorso del Rosario nel vicino paese di Alfiano. Col permesso e coll’assistenza del suo caro prevosto accettò l’invito e per la prima volta salì il pulpito di quel paese, fortunato di poter consacrare le primizie della sua predicazione a quella Signora, che più volte gli si era manifestata Madre e guida. Il suo primo argomento fu adunque quella potentissima preghiera in onore di Maria SS., della quale sarà apostolo infaticabile il sapientissimo Leone XIII, sicuro che con essa si otterrà dal Signore la restaurazione sociale. Non a caso facciamo questa riflessione: il lettore ne intenderà lo scopo dallo svolgimento del nostro racconto.
Comollo intanto non dimenticava l’amico e gli scriveva:”Ho già passato circa due mesi di vacanze, i quali anche con questo gran caldo mi hanno fatto assai bene per la corporale sanità. Ho già studiato quegli avanzi di logica e di etica, che si sono omessi nel decorso dell’anno; leggerei volentieri la storia sacra di Giuseppe Flavio, che mi suggerisci: [428] ma ho già cominciato a leggere la storia delle eresie, onde verrà a mancarmi il tempo. Spero che ciò farò un altr’anno. Del resto la mia stanza è tuttora l’ameno paradiso terrestre; qui dentro rido, salto, studio, leggo, canto, e non ci vorrebbe altro che te per far la battuta. A mensa, in ricreazione, a passeggio sempre mi godo la compagnia del caro mio zio, il quale, sebbene cadente pegli anni, è sempre giulivo e lepido, e mi racconta ognor cose una più bella dell’altra, che mi contentano all’estremo. Ti attendo pel tempo stabilito, stammi allegro; e se mi vuoi bene, prega il Signore per me”.
Il chierico Bosco non mancò di accondiscendere all’invito di Comollo. Non era mai stato a Cinzano, e vi giunse in compagnia del chierico. Garigliano, del giudice, del segretario comunale e del geometra G. B. Paccotti, coi quali era in intimità. Questi avevano stabilito di passare allegramente una giornata in casa del prevosto. All’arrivo della comitiva, gli amici, che ivi abitavano, vennero ad annunziare come il parroco col nipote fossero andati in quel giorno alla solita mensile conferenza morale, che tenevasi in Sciolze, dal vicario foraneo. Non erano dunque aspettati. Che fare? Mandare a monte la partita? È ciò che non si voleva. Il parroco di Cinzano, zio di Comollo, era un venerando vecchio di ottanta anni, il quale, andato a Chieri e a Castelnuovo, più volte aveva invitato il nostro Giovanni a venire a visitarlo in Cinzano, aggiungendo che facevalo padrone di casa sua. Ma la fantesca, che con piena padronanza maneggiava l’azienda domestica, da brava economa e fedele fino allo scrupolo, ora non avrebbe certamente aperta la porta di casa e dato da pranzo al primo venuto e tanto meno ad una comitiva di gente allegra, senza ordini precisi. Giovanni capì doversi aprire trattative diplomatiche per riuscire nell’intento; ciononostante assicurò gli amici della vittoria. [429] Non conoscendo la fantesca, chiese notizie del suo nome e del suo naturale; poi senz’altro si avviò col solo Garigliano alla canonica. La fantesca, che non lo aveva mai visto, lo accolse freddamente, annunziandogli che il prevosto non c’era. – Mi rincresce molto, rispose Giovanni con quella grazia e candore che gli era proprio: siamo buoni amici e lo conosco da un pezzo. Ci fosse almeno la Sig. Maddalena, che mi fu detto essere persona così cortese e bene educata; ma essa avrà accompagnato il prevosto a Sciolze. È impossibile che quel buon vecchio vada fuori di casa, senza colei che sa consigliarlo così opportunamente in ogni circostanza, Son passato anche per riverire dessa, la signora Maddalena; ma se non ci fosse, pazienza; passerò a riverirla un’altra volta. Lei intanto appena la vedrà, le presenti tanti rispetti la parte mia. – La buona fantesca, così lusingata, sorrideva modestamente, e poi interrompendolo: – Maddalena non è andata a Sciolze.
– Non è andata? possibile? Eppure a quello che mi hanno fatto supporre
– Le torno a dire che Maddalena non è andata… perchè… Maddalena sono io.
– Oh! lei! la signora padrona?
– Che padrona! Io sono una povera serva.
– Non dica questo; se non fosse per lei, che cosa sarebbe di questo povero parroco? Sappiamo che è lei quella che accudisce ogni sua cosa, che governa la casa, che dirige l’economia domestica. D. Comollo non ha parole per lodarsi di lei, che è così attenta e premurosa in tutto ciò che può fargli piacere o recargli giovamento.
– Tutta bontà sua! faccio quel poco che posso… esclamò Maddalena, vinta da quelle lodi realmente meritate; del resto mi rincresce che, mentre lei è venuto, il parroco [430] non sia in casa: ma prima di notte son certa che sarà di ritorno.
– Rincresce anche a me: avevo fatto conto di passare la giornata con lui…. ma quando è così rassegnamoci. Io vado, ma ritornerò presto. Intanto sono ben contento d’aver potuto riverire la signora Maddalena.
– Ma dove vuole andare? Lei ha forse già pranzato?
– Io no; ma lasci fare; mi aggiusterò.
– Ma sa dove andare?
– Per dire la verità è quello che non saprei.
– Ma dunque perchè fa complimenti? Si accomodi, entri…
– Ma non essendoci il padrone…
– Se non c’è il prevosto, ci sono io… Il prevosto è generoso e non se l’avrà a male…. Venga avanti.
– Ma lei ha troppo da fare, non voglio darle tanto incomodo…
– No, no: troppo grande piacere sarà il mio nel darle un po’ di pranzo alla buona. Lasci fare a me.
– Ma, a dir la verità, non sono solo: ho anche cinque o sei amici nel paese.
– Li faccia venire essi pure.
– Ma poi?
– Non dubiti, che ce ne sarà per tutti.
– Lo vedo che è proprio vero quello che tutti dicono, lei esser molto brava; ma noti che i miei amici sono persone di un certo riguardo…
– Vedrà, vedrà che resteranno contenti.
– Ma le chiavi della cantina il parroco le avrà chiuse in sua stanza.
– Le chiavi della cantina? Vorrei veder questa! Tutto, tutto è in mano mia. – E battendo colle mani le chiavi che [431] aveva attaccate al grembiale: Sono qui sa! Crede ella che io voglia dar loro dell’acqua da bere?
Maddalena andò subito a preparare il pranzo, e Giovanni mandò a chiamare i suoi amici, i quali tosto vennero e tutti si assisero a tavola. Non poteva desiderarsi pranzo più delicato ed abbondante. Furono pure sturate bottiglie di vino prelibato. Giovanni ne era alquanto impensierito, perchè non aveva previsto tale imbandigione, ma non era caso di far rimostranze. Viva la padrona! Viva Maddalena! gridavano i convitati. Per quella buona donna fu un giorno di trionfo.
Tuttavia i convitati non tardarono ad accorgersi che la burla aveva passato un po’ il segno. Maddalena si affrettò a sparecchiare, gli amici ritornarono alle loro case, decisi di non dir parola, che potesse compromettere la fantesca. Intanto giungevano da Sciolze il prevosto col nipote, che fecero mille feste a Giovanni, il quale, nulla disse dei pranzo nè allora, nè poi finchè visse il suo giovane amico; e solo dopo la sua morte narrò tutto al prevosto, che fece le più grasse risa e ricordò il versicolo dell’Ecclesiastico; “L’amico costante sarà come tuo eguale e porrà le mani liberamente nelle cose della tua casa”[101].
Questa piccola avventura, che apprendemmo dallo stesso D. Bosco, ci fa conoscere come fin d’allora avesse una singolare attitudine nel piegare l’altrui volontà alla propria. La sua affabilità, unita ad una profonda conoscenza del cuore umano, sapeva vincere gli animi avversi, ostinati, scoraggiati o capricciosi. Quando si avvedeva che le ragioni di convenienza, di carità o di dovere a nulla avrebbero [432] approdato, egli, con arte finissima e senz’ombra di adulazione o di menzogna, facevasi alleato il loro amor proprio; e sapeva solleticare in modo questa corda, da farla rispondere a quella nota che aveva in mente. Una sua parola di lode, un ricordo onorevole, un atto e un motto di stima, di confidenza, di fiducia, di rispetto, faceva la maggior parte delle volte sparire ogni difficoltà od avversione, riuscendo, egli così ad ottenere dalle persone di casa o dalle estranee quanto desiderava. Ci vorrebbero più volumi a descrivere queste scene ora lepide, ora commoventi e talora perfino, eroiche. Infatti, vinte le ripugnanze, purificate le intenzioni, quanti generosi abbiamo noi veduti far atti duraturi, nobilissimi di abnegazione e di sacrifizio, dei quali nessuno li avrebbe creduti capaci. Ed erano le sante industrie di D. Bosco, che producevano simili portenti. “Le labbra del giusto, stillano cose gradevoli. Il flauto e il saltero fanno soave concerto, ma l’uno e l’altro è superato da una lingua soave”[102].
Giovanni allora si fermò alcuni giorni a Cinzano, ammirando sempre più l’angelica condotta, la frequenza ai Sacramenti, l’assiduità alle sacre funzioni di Comollo. Aveva le sue stesse, inclinazioni, e quindi puntuale nel far il catechismo ai ragazzi in chiesa ed anche per le vie ogni volta gli avveniva d’incontrarne. I due amici parlarono lungamente di cose di pietà, dei loro progetti e de’ loro studii. E Comollo fu meravigliato di una prova, che Giovanni gli diede della potenza di sua memoria, sicchè dovette concludere esservi pochi al mondo arricchiti di simile dono dal Signore. Aveva letti una volta sola i sette volumi della storia di Giuseppe Flavio, ed ora, toltili dalla biblioteca del prevosto, li porgeva a Comollo [433] dicendogli: – Chiedimi pure quale capitolo vuoi che io reciti, purchè mi dica il titolo. – Comollo lo contentò, e quel capo fu recitato con mirabile prestezza dalle prime parole all’ultime. Dopo il primo capo, ne recitò altri ancora. – Adesso, proseguì Giovanni, domandami qualunque fatto ti piaccia scegliere. Comollo guardò l’indice e chiese il primo fatto che gli cadde sott’occhio: Giovanni lo sapeva così a mente, che non ne sbagliò una sola frase. – Ora, disse ancora Giovanni, apri pure quei libri a qual pagina più ti aggrada e dimmi le prime parole della prima riga, eziandio se il periodo fosse a metà. E così faceva Comollo, e Giovanni recitava come se avesse la pagina sotto gli occhi. Finalmente, accennato da Comollo un fatto, sapeva in quale pagina si trovasse e in quale punto di questo incominciasse il testo. Questa prova aveala già data al suo prevosto il teologo Cinzano, il quale ne faceva fede più tardi ai giovani dell’Oratorio, quando andavano a visitarlo nel tempo delle passeggiate.
Di questa sua portentosa memoria abbiamo altre prove e senza numero. Mi ricordo che D. Bosco a Lanzo verso il 1870, scrivendo l’Orfanella degli Apennini, mandò un suo prete a cercare un volume determinato del Bercastel, e poco più e poco meno indicogli la facciata, perchè trovasse il racconto della solitaria dei Pirenei. Si cercò I’ opera, si prese il volume e si trovò subito quel che D. Bosco voleva. E notare che non aveva più letto riga di questo libro dacchè era uscito dal seminario.
Egli conosceva a menadito un’infinità di libri. I suoi preti ebbero da ciò un grande aiuto e risparmio immenso di tempo, poichè dovendo far prediche, panegirici, prepararsi ad esami, scrivere libri, ricorrevano a lui, il quale indicava sempre cinque o sei volumi, accennava qual fosse l’autore più stimato, [434] precisava il modo, coi quale dovevano avvantaggiarsene. Nel 1865 dovè D. Cagliero surrogare un predicatore, che, preso l’impegno, non poteva recarsi fuori di città a fare il panegirico di un Santo, del quale il nome era poco conosciuto. D. Cagliero ne ignorava interamente le gesta. D. Bosco era lontano da Torino. La predica doveva farsi prima che D. Bosco fosse di ritorno. D. Cagliero, per cavarsi d’impiccio in quelle strettezze di tempo, scrive un biglietto a D. Bosco, il quale risponde a volta di corriere, indicando volume e pagina dei Bollandisti. D. Cagliero, benchè assuefatto a queste meraviglie, appena ricevuto il biglietto, lo legge ad un compagno, e con esso sale in biblioteca per verificare con quel testimonio la giustezza dell’indicazione. Prende il volume, cerca la pagina, ed ecco le notizie desiderate.
CAPO XLIX.
Giovialità perenne di Giovanni Bosco – Cose da nulla – Una disciplina ridicola – Un cantore che perde gli occhiali – L’imbroglio di un sindaco – Adempimento di promessa.
LA VITA di Giovanni Bosco fu sempre vita di pace e di allegrezza. Anche in mezzo alle più dure prove, eziandio quando fu sacerdote, se talora parve per alcuni istanti velarsi, l’animo suo gioviale manifestavasi subito con motti spiritosi o racconti ameni. Non passò giorno, si può dire, senza che con questi destasse l’ilarità o nelle pubbliche radunanze, e nelle parlate agli allievi, o nei crocchi che formavano intorno a lui i suoi salesiani, i suoi giovanetti, nei viaggi, nelle case e nei palagi dei cittadini, insomma ovunque apparisse. Essendo egli attento osservatore di ogni cosa, sapeva di fatti graziosi una raccolta inesauribile. La coscienza tranquilla ed il pieno abbandono nella Provvidenza divina impedivagli gli scoraggiamenti e le tristezze. Ovunque recavasi, con sè portava la gioia più viva, il riso più cordiale. E di ciò erasi fatto regola costante, secondo l’insegnamento dell’Ecclesiastico:
“Non lasciare l’anima tua in preda alla tristezza e non affliggere te stesso co’ tuoi pensieri. La giocondità del cuore è la vita dell’uomo; è tesoro inesausto di santità; la letizia allunga i giorni dell’uomo. Abbi compassione dell’anima tua per piacere a Dio e sii continente, (guardandoti da ciò che [436] turba il cuore); consólati nei santi doni di Dio e manda lungi da te la tristezza. Perocchè la tristezza ne ha uccisi molti, ed ella non è buona a nulla. L’invidia e l’ira abbreviano i giorni, e i sopraccapi menano la vecchiaia prima del tempo”[103]. E il cuore allegro di D. Bosco si rifletteva pur nel suo volto, come se gli risuonasse sempre all’orecchio l’esortazione di S. Paolo: “State allegri sempre nel Signore: lo dico per la seconda volta, state allegri”[104].
Di quando in quando interrompiamo il nostro racconto per ricordare alcuni fatterelli, acciocchè resti sempre più di, mostrata questa sua vena inesauribile di buon umore per rallegrare le brigate. Si dirà da qualche serio filosofo essere queste cose da nulla e che si potevano ommettere. A dir il vero, a noi pure venne questa tentazione; ma poi, riflettendo che una proposizione senza prove val nulla e che noi scriviamo senza pretensioni di sorta, eccettuata quella di essere veritieri, e per i confratelli salesiani, ai quali torna gradita ogni piccola cosa che riguardi il padre loro, tiriamo avanti e le narriamo press’a poco colle stesse parole, colle quali le udimmo raccontare da D. Bosco.
Eransi radunati presso il prevosto D. Cinzano i parroci della vicaria e in mezzo ad essi sedeva il chierico Bosco. A un tratto un di que’ sacerdoti chiese al chierico se avesse, secondo il solito, qualche amenità da raccontare, specialmente sulla vita del seminario. Giovanni per buona pezza sembrò concentrato in profondi pensieri; quindi, cedendo alle insistenze che gli veniano fatte, con tutta serietà prese a parlare delle virtù eroiche, nelle quali si esercitavano i seminaristi, [437] passando in ultimo a portarne le prove. Erano finiti i santi spirituali esercizii, e due chierici, presi da insolito fervore, avevano fatto proponimento di aiutarsi a vicenda nell’infliggersi più volte alla settimana una salutare disciplina. La prima volta che convennero per questa pratica di penitenza, l’uno di essi si gettò il mantello giù dalle spalle e l’altro afferrò il flagello e gli diede un primo colpo, ma leggermente. – Più forte, disse l’altro. – E ricevette un secondo colpo, ma anche questo molto leggiero. – Più forte ancora! – esclamò il paziente. E allora il compagno gli scaricò con tutte le sue forze un colpo tale, che le corde gli solcarono le spalle e vi lasciarono striscie violacee. Un ahi! formidabile rispose a quel colpo, ed il percosso salito in rabbia: – È la maniera di trattarmi? gridò; sei un malcreato. A me quest’insulto! replicò l’altro e giù una staffilata. Quindi si accapigliarono, si batterono, corsero i compagni a dividerli e così finì quella prova disciplinare.
I parroci, che dall’esordio non avevano potuto prevedere la conclusione, tanto più che Giovanni non rideva mai quando diceva delle facezie, ne ebbero d’avanzo per sentirsi indolenziti i polmoni ed i fianchi.
- Bosco ripeteva spesso il racconto di questo aneddoto per trarne la morale: che, cioè tutto che è contrario alle regole, se non è suggerito da una necessità o convenienza morale, e di più colla licenza dei superiori, è disordine e porta con sè conseguenze molto disastrose.
A Castelnuovo in un giorno di festa solenne celebrava la santa Messa il parroco teologo Cinzano. Dirigeva l’orchestra, composta di pochi cantori, un cotale soprannominato Barba Domenico, il quale aveva ottima voce, ma conosceva la musica solo per pratica e nulla per teoria. Ciò non ostante squadernava i fogli di musica e so li ponea dinanzi con una sicuméra [438] da professore consumato. Ci tenea ad essere creduto cantore di vaglia e su questa sua abilità non soffriva che alcuno scherzasse. Quel giorno, inforcati al solito gli occhiali, inchinato per un istante sul parapetto dell’orchestra, perchè la gente in chiesa vedesse come e qualmente egli in persona era pronto a gettar fuori le armoniose sue note, girato uno sguardo con sussiego al compagni, incomincia a trinciar l’aria colla mano per segnare le prime battute. Kyrie, intuona; ma un movimento da lui fatto con troppo entusiasmo gli fa cadere gli occhiali dal naso. I vicini a stento frenano le risa. Kyrie, prosegue Barba Domenico, e sottovoce dice a chi gli sta a fianco: – Prendi gli occhiali. – Quegli, cui era rivolto il comando, si curva verso terra, ma si approfitta di quell’istante per lasciar libero il freno alle risa. – Eleison! continua a cantare Domenico. – E fa presto! esclama rapidamente e impazientito tra una nota e l’altra a chi quasi inginocchiato si dibatteva per le convulsioni del ridere. Ebbe finalmente gli occhiali, se li ricacciò stizzito sul naso e schiacciando un contacc tra un Kyrie ed un eleison, proseguì la sua musica. Ci vollero sforzi erculei, perchè gli altri, che erano sull’orchestra, si rimettessero in tono e proseguissero il loro canto. Giovanni, che ogni cosa avea osservato, pel momento fece le viste di nulla e si mantenne serio; ma, andato a pranzo col parroco prese a descrivere quella scena in modo così ameno, che il teologo Cinzano ruppe in un riso infrenabile. Gli dolevano i fianchi, si comprimeva la milza: – Basta, basta! – si sforzava di dire, fra un singhiozzo e l’altro. Ma non ci fu verso che potesse comporsi e dovette lasciare di cibarsi. Ed ogni volta poi che il buon parroco ricordava questa commedia, non potea più far nulla, tanto ne veniva distratto, e dovette proibire assolutamente a Giovanni di fargliene memoria, perchè il troppo ridere cagionavagli danno alla salute. [439] Un’altra volta in quegli anni il chierico Bosco fu chiamato dal parroco di un paese vicino, per assistere alle sacre funzioni, che colà doveva tenere il Vescovo d’Asti Monsignor Michele Amatore Lobetti. Il sindaco di quel paese, uomo di poca levatura e di nessun studio, avea però capito non doversi lasciar passare quell’occasione senza farsi un po’ di onore. Quindi si rivolse al chierico Bosco, perchè gli scrivesse un sonetto da leggersi al Vescovo. Giovanni glielo scrisse, glielo recò ed esortollo a leggerlo bene prima di esporsi al pubblico. – Lascia fare a me! vedrai! – rispose il buon uomo. Venne il Vescovo; e il clero, il municipio, la popolazione fu a riceverlo all’entrata del paese. Benchè il sindaco, si fosse messo il vestito dei giorni di festa e si trovasse in prima linea, il Vescovo, non conoscendolo, si fece a complimentare il parroco, che davagli il benvenuto, volgendo le spalle al rappresentante della comunità. Costui manifestava la sua impazienza da tutte le rughe del volto e dai gesti del capo, e trovando poco onorevole all’alta sua dignità essere messo da banda, preso il lembo della cappa vescovile e tirandola leggermente.- Eccellenza, disse, qui c’è il sindaco! – Il Vescovo si rivolse a lui: – Oh! e dov’è? Sono io! – Signor sindaco! Perdoni. Non l’avevo riconosciuto! – Se permette, ho qualche cosa da leggere – replicò con un inchino il sindaco. Volentieri, sentiamo! – rispose il Vescovo. Era stata preparata una specie di cappella con pali e frondi e quivi il Vescovo fu condotto ad assidersi in mezzo al clero ed agli altri maggiorenti del paese. Il sindaco era rimasto in piedi nel mezzo e il popolo silenzioso gli facea larga siepe dietro le spalle. Con aria magistrale si mise gli occhiali, si soffiò il naso, mise la mano in una saccoccia, ma non trovò la carta del sonetto. Fruga e rifruga nelle varie tasche, e nulla. Il suo imbarazzo [440] incominciava a destare l’ilarità del rispettabile pubblico e dell’inclita guarnigione. Il sindaco volgeva gli occhi attorno cercando del chierico Bosco, il quale erasi ritirato in un angolo dietro al clero, e con un gesto espressivo gli disse – Che cosa facciamo adesso? – Mentre si attendeva l’arrivo di Monsignore, il povero uomo era stato in disparte compitando la sua lezione, e allo sparo dei mortaretti, alle grida di evviva, senza badare avea posta la carta sopra il tavolino di quella cappella di frasche ed era corso per trovarsi fra i primi. Ed ora si dimenticava di questa circostanza. Giovanni però, che si trovava poco distante dal tavolino, avendo in quell’istante veduto il suo foglio, andò a prenderlo e glielo porse. Respirò il sindaco: prese un’aria imponente, sputò per terra, si forbì la bocca ed incominciò. Ma per sua sventura il foglio era doppio: il sonetto era scritto nella facciata interna a sinistra e nella facciata interna di destra la firma del lettore. Tutto era di mano del chierico Bosco. Ma il sindaco, avendo piegato il foglio sicchè combaciassero le due facciate esterne, ora avealo preso in mano in modo che avea sottocchi la sola firma; quindi lesse ad alta voce: – Suo umilissimo ed ubbidientissimo servo sindaco di B….. e poscia nome e cognome. Fin qui la cosa passava ancora, ma non potè più andare oltre; poichè il sindaco, non pensando a rivolgere la carta, esclamò: – C’è più niente! Bosco, Bosco, vien qui: tu che l’hai fatto, dimmi dove debbo leggere. – Si può immaginare il bisbiglio e le risa del popolo. Monsignore stentava a serbare il suo contegno, e il parroco senz’altro alzatosi recitò un suo breve complimento e tutti si avviarono alla chiesa. A mensa la figura del povero sindaco assente tenne viva l’allegria dei convitati. Fu chiamato il chierico Bosco, e gli fu chiesto spiegazione della cosa. Al suo racconto Monsignore ed i parroci risero tanto, da affermare [441] che in vita loro non aveano mai assistito a fatto così lepido. Il sindaco però da quel punto prese a fare il broncio a Giovanni, accusandolo d’essere la causa di quella sua brutta figura.
Così Giovanni passava lieti e tranquilli que’ giorni, non disturbati in Piemonte, per la protezione di Maria SS., dal morbo asiatico, che mieteva in quell’anno ben 5500 vite a Roma e 200,000 nel regno delle due Sicilie. Per questo segnalato favore il Municipio di Torino riconoscente scioglieva un suo voto, erigendo sulla piazzetta di fianco al santuario della Consolata una colonna di granito, sostenente la statua marmorea della Vergine Santa.
Frattanto le vacanze volgevano al loro termine e Giovanni per mantenere una promessa fatta, recavasi a visitare la famiglia Moglia. Il signor Luigi Moglia sapeva che mamma Margherita era stretta d’alloggio, e però si era fatto promettere da Giovanni che non avrebbe mancato di venire molte volte a visitarlo. E Giovanni mantenne la parola, e tutti gli anni nelle vacanze compariva in mezzo a quella buona famiglia, dimorandovi qualche settimana e una volta circa due mesi, intrattenendosi volentieri coi giovanetti di casa e del vicinato, istruendoli nel catechismo e dando a ciascuno i consigli più opportuni secondo l’età, le tendenze o i difetti che in essi scopriva. Era solito ovunque andasse, e così alla Moglia, distribuire immagini e medaglie ai ragazzi, ma non ne donava mai alle figlie, non volendo che gli venissero intorno a far ressa. Giorgio Moglia, che dormiva nella stessa stanza con Giovanni, narrava che il buon chierico, prima di mettersi a riposo, lo faceva pregare e lo avvisava soavemente se in lui avesse scorto qualche azione o parola che meritasse riprensione. Lo esortava sovente all’amore, rispetto ed ubbidienza dovuta ai genitori, ed avendogli quegli narrato come un giovane del [442] paese avesse maltrattato suo padre, rispose: – Colui, che perde il rispetto al padre o alla madre, si attira sul capo la maledizione di Dio. – Siccome gli pareva che in lui avrebbe potuto manifestarsi una vocazione ecclesiastica, così parecchie volte gli diceva: – La migliore opera che si possa fare al mondo è quella di trarre le anime perdute sulla buona strada, alla virtù, a Dio. – Quest’anno il Sig. Luigi gli comperava un cappello nuovo, perocchè quello donatogli dal Cav. Pescarmona era divenuto troppo logoro: e la signora Dorotea, riguardandolo come suo figliuolo, lo regalava di alcune paia di calze che essa stessa aveva fatte, dono che rinnovava ogni anno. In quella cascina il nome di Bosco si ripeteva in tutte le conversazioni. Sapevasi che in seminario egli si faceva onore ed era molto amato e stimato dai superiori; ed il parroco di Moncucco Teol. Cottino, che recavasi qualche volta a visitare quei proprietari, loro portava di sue notizie, godendo, del grande piacere che ne provavano. Giovanni a sua volta non lasciava occasione per esternare il suo affetto e la sua riconoscenza verso di quella famiglia, tanto che lo stesso maestro D. Nicolao Moglia, beneficiato in Castelnuovo, ebbe a dire di rimanere incantato dall’affezione grande che gli dimostrava il suo antico discepolo.
CAPO L.
Il primo corso di teologia – Altro attestato in lode di Giovanni – Suo amore per la storia ecclesiastica e per il Papa – Accademia letteraria fra i seminaristi – Giovanni Bosco infermiere – Le vacanze – Visite degli amici – Giovanni predica ancora ad Alfiano – Sostituisce il predicatore mancato improvvisamente a Cinzano ed a Pecetto – Altro discorso a Capriglio – Umile giudizio sulle sue prediche – Si reca nuovamente a Cinzano – Dialogo con Luigi Comollo – Presagi di morte – Vocazioni ecclesiastiche.
SUL principio dell’anno scolastico 1837- 38, il chierico Giovanni Bosco entrava nel primo corso di teologia. Professore della conferenza teologica del mattino era il teologo D. Prialis, e quello della sera il teologo Arduino di Carignano, di poi canonico, prevosto e vicario foraneo della collegiata di Giaveno.
All’esame semestrale di quest’anno anche Luigi Comollo conseguiva il premio di sessanta lire, che si suole assegnare a chi più si distingue nello studio e nella pietà. “Finchè Dio conservò in vita questo incomparabile compagno, scrive D. Bosco, gli fui sempre in, intima relazione. Io vedeva in lui un santo giovanetto; lo amava per le sue rare virtù; e quando ero con lui mi sforzava di imitarlo in qualche cosa, ed egli poi amava me, perchè lo aiutava negli studii”. [444] Se è vero che l’amore o trova simili gli amici o simili li rende, possiamo argomentare come il nostro Giovanni, nutrisse almeno gli stessi sentimenti, lo stesso candore, la stessa pietà e virtù di Comollo. Ne fa testimonianza il chierico Giacomo Bosco, che apparteneva allora al secondo corso di teologia. Così egli narrava del nostro Giovanni alla presenza di D. Rua, di D. Francesia, D. Lazzero, D. Bonetti e D. Lemoyne: “Tutte le domeniche immancabilmente si accostava alla SS. Comunione. La sua umiltà era grande. Con me aveva una confidenza senza limiti, palesandomi ogni suo segreto. Nei dubbi o in qualche risoluzione già presa, prima di operare chiedeva il mio parere e poi obbediva, qualunque fosse il consiglio ricevuto. Era sempre composto nella persona, riservato negli atti, si applicava continuamente in qualche occupazione, o materiale, o intellettuale non stava mai in ozio, era esatto nell’osservanza di tutte le regole; in ricreazione non si vedeva mai correre e ridere forte, ma passeggiava solo co’ suoi pensieri o accompagnato da’ suoi fidi, intrattenendosi in utili ragionamenti; alla sera faceva crocchio con pochi fra i più studiosi; ed egli prediligeva gli studi storici ecclesiastici, pei quali aveva una attrattiva particolare. Sovente deplorava che i fatti riguardanti i Papi fossero da molti scrittori ecclesiastici trascurati, mentre erano prolissi nello scrivere le geste di personaggi secondari. Così pure si affliggeva quando le azioni di certi Pontefici erano giudicate con poca reverenza”. A questo proposito noi aggiungeremo che appena vide la luce l’opera del Rorhbacher, ne lesse con attenzione tutti i diciassette volumi. Così pure percorse la storia ecclesiastica del Salzano, esclamando che, se fosse stata data alle stampe quando era in seminario, ne avrebbe baciate una ad una le pagine, appunto perchè questo storico italiano mostra grande venerazione pei [445] Sommi Pontefici. Così egli, guidato da giusti criteri ed arricchito degli studi del Bercastel, dell’Henrion, del Fleury, del Rorhbacher, del Salzano e de’ Bollandisti, si disponeva a comporre la sua piccola storia ecclesiastica ad uso dei giovani.
Gli studi storici nulla toglievano agli studi teologici. Continuava il circolo colle dispute sulle questioni più difficili, ove esigevasi la più rigorosa precisione nei termini. Narra D. Giacomelli che il chierico Bosco era sempre attentissimo, sì da non lasciar passare inosservati non solo gli errori, ma neppure le più piccole inesattezze. Una volta un compagno avendo messo fuori durante la conversazione una proposizione azzardata sul peccato originale, Giovanni tosto lo corresse e lo ridusse al silenzio con buone ragioni. E tale prontezza nel difendere i dogmi l’ebbe sempre finchè visse, in ogni occasione, facendo meravigliare chi l udiva per la perspicacia della sua mente e la profondità del suo sapere.
Nello stesso tempo non trascurava le belle lettere. Giacomo Bosco, come egli stesso narravaci, aveva formato un’accademia, della quale il nostro Giovanni era l’anima. Si componeva di 12 o 14 seminaristi e vi si trattava di lingue, di autori classici e anche di galateo. Si tenevano le radunanze nei giorni di vacanza e in certi tempi di ricreazione. Si leggevano composizioni storiche, letterarie, in poesia ed in prosa. Finita la lettura, i compagni davano il loro giudizio sulla sostanza e sulla forma del lavoro e sul modo di porgere del lettore, specialmente quando trattavasi di una predica. Giovanni era così minuto nel correggere, che i compagni lo soprannominarono il rabbino della grammatica. Ma soprattutto in lui veniva allora notato l’estremo riserbo che usava in ciò che, riguardava, la modestia. Un giorno in quell’accademia fu letta non so quale composizione, nella quale si nominavano. [446] due volte genericamente persone di altro sesso con qualche epiteto laudatorio. Giovanni, interrogato del suo giudizio, prima rimase soprapensiero, e poi disse: – Tutto bello in questo lavoro, ma si nominano due volte le donne con espressioni, che non convengono affatto ad un chierico. – Lo scrittore di quella composizione divenne prete ed ebbe la disgrazia di farsi vecchio cattolico.
In questi esercizii e studi, l’anno passava tranquillamente. Continuando poi a prestare i suoi servigi ai compagni infermi, ciò che fece in tutto il tempo che stette in seminario, Giovanni ebbe occasione di interrogare i medici e venire così a conoscere i sintomi, lo svolgimento e le fasi di molte malattie e le cure necessarie secondo i casi, ed a provvedere e preparare eziandio i rimedi che venivano ordinati: scienza e pratica che non dovevano tornargli inutili per la sua futura missione.
Prova di questa sua scienza è il fatto seguente. Un giorno essendo venuto a visitarlo un medico, che aveva suo figlio ammalato, D. Bosco incominciò un discorso su vario genere di malattie, e interrogando il dottore chiedevagli varie spiegazioni. – Ma lei, esclamò a un tratto il medico, prima di essere prete, ha forse esercitata l’arte medica?
– Io no, rispose D. Bosco; faccio solamente alcune interrogazioni per istruirmi.
– Ma non sa che le sue interrogazioni non può farle se non chi ha studiato medicina?
Finito l’anno scolastico, Giovanni tornò presso la madre sua. Due soli erano gli amici che venivano in tempo di vacanza a casa Bosco: il chierico Giacomelli di Avigliana, il quale ivi pernottava, e più volte Luigi Comollo, che se ne ripartiva la sera ed a cui poi Giovanni più volte restituiva la visita. Frequenti erano pure le lettere che [447] si indirizzavano tra loro. Mamma Margherita, conoscendo l’importanza delle buone amicizie, faceva ogni suo potere, per apprestare loro una accoglienza cordiale e lauta. Erano quelli giorni di festa che lasciavano desiderio di ripetersi. – Voglio fare onore al mio Giovanni! – esclamava la buona madre.
Pochi giorni dopo il suo arrivo in patria, Giovanni riceveva il seguente biglietto dall’amico Comollo: “Debbo significarti un affare, che da un canto mi consola, dall’altro mi confonde. Mio zio mi diede incombenza di fare un discorso sulla gloriosa Assunzione di M. V. L’essere eccitato a parlare di questa cara Madre mi riempie di gioia il cuore. Dall’altro canto, conoscendo la mia insufficienza, veggo pur chiaro quanto io sia lungi dal saperne tessere condegnamente gli encomi. Checchè ne sia, appoggiato all’aiuto di Colei, di cui debbo favellare, mi dispongo ad ubbidire: l’ho già scritto e mediocremente studiato; lunedì sarò da te, onde l’ascolti a recitare e mi faccia le osservazioni, che stimerai a proposito, sia riguardo al gesto, sia riguardo alla materia. Raccomandami all’Angelo Custode pel buon viaggio…. Addio…”.
“Comollo fu puntuale, scrive D. Bosco nelle sue memorie, e venne a passar meco una giornata in tempo che i miei parenti erano in campagna per la mietitura. Egli mi fece dapprima leggere il discorso, che avea preparato per recitare alla prossima festa dell’Assunzione; di poi lo recitò accompagnando le parole col gesto. Dopo alcune ore di piacevole trattenimento, ci siamo accorti essere l’ora del pranzo. Eravamo soli in casa. Che fare? Alto là, disse il Comollo, io accenderò il fuoco, tu preparerai la pentola, e qualche cosa faremo cuocere. – Benissimo, risposi, ma prima andiamo a cogliere un pollastrino nell’aia e questo ci servirà di pietanza e di brodo; tale è l’intenzione di mia [448] madre. – Presto siamo riusciti a mettere le mani addosso ad un pollino; ma poi chi sentivasi di ucciderlo? Nè l’uno, nè l’altro. Per venire ad una conclusione vantaggiosa, fu deciso che il Comollo tenesse l’animale col collo sopra un tronco di legno appianato, mentre con un falcetto senza punta glielo avrei tagliato io. Fu fatto il colpo: la testa spiccata dal busto. Di che ambedue spaventati, ci siamo dati a precipitosa fuga piangendo. Sciocchi che siamo, disse di lì a poco il Comollo; il Signore ha detto di servirci delle bestie della terra pel nostro bene; perchè dunque tanta ripugnanza in questo fatto? – Senz’altra difficoltà, abbiamo raccolto quell’animale, e spennatolo e cottolo, ci servì per pranzo.
Io doveva recarmi a Cinzano per ascoltare il discorso del Comollo; ma essendo anch’io incaricato di fare il medesimo discorso ad Alfiano, vi andai il giorno dopo. Era una meraviglia l’udire le voci di encomio, che da tutte parti risuonavano sulla predica del Comollo. – Predica da santo, mi diceva taluno. – Oh! esclamava un altro, pareva un angelo da quel pulpito, tanto era modesto e franco nel ragionare. – Altri: – Che bella maniera di predicare! – Ciò dicendo, ne ripetevano alcuni i sentimenti e perfino le stesse parole, che fisse avevano ancora nella memoria. Suo zio diceva di veder l’opera di Dio, manifestata nel suo nipote. Io, che conosceva la grande timidità di Comollo, gli chiesi in qual modo fosse riuscito a predicare con tanta franchezza, ed egli mi rispose: – Sul punto di comparire alla presenza del popolo, io mi sentii mancar la forza e la voce, e le ginocchia non mi volevano più reggere. Ma tosto che Maria mi porse la mano, divenni vigoroso e forte, di maniera che incominciai il discorso e lo proseguii sino alla fine senza il menomo intoppo; questo fece Maria, non già io; sia lode a Lei. [449] Io tengo presso di me questo discorso, nel quale quantunque Comollo siasi servito di accreditati autori, nulla di meno la composizione è sua, e in essa vi si scorgono espressi tutti quei vivi affetti, di cui ardeva il suo nobile cuore per la gran Madre di Dio”.
Giovanni si era recato a Cinzano per congratularsi coll’amico del discorso fatto;, ma non aveva preveduto che in quel giorno medesimo egli avrebbe dovuto parlare dallo stesso pulpito a quella popolazione, che aveva udita il giorno innanzi la voce di Comollo. In questi termini egli continua la narrazione: “Quel giorno (16 agosto) correva la festa S. Rocco, che suole chiamarsi festino della pignatta o della cucina, perchè i parenti e gli amici sogliono approfittarne per invitare vicendevolmente i loro cari a pranzo ed a godere qualche pubblico trattenimento. In quell’occasione avvenne un episodio che dimostrò fin dove giungesse la mia audacia. All’ora del pranzo il predicatore di quella solennità non comparve. Si aspettò quasi fino all’ora di montare in pulpito non giunse. Per togliere il prevosto di Cinzano dall’impiccio io andava or dall’uno or dall’altro de’ molti parroci colà intervenuti, pregando ed insistendo che qualcheduno indirizzasse un sermoncino al numeroso popolo raccolto in chiesa. Niuno voleva acconsentire. – Ma come! io esclamava: vogliono lasciar andare via tanta gente, senza dir loro due parole? – Seccati da’ miei ripetuti inviti, mi risposero acremente: – Minchione che siete, il fare un discorso sopra S. Rocco all’improvviso non è mica come bere un bicchiere di vino; invece di importunare gli altri, fatelo voi. – A quelle parole tutti batterono le mani. Mortificato e ferito nella mia superbia, io risposi: – Non osava certamente offerirmi a tanta impresa, ma poichè tutti si rifiutano, io accetto. – Si cantò una laude sacra in chiesa per darmi alcuni [450] istanti a pensare; poi richiamando a memoria la vita del Santo che aveva già letta, montai in pulpito e feci un discorso che mi fu sempre detto essere stato il migliore di quanti avessi fatto prima e di poi”. Giuseppe Turco, che, invitato dal chierico Bosco, spesse volte lo accompagnava nei varii paesi ove andava a predicare, in questa occasione si trovò a Cinzano, ed ebbe a dire: – La predica sembrò preparata con molto studio e da persona assuefatta al pulpito e nutrita di studii profondi, sicchè destò gran stupore in tutti i parroci che si trovavano presenti.
Altro fatto simile a questo accadde a Giovanni alcun tempo dopo, in un’altra solennissima festa a Pecetto. Ce lo narrò il prevosto di Castelnuovo, D. Antonio Cinzano. All’ora del vespro, non era ancora comparso il panegirista colto da improvvisa malattia. Nessuno de’ sacerdoti presenti volle sostituirlo, dicendo mancar loro il tempo necessario a prepararsi e non osare parlare al pubblico così all’improvviso. Il parroco disse allora al chierico Bosco: – Andate voi! Giovanni chiese allora un breviario, lesse le lezioni del giorno, salì in pulpito e soddisfece così pienamente la popolazione, che alcuni degli uditori, parlando all’indomani col parroco di Castelnuovo, decantavano la bellezza del discorso e l’abilità del predicatore.
E D. Bosco quale giudizio dava di queste sue prediche? Egli, che esaltava alle stelle il discorso di Comollo, così scrive di sè: “Dopo il primo anno di teologia, predicai ancora sopra la Natività di Maria in Capriglio. Non so quale ne sia stato il frutto. Da tutte parti però era applaudito, sicchè la vanagloria m’andò guidando, finchè ne fui disingannato, come segue. Un giorno, dopo la detta predica sulla nascita di Maria, interrogai uno, che pareva de’ più intelligenti, sopra la predica, di cui faceva elogi sperticati, e mi rispose: [451]
– La sua predica fu sopra le anime del Purgatorio; mentre io avea predicato sopra le glorie di Maria. Ad Alfiano ho anche voluto richiedere il parere del parroco, persona di molta pietà e dottrina, di nome Giuseppe Pelato, e lo pregai a dirmi il suo parere intorno alla mia predica. – La vostra predica, mi rispose, fu assai bella, ordinata, esposta con buona lingua, con pensieri scritturali, e continuando così potete riuscire nella predicazione.
– Il popolo avrà capito?
– Poco: avranno capito il mio fratello prete, io e pochissimi altri.
– Come mai, non furono intese cose tanto facili?
– A voi sembrano facili, ma per il popolo sono assai elevate. Lo sfiorare la storia sacra, il volare ragionando sopra un tessuto della storia ecclesiastica, sono tutte cose che il popolo non capisce.
– Che adunque mi consiglia di fare?
– Abbandonare la lingua e l’orditura dei classici, parlare in volgare ove si può, od anche in lingua italiana, ma popolarmente. Invece poi di ragionamenti, tenetevi agli esempi, alle similitudini, ad apologi semplici e pratici. Ma ritenete sempre che il popolo capisce poco e che le verità della fede, non gli sono mai abbastanza spiegate.
Questo paterno consiglio mi servì di norma in tutta la vita. Conservo ancora a mio disdoro quei discorsi, in cui presentemente non iscorgo più altro che vanagloria e ricercatezza. Dio misericordioso ha disposto che avessi quella lezione, lezione fruttuosa, nelle prediche, nei catechismi, nelle istruzioni, e nello scrivere, cui mi ero fin da quel tempo applicato”.
Giovanni in queste vacanze del 1838 ritornò la seconda volta a Cinzano, per concertare col Comollo alcune cose spettanti al vicino anno scolastico. “Un bel giorno, scrive [452] egli ancora nella biografia di questo santo giovanetto, uscii a passeggio col Comollo sopra un colle, donde scorgevasi vasta estensione di prati, campi e vigne. – Vedi, Luigi, presi a dirgli, che scarsezza di raccolti abbiamo quest’anno! Poveri contadini! Tanto lavoro e quasi tutto invano!
– È la mano del Signore, egli rispose, che pesa sopra di noi. Credimi, i nostri peccati ne sono la cagione.
– L’anno venturo spero che il Signore ci donerà frutti più abbondanti.
– Lo spero anch’io, e buon per coloro che si troveranno a goderli.
– Su via, lasciamo a parte i pensieri melanconici; per questo anno pazienza, ma l’anno venturo avremo più copiosa vendemmia e faremo miglior vino.
– Tu ne beverai.
– Forse tu intendi continuare a bere la solita acqua.?
– Io spero di bere un vino assai migliore.
– Che cosa vuoi dire con ciò?
– Lascia, lascia….. il Signore sa quel che si fa.
– Non dimando questo, io dimando che cosa vuoi dire con quelle parole: Io spero di bere un vino assai migliore. Vuoi forse andartene al Paradiso?
– Sebbene io non isperi di andare dopo morte al paradiso, se non per pura misericordia del Signore, tuttavia da qualche tempo mi sento un sì vivo desiderio di andare a gustar l’ambrosia dei beati, che parmi impossibile che siano ancora lunghi i giorni di mia vita.
Questo, diceva il Comollo colla massima ilarità di volto, in tempo che godeva ottima sanità, e sì preparava per ritornare in seminario.
Finite queste ultime vacanze e messosi in via per recarsi in, seminario, giunto ad un luogo, ove procedendo perdeva [453] di vista il suo paese, soffermossi ad un tratto e stette un istante rimirando la patria con una serietà,, insolita. Suo padre fece alcuni passi verso di lui, dicendo: – Che fai Luigi? Non stai bene di sanità? Che guardi?
– Io sono in buona sanità, mi sento bene, ma non posso togliere lo sguardo da Cinzano.
– Che guardi adunque? ti rincresce forse di recarti in seminario?
– Non solo non mi rincresce, ma desidero di arrivare al più presto in quel lungo di pace; quel che guardo si è il nostro Cinzano, che lo rimiro per l’ultima volta.
Richiesto di nuovo, se non istesse bene in salute, se volesse ritornare a casa: – Niente, niente, rispose, sto benissimo, andiamo allegri, il Signore ci aspetta”.
Questo dialogo veniva tosto dal padre di Comollo manifestato a Giovanni, appena giunto al seminario.
Così mesti pronostici però mettevano in serio pensiero il nostro Giovanni, il quale, desideroso che si moltiplicassero i ministri della casa di Dio per la salute delle anime, con rammarico temeva vicina ad eclissarsi una tanto splendida vocazione. Egli infatti conoscendo qual favore inestimabile sia una chiamata del Signore al suo divino servizio ne’ suoi discorsi famigliari coi giovanetti di Chieri, di Castelnuovo e di altri paesi sapeva trovare il momento opportuno per infondere nel loro animo un’altissima idea dello stato sacerdotale e l’obbligo stretto di ottemperare alla divina chiamata. Come S. Paolo egli pensava: Bramo che voi tutti siate quale sono io; ma ciascuno ha da Dio il suo dono; uno in un modo e l’altro nell’altro[105]. E andava pertanto studiando [454] qual fosse il dono che Iddio destinava a’ suoi giovani amici. Se vedeva splendere in essi amore a quella virtù, che rende gli uomini simili agli angeli, teneva per certo che questa fosse l’indizio più sicuro di vocazione. Quindi investigava se avessero inclinazione allo stato ecclesiastico, e con acconcie ragioni ne ispirava loro il desiderio; e se questo già realmente esisteva, secondavalo con saggi consigli, e poi lasciava tranquillamente che Iddio facesse germogliare e maturare il suo prezioso innesto. Così egli fin d’allora incominciava una missione, che fu poi lo scopo ed il lavorio di tutta la sua vita; sicchè a migliaia a migliaia furono le sacre vocazioni di giovanetti, che senza le sue cure sarebbero rimaste sterili. D. Bosco avrebbe fatto qualunque sacrifizio, perchè neanche una sola di queste vocazioni andasse perduta. Descriveremo in altri capitoli le sue mirabili conquiste. Non tutte le volte riuscì nel suo intento; Dio solo conosce i segreti della sua preordinazione e quelli dei cuori; ma eziandio allora la carità di D. Bosco recava vantaggi grandi alle anime.
Abbiamo più sopra parlato del giovane Annibale Strambio, il quale, co’ suoi due fratelli Domenico e Pietro, era stato, compagno con Giovanni a Chieri, nei corsi ora detti ginnasiali. Orbene in quest’anno 1838, il Pietro riceveva una lettera, nella quale Giovanni invitavalo a farsi prete, adducendogli per ragione la sua indole quieta e lene e la sua buona condotta. Nel 1898, Pietro Strambio, Cavaliere, Consigliere emerito di Prefettura, riferiva al Prof. D. Francesco Cerruti: “Io non seguii il consiglio di D. Bosco, perchè non mi sentiva trasportato verso la carriera propostami. Conservai però cara memoria di quel bell’invito, il cui ricordo mi fece sempre del bene nel corso della mia vita. Tengo ancora gelosamente presso di me la sua lettera, la quale ridesta ognora [455] nel mio cuore la commozione che allora provai nel riconoscere quanta buona opinione avesse di me un condiscepolo e amico di tanto merito. Non è a dire la stima che i miei fratelli ed io avevamo per lui. Noi alcuni anni dopo eravamo a Camagna ed egli venne a visitarci. Lo accogliemmo con un vero tripudio; ma quei giorni vennero funestati da un grande incendio sviluppatosi in una cascina. D. Bosco colla sua calma abituale prestava mano a salvare le masserizie e comparve recando la polenta già preparata per la mensa di quel colono. Io gli dissi allora: – Tu, o D. Bosco, che sei tanto buono e che operi miracoli, fa cessare questo incendio -”. E questa opinione della sua santità era radicata e diffusa ne’ suoi compagni, cagione dell’importanza che davasi alle sue parole ed alle sue lettere.
CAPO LI.
Lo studio della teologia – Giovanni è fatto sagrestano della cappella – Preziose confidenze di Comollo con Giovani – Gli esercizii spirituali e il teologo Giovanni Borel – Comollo cade infermo – Sogno prima spaventoso e poi consolante – Sua santa morte – Sua prima apparizione.
UN NUOVO insegnante saliva la cattedra di teologia in Chieri al principio dell’anno scolastico 1838 – 39, il piissimo sacerdote Giovanni Battista Appendini di Villastellone, più tardi per meriti preclari fatto Monsignore, il quale per ben tre anni ebbe a suo discepolo il nostro Giovanni. La intimità, che fin d’allora legollo con questo suo caro allievo, durò per tutta la sua lunga vita.
Frattanto Iddio misericordioso riuniva finalmente nella stessa scuola i chierici Giacomelli, Bosco e Comollo, dall’amicizia de’ quali richiedeva però un grande sacrifizio, rendendo maturo pel paradiso l’angelico Comollo. Intanto a Giacomelli era dato di poter meglio apprezzare il profitto del chierico Bosco negli studi. Così scrisse di lui: “In iscuola era un modello. Aveva una memoria portentosa, ma grandissima era pure la sua applicazione allo studio. Non di rado, studiando le lezioni, confrontava il libro di testo con varii altri autori di teologia. Non imparava tuttavia la lezione [457] ad literam, come usavano fare gli altri. Interrogato sapeva; alcune volte tuttavia cambiava un po’ certe ragioni, mostrava opinioni alquanto diverse da quelle del trattato. Mi ricordo che una volta un professore lo sgridò: – Studii il trattato alla lettera come gli altri! Era questa una delle cose, alle quali il chierico Bosco non si adattò che con difficoltà, e parlandone molti anni dopo, diceva: – Nella scuola di teologia bisogna ottenere che si studii molto; accertarsi che i trattati si sappiano bene e non superficialmente; per la maggior parte degli allievi è proprio meglio che si mandi a me orla quanto vi è nel libro di testo, ma non si deve pretendere allorchè si sa che un chierico studia, capisce ed interrogato risponde costantemente bene”.
In questo secondo anno di teologia, il nostro Giovanni ebbe la fortuna di esser fatto sacristano della cappella del seminario. Era questa una carica di poca entità, se si vuole, ma un prezioso segno di benevolenza dei superiori, cui erano annessi altri franchi sessanta. Cosicchè egli godeva già metà pensione, mentre il caritatevole D. Cafasso provvedeva al rimanente. Il sacrestano deve, aver cura della nettezza della chiesa, della sacrestia, dell’altare, e tenere in ordine lampade, candele e gli altri arredi ed oggetti necessarii al divin culto. Questa carica che gli venne aggiudicata, perchè primeggiava sugli altri nella scienza e nella virtù, come più volte affermarono a D. Cagliero D. Giuseppe Fiorito, suo prefetto di camerata, e D. Giacomelli, gli fu pure occasione di nuovo esercizio di virtù. Narrava infatti D. Giacomo Bosco: “I seminaristi di filosofia e dei primi due corsi di teologia erano spinti verso di lui da uno slancio incredibile, e quelli de’ corsi superiori lo riguardavano con maggior o minor riverenza, secondo le inclinazioni ed i naturali. Chi si distingue per sapere e virtù facilmente è: oggetto di qualche [458] invidiuzza, non avvertita talora da chi ne è amareggiato, ma che trapela nei modi e nelle parole sì da avvedersene chi ne è l’oggetto. Ma la carità e l’umiltà di Giovanni sapeva dissimulare tali miserie. E questa umiltà non si alterava anche quando certi giovani chierici irrequieti non cessavano di motteggiarlo, mortificarlo e talora disprezzarlo, nel vederlo vivere appartato e quasi solo. L’ufficio di sacrestano, che gli era stato assegnato, gli meritò da costoro il soprannome di: Bosco d’ l’oli per la lampia, dall’andare ch’egli faceva ogni giorno a chiedere l’olio all’economo, per la lampada e che arder doveva innanzi all’altare. Ma egli, sempre sereno, e tranquillo, lasciava dire”. Non era però insensibile; e D. Giacomelli ci riferiva che un giorno, non so per quale disparere, Giovanni ebbe a sentirsi dire da un compagno con irrisione del suo ufficio: – Tu minchione delle torcie! – Giovanni divenne rosso fin sui capelli, ma non proferì parola e si allontanò. L’offesa però fu giudicata così grave dai chierici presenti, che uno di essi non potè tenersi dal rimproverare aspramente l’insultatore.
Intanto Comollo, nonostante i presentimenti del fine prossimo della sua vita mortale, aveva ripigliato seriamente i suoi studi ed all’esame semestrale conseguiva ancora il premio di sessanta lire. Sebbene egli dimostrasse la medesima giovialità ed allegria nel ragionare e nel ricrearsi; tuttavia Giovanni scorgeva un non so che di misterioso nella sua condotta. Lo vedeva, oltre l’usato, attento nella preghiera e in tutti gli altri esercizi di pietà e specialmente nella maggior frequenza alla santa Comunione. Udivalo talora esclamare: – Oh! potessi, quando sarò per partire da questo mondo, sentirmi dal Signore un consolante Euge, serve bone et fidelis, vieni, o servo buono e fedele. – E la sua meditazione ordinaria era sull’argomento dell’inferno, per concepire maggior orrore del peccato [459] Ma lasciamo la penna a D. Bosco: “Con grande trasporto di gioia discorreva del paradiso; e fra le belle cose, che mi soleva dire, una fu questa: – Quando mi trovo solo e disoccupato, o quando non posso prendere sonno lungo la notte, allora mi metto a fare le più amene passeggiate. Suppongo trovarmi sopra un’alta montagna, dalla cui cima mi sia dato scoprire tutte le bellezze della natura. Contemplo, il mare, la terra, i paesi, le città, con quanto di più magnifico esiste in essi; levo quindi lo sguardo pel sereno cielo, miro il firmamento, che tutto di stelle tempestato forma il più maraviglioso spettacolo. A questo vi aggiungo ancora l’idea di una soave musica, che a voce ed a suono faccia echeggiare di lieti evviva valli e monti, e deliziando, la mente con questa mia immaginazione, mi volgo in altra parte, alzo gli occhi, ed eccomi innanzi la città di Dio. La miro all’esterno, poscia me le avvicino e penetro dentro; qui pensa tu alle cose, che senza numero io fo passare a rassegna. – Proseguendo nella sua passeggiata raccontavami cose le più curiose ed edificanti, che nella sua mente faceva passare rassegna nelle varie sezioni del paradiso.
Fu pure in quest’anno che gli cavai il segreto di poter pregare senza distrazione. – Vuoi sapere, dicevami, come io mi metta a pregare? Ella è un’immagine tutta materiale che ti farà ridere. Chiudo gli occhi, e col pensiero mi porto entro una grande sala, il cui soffitto è sostenuto da innumerevoli colonne, adornata nella maniera più squisita, e in fondo alla quale si alza un maestoso trono, sovra di cui suppongo stare assiso Iddio nella sua infinita maestà; dopo di lui tutti i cori dei beati comprensori. Questa immagine materiale mi serve maravigliosamente per sollevare il mio pensiero all’infinita Maestà Divina, dinanzi a cui mi prostro e con tutto il rispetto a me possibile fo la mia preghiera” [460]
Nel corso della quaresima (1839), ebbero luogo per i seminaristi di Chieri i santi spirituali esercizi. Giovanni li fece coi sentimenti della più viva divozione. “Fu in quest’anno, così narra egli nelle sue memorie, che ebbi la buona ventura di conoscere uno dei più zelanti ministri del santuario, venuto a dettar gli esercizi spirituali in seminario. Egli apparve in sacrestia cori aria ilare, con parole celianti, ma sempre condite con pensieri morali. Quando ne osservai la preparazione ed il ringraziamento della Messa, il contegno, il fervore nella celebrazione di essa, mi accorsi subito essere quegli un degno ministro di Dio. Egli era il Teol. Giovanni Barel di Torino. Quando poi cominciò la sua predicazione e se ne ammirò la popolarità, la vivacità, la chiarezza e il fuoco di carità che appariva da tutte le parole, ognuno andava ripetendo: Egli è un santo! Difatti tutti facevano a gara per andarsi a confessare da lui, trattate con lui della vocazione ed avere qualche particolare ricordo. Io pure ho voluto conferire col medesimo delle cose dell’anima. In fine, avendogli chiesto qualche mezzo certo per conservare lo spirito di vocazione lungo l’anno e specialmente in tempo delle vacanze, egli mi lasciò con queste memorande parole: – Colla ritiratezza e colla frequente Comunione si perfeziona e si conserva la vocazione e si forma un vero ecclesiastico. Gli esercizi spirituali del teologo Borel fecero epoca in seminario, e parecchi anni appresso si andavano ancora ripetendo le sante massime, che aveva in pubblico predicate o privatamente consigliate”.Il mattino del 25 marzo, giorno della SS. Annunziata, avviandosi Giovanni alla cappella s’incontrò nei corridoi con Comollo, che lo stava aspettando per dirgli essere per lui spedita. Giovanni ne fu molto sorpreso, stantechè il giorno avanti avevano passeggiato molto tempo insieme e lo [461] aveva lasciato in perfetta salute. Comollo soggiunse con voce commossa: Mi sento male e quello che mi atterrisce si è dovermi presentare al gran giudizio di Dio. Giovanni lo esortò a non volersi così affannare, essere queste certamente cose serie assai, ma per lui remote, e aver egli ancora molto tempo a prepararsi. Ciò detto, entrarono in chiesa. Comollo ascoltò ancora la santa Messa, dopo la quale venne sorpreso da uno sfinimento di forze, per cui si dovette trasportare in camera e metterlo a letto. In quel momento, attesta D. Giacomelli, Giovanni annunziò ai compagni che Comollo sarebbe morto di quell’infermità.
“Terminate che furono le funzioni di chiesa scrive D. Bosco nella biografia dell’amico, mi recai a visitar Comollo nel proprio dormitorio. Appena mi vide tra gli astanti, fece segno che me gli appressassi e così prese a parlare: – Mi dicesti che era cosa remota e che eravi ancor tempo a prepararmi prima di andarmene; ma non è così sono certo che debbo presentarmi presto al cospetto di Dio; poco tempo mi resta a dispormi; vuoi che tel dica chiaramente? Abbiamo da lasciarci. – Io lo esortava tuttavia a non inquietarsi e a non affannarsi con tali idee. – Non m’inquieto, interrompendomi disse, nè mi affanno; solo penso che debbo andare al gran giudizio e giudizio inappellabile e questo agita il mio interno. – Quelle parole mi afflissero assai; perciò ogni momento desiderava sapere delle sue nuove, e ogni volta che io lo visitava, mi ripeteva sempre la stessa espressione: – Si avvicina il tempo che debbo presentarmi al divin giudizio; dobbiamo lasciarci. – Talmente che nel decorso di sua malattia non credo d’esagerare dicendo che me l’ha ripetuta più di quindici volte
Frattanto egli febbricitante si stette il lunedì coricato. Aveva predetto che il suo male sarebbe inteso al rovescio [462] dai medici, e così avvenne. Il martedì e mercoledì passolli fuori di letto, per altro sempre triste e melanconico, assorto nel pensiero dei giudizi divini. Alla sera del mercoledì si pose di nuovo a letto come infermo per non levarsi più. Il sabato, a sera, vigilia di Pasqua, andatolo a visitare: Poichè, mi disse, dobbiamo lasciarci e tra poco io debbo presentarmi al giudizio, avrei caro che tu vegliassi meco questa notte. – Il direttore spirituale D. Giuseppe Mottura, scorgendo l’infermo camminare di male in peggio, mi concedette assai volentieri, che passassi presso di lui la notte, che era quella del 30 marzo, precedente al solenne giorno di Pasqua. State attento, mi disse il direttore, e se vi accorgete di grave pericolo, chiamatemi tosto. Notate eziandio ogni particolarità della malattia, e sappiatene ragguagliare il medico domani. Alle otto la febbre facevasi più violenta; alle otto e un quarto l’assalì un accesso di febbre convulsiva sì gagliardo, che gli tolse l’uso della ragione. Sulle prime faceva un lamento prolungato, come se fosse stato atterrito da spaventevole oggetto o da tetro fantasma. Da lì a mezz’ora tornato alquanto in se e guardando fisso gli astanti, gridò ad alta voce: Ahi giudizio! – Quindi cominciò a dibattersi con forze tali, che cinque o sei che eravamo astanti appena lo potevamo trattenere in letto. Tali dibattimenti durarono per ben tre ore, dopo i quali ritornò in piena cognizione di se stesso. Stette lunga pezza pensieroso, come occupato in seria riflessione; quindi deposta quell’aria di mestizia e di terrore, che da più giorni dimostrava pei giudizi divini, comparve tutto placido e tranquillo. Parlava, rideva, rispondeva a tutte le interrogazioni, che gli venivano fatte, a segno che l’avremmo quasi giudicato in regolare condizione di salute. Gli fu chiesto da che provenisse un tale cangiamento, essendo poco prima cosi triste ed ora tanto gioviale ed affabile. A quella dimanda [463] mostrossi alquanto imbarazzato a rispondere; di poi, rivolto qua e là lo sguardo se da nissuno fosse udito, prese a parlarmi sotto voce: – Finora paventai di morire pel timore del giudizio divino; questo tutto mi atterriva; ma ora son tranquillo, nulla più temo per le seguenti cose, che in amichevole confidenza ti racconto. Mentre era estremamente agitato pel timore dei giudizi divini, parvemi in un istante essere trasportato in una profonda ed ampia valle, in cui l’agitazione dell’aria e le bufere di un vento furioso toglievano forza, e vigore a chiunque colà capitava. Nel centro di quella valle era un grande abisso a guisa di larga e profonda fornace, onde uscivano fiamme avvampanti. Di quando in quando vedeva anime, delle quali alcune riconobbi, cadere là entro, e a quel tonfo globi immensi di fuoco e di fumo si sollevavano verso il cielo….. A tale vista spaventato mi posi a gridare per timore di dover precipitare in quella spaventosa voragine. Perciò mi voltai all’indietro per fuggire, ed ecco una innumerevole turba di mostri di forma orribile e diversa, che tentavano urtarmi in quell’abisso… Allora gridai più forte vie più atterrito, senza sapere che mi facessi, e mi segnai col segno della santa Croce. A quell’atto religioso tutti quei mostri volevano chinare il capo, ma non potendo si contorcevano, scostandosi alquanto da me. Tuttavia non poteva ancora fuggire e allontanarmi da quel malaugurato luogo; allorchè vidi una moltitudine di uomini armati, che a somiglianza di forti guerrieri venivano in mio soccorso. Essi assalirono vigorosamente quei mostri, alcuni dei quali rimasero sbranati, altri giacquero stesi a terra, altri si diedero a precipitosa fuga. Liberato da quel pericolo, presi a camminare per quella spaziosa valle, finchè giunsi ai piè di un’alta montagna, su cui solo si poteva salire per una scala. Ma questa aveva gli scalini tutti occupati da grossi serpenti, pronti a [464] divorare chiunque vi ascendesse. Eppure non v’era altro passaggio che quello, ed io non osava avanzarmi temendo essere da quei serpenti divorato.. Quivi abbattuto dalla stanchezza e dagli affanni, privo di forze, già veniva meno quando una Donna, ch’io giudico essere la comune nostra Madre, vestita in gran pompa, mi prese per mano e fecemi rizzare in piedi dicendo: – Vieni meco. Hai lavorato in mio onore e mi hai tante volte invocata; pertanto è giusto che ora ne abbi la dovuta mercede. Le Comunioni fatte in mio onore ti meritano lo scampo dal pericolo, in cui ti ha posto il nemico delle anime. – Intanto Ella mi fe’ cenno di seguirla per quella scala. Come essa pose piede sugli scaglioni, tutti quei serpenti voltavano altrove la mortifera loro testa, nè sì volgevano verso di noi, se non quando eravamo alquanto da loro lontani. Giunti in cima a quella scala, mi trovai in deliziosissimo giardino, dove io vidi cose, che non mi sono giammai immaginato che esistessero. Quando fui in sicuro, la benefica Signora mi aggiunse queste parole: – Ora sei in salvo. La mia scala è quella che deve condurti al sommo bene. Animo, figlio mio, il tempo è breve. Quei fiori, che formano, sì bello ornamento in questo giardino, sono raccolti dagli angioli, con cui ti vanno intrecciando una corona di gloria a fine di collocarti tra i miei figli nel regno de’ cieli. – Ciò detto disparve. Queste cose, conchiuse il Comollo, appagarono talmente il mio cuore e mi resero così tranquillo, che ben lungi dal temere la morte, io desidero che venga presto, affine di potermi unire cogli angioli del cielo per cantare le lodi, del mio Signore. Sin qui, l’infermo.
Checchè se ne voglia dire del sovraesposto racconto, il fatto fu che quanto grande era prima il suo timore di comparire innanzi a Dio, altrettanto di poi manifestavasi il suo desiderio che giungesse quell’istante. Non più tristezza o [465] malinconia in volto, ma tutto ridente e gioviale, voleva sempre cantare salmi, inni o laudi spirituali.
Sebbene lo stato della sua malattia apparentemente sembrasse assai migliorato, tuttavia sul fare dell’alba, ho stimato di avvertirlo essere cosa buona che in quel giorno ricevesse i SS. Sacramenti, occorrendo appunto la solennità di Pasqua. – Volentieri, ripigliò; non ho alcuna cosa che mi inquieti la coscienza; nulladimeno, atteso lo stato in cui mi trovo, ho piacere di parlare un momento col mio confessore prima di ricevere la santa Comunione.
Spettacolo poi veramente edificante e maraviglioso fu la sua Comunione. Terminata la confessione, fatta la preparazione per ricevere il SS. Viatico, già il signor direttore, che ne era il ministro, seguito dai seminaristi, entrava nell’infermeria; quando al suo primo comparire l’infermo tutto commosso, cangia colore, muta d’aspetto, e pieno di santo trasporto esclama: – Oh bella vista… Giocondo vedere…! Mira come risplende quel sole! Quante belle stelle gli fanno corona! Quanti prostrati a terra l’adorano e non osano alzare la chinata fronte! Deh! lascia che io vada ad inginocchiarmi con loro e adori anch’io quel non mai veduto sole. – Mentre tali cose diceva, voleva rizzarsi, e con forti slanci tentava portarsi verso il SS. Sacramento. Io mi sforzava a fine di trattenerlo in letto; mi cadevano lagrime di tenerezza e di stupore; e non sapeva che dire, nè che rispondergli. Ed egli vie più si dibatteva, onde portarsi verso il SS. Viatico; nè si acquetò, finchè non l’ebbe, ricevuto. Dopo la Comunione stette alcun tempo immobile, tutto concentrato nei più affettuosi sentimenti verso Gesù; quindi si lasciò andare in novelli trasporti di gioia, pronunciando per un buon tratto di tempo fervorose giaculatorie. Infine, abbassata la voce, chiamommi a sè e mi pregò a non parlargli più d’altro che di cose [466] spirituali, dicendo essere troppo preziosi, quegli ultimi momenti che gli restavano ancor di vita, e doverla tutta impiegare a il suo Dio; perciò non darebbe più alcuna risposta, qualora fosse interrogato intorno ad altre cose.
Intanto l’infermo, apparendo assai prostrato di forze e palesando tendenza al sonno, si lasciò alquanto riposare. I seminaristi erano andati alle sacre funzioni del duomo
Dopo breve riposo, si svegliò e trovandosi solo con me prese a così parlarmi: – Eccoci, o caro amico, eccoci al momento, in cui noi dobbiamo per alcun tempo lasciarci. Noi pensavamo di confortarci nelle vicende della vita, aiutarci, consigliarci in tutto quello che ci avrebbe potuto giovare alla eterna nostra salvezza.. Non era scritto così nei santi e sempre adorabili voleri del Signore. Tu mi hai sempre aiutato nelle cose spirituali, nelle cose scientifiche ed anche temporali, ed ora ti ringrazio. Dio te ne rimeriti. Ma prima di lasciarci, ascolta alcuni ricordi di un tuo amico. L’amicizia non importa solo di far quanto l’amico richiede mentre vive, ma di eseguire altresì quello che a vicenda si è promesso da effettuarsi dopo la morte. Perciò il patto, che abbiamo fatto colle più obbliganti promesse, di pregare a vicenda, a fine di poterci salvare, non solo voglio che si estenda sino a morte dell’uno o dell’altro, ma di ambedue: onde finchè tu condurrai i tuoi giorni quaggiù, prometti e giura di pregar per me. – Benchè in udir tali parole mi sentissi forzato a piangere, pure frenai le lacrime e promisi nel modo richiesto quanto voleva. Quindi, datimi alcuni, avvisi, concludeva – Una cosa ho ancora da dimandarti, di cui ti prego cordialmente. Quando andrai al passeggio, e passando presso il luogo di mia tomba, udirai i compagni a dire: Qui sta sepolto il nostro collega Comollo, allora tu suggerisci in prudente maniera a ciascheduno da parte mia, che mi recitino un Pater [467] ed un Requiem. In tal guisa io sarò dalle pene del purgatorio liberato. Molte cose ti direi ancora, ma il male prende forza e m’opprime; perciò raccomandami alle preghiere degli amici, prega il Signore per me, Iddio ti accompagni e ti benedica e ci rivedremo quando egli vorrà.
Sulla sera dei giorno di Pasqua apparve così prostrato, che appena poteva articolare e pronunciare qualche parolai quando fu sorpreso da nuovo e più violento accesso di febbre, accompagnata da dolorose convulsioni, sicchè a stento si poteva trattenere. Comunque fuori di sè o agitato dalla violenza del male, dettogli appena: – Comollo, per chi bisogna soffrire? egli subito rinvenendo, tutto gioviale e ridente – Per Gesù Crocifisso – rispondeva.
In simile stato, senza mai proferire un lamento, per la atrocità dei dolori, passò la notte e quasi intiero il giorno susseguente. Di quando in quando si metteva a cantare con voce ordinaria e così sostenuta, che l’avreste giudicato in perfetto stato di salute. Il suo canto era il Miserere, le Litanie della Madonna, l’Ave maris Stella e laudi spirituali.: Ma siccome il cantare di troppo lo prostrava, si cercò di suggerirgli qualche preghiera; così egli cessava di cantare per recitare quello che gli veniva suggerito.
Alle sette di sera del 1° aprile, andando le cose ognora peggio, il direttore spirituale stimò bene amministrargli l’Olio Santo; ed egli, che poco prima sembrava in agonia, riavutosi pienamente rispose a tutte le preci e responsorii, che in quella amministrazione occorrono. Lo stesso avvenne alle undici e mezzo, quando il signor rettore, Can. Sebastiano Mottura, al vedere che un freddo sudore cominciava a coprirgli il pallido volto, gli impartì la papale benedizione.
Amministrati così tutti i conforti di nostra santa cattolica religione, non pareva più un infermo, ma uno che stesso in [468] letto per riposo: era pienamente consapevole di se stesso, con animo pacato e tranquillo; tutto allegro, ad ogni momento innalzava fervorose giaculatorie a Gesù Crocifisso, a Maria Santissima, ai Santi: onde il signor rettore, ebbe a dire: – Egli non abbisogna che altri gli raccomandi l’anima, essendo sufficiente per se medesimo. A mezza notte, con voce assai robusta intuonò l‘Ave maris Stella, e continuò quest’inno sino all’ultimo versetto, senza desistere, nonostante che i compagni lo pregassero a non istancarsi. Era tanto assorto in se stesso e traspariva dal suo volto tale un’aria di paradiso da sembrare un angiolo.
Richiesto da un compagno: – Che cosa ti consola di più in questo momento? – Aver fatto qualche cosa per amore di Maria e l’aver frequentato la santa Comunione – rispose.
Ad un’ora e mezzo dopo la mezzanotte 2 aprile, benchè conservasse sempre la solita serenità nel volto, apparve talmente estenuato di forze, che sembrava mancargli il respiro. Rinvenuto poscia un tantino, raccolto quanto aveva di vigore, con voce tronca, cogli occhi elevati al cielo, proruppe in tali atti di amore e di confidenza verso Maria, che tutti gli astanti erano commossi sino alle lagrime. Vedendo venirgli meno il polso, m’accorsi appressarsi il momento, che egli doveva abbandonare il mondo ed i suoi compagni: perciò presi a suggerirgli quel tanto, che venivami a proposito in simili circostanze. Ed egli tutto attento a ciò che gli si diceva, col volto e colle labbra ridenti, conservando l’inalterabile sua tranquillità, fissi gli occhi nel Crocifisso, che stretto teneva fra le mani giunte innanzi al petto, si sforzava di ripetere ogni parola che gli veniva suggerita. Circa dieci minuti prima del suo spirare mi chiamò per nome e, se vuoi, mi disse, qualche cosa per l’eternità, io…. addio, me ne parto. Gesù e Maria, metto nelle vostre mani l’anima ma. – Queste [469] furono le ultime sue parole. Quindi per la durezza delle labbra e la spessezza della lingua, non potendo più colla voce pronunziare le giaculatorie suggerite, le componeva e le articolava colle labbra.
Eranv. altresì due diaconi, D. Sassi e D. Fiorito, che gli leggevano il proficiscere, il quale terminato, nell’atto che si pronunciavano i santi nomi di Gesù e di Maria, sempre sereno e ridente in volto, movendo egli un dolce sorriso a guisa di chi resta sorpreso alla vista di un meraviglioso e giocondo oggetto, senza fare alcun movimento, l’anima sua bella si separò dal corpo, volando, come piamente si spera, a riposare nella pace del Signore. Il suo felice transito avvenne alle due dopo mezzanotte, prima che sorgesse l’aurora del 2 aprile 1839, in età di anni 22, meno cinque giorni”.
In quella notte, narrava D. Giacomo Bosco, il chierico Vercellino di Bulgaro, che dormiva in una camerata diversa da quella del chierico Bosco, a un tratto essendo svegliato, si mette a gridare: – C è Comollo, c’è Comollo. – Tutti si destano, si rivolgono a lui, lo interrogano. Bosco Giacomo viceprefetto, lo invita a far silenzio; ma Vercellino andava ripetendo: – Comollo è morto! – I compagni gli dicevano essere ciò impossibile, perchè alla sera Comollo sembrava di motto migliorato. Eppure l’ho visto io. Comollo entrò nella camerata e disse: Sono morto adesso! E poi disparve. – Mentre l’uno affermava e gli altri volevano persuaderlo di aver sognato, ecco i diaconi Fiorito e Sassi, che in quella notte erano stati incaricati di assistere l’infermo, entrare in camerata. Ebbene, tutti li interrogarono, Comollo come sta? – È morto, risposero. Ed a che ora? – Saranno dodici minuti – Si pensi lo stupore, dal quale furono tutti compresi a queste parole. Dunque non era stato un’ illusione!”.
CAPO LII.
Solenne sepoltura di Comollo – Apparisce ad un’intiera camerata di seminaristi – Giovanni in vacanza – Giorgio Moglia – Presso il Teol. Comollo – Da D. Giuseppe. Cafasso – Dite fausti avvenimenti.
FATTOSI giorno e sparsasi la voce della morte del Comollo, la più grande costernazione invase il seminario. Tutti però a comune conforto si dicevano: A quest’ora Comollo è già in paradiso a pregare per noi; e andavano a gara per ottenere qualche oggetto che gli fosse appartenuto per ritenerlo come memoria di tanto amato e venerato collega. Il rettore del seminario, mosso pur egli dalle singolari circostanze che accompagnarono la morte di lui, comportando a malincuore che il suo cadavere fosse portato al cimitero comune, appena giorno si recò a Torino dalle autorità civili ed ecclesiastiche, da cui ottenne che fosse sepolto nella chiesa di S. Filippo annessa al seminario medesimo. Pertanto il mattino del 3 aprile, coll’intervento di tutti i seminaristi, di tutti i superiori, del signor canonico curato cogli altri canonici e col clero, e di un popolo immenso fu il cadavere portato processionalmente per la città di Chieri, e dopo lungo giro venne accompagnato alla suddetta chiesa di S. Filippo. Quivi giunti con lugubre musica e pomposo apparato si cantò messa dal [471] direttore, presente cadavere; il quale, terminata la funzione, venne deposto in una tomba preparatagli vicino allo steccato che ne tramezza la balaustrata, quasi che quel Gesù Sacramentato, verso cui mostrò tanto amore e col quale sì volentieri si tratteneva, vicino pure lo volesse anche dopo morte.
Appena sepolto Comollo apparve una seconda volta, essendo testimone del fatto un’intera camerata di seminaristi. Ecco come D. Bosco narra il portentoso avvenimento: “Attesa l’amicizia e la confidenza illimitata che passava tra me e Comollo, eravamo soliti a parlare di quanto poteva ad ogni momento accaderci, vale a di re della nostra separazione in caso di morte. Un giorno, ricordando ciò che avevamo letto in alcuni libri di vite dei santi, tra celia e serietà dicemmo che sarebbe stata una grande consolazione, se quello di noi due che pel primo fosse chiamato all’eternità avesse portato all’altro notizia dello stato suo. Rinnovando più volte questi discorsi, ci siamo fatta reciproca promessa di pregare l’uno per l’altro e che colui che fosse il primo a morire avrebbe recate novelle di sua salvezza al compagno superstite. Io non conosceva tutta la importanza di tale promessa, e confesso che ci fu molta leggerezza, nè mai sarei per consigliare altri a farla; tuttavia tra di noi si ritenne sempre sul serio quale sacra promessa da mantenersi. Più volte l’abbiamo confermata, specialmente nell’ultima malattia del Comollo, mettendo però sempre la condizione, se Dio avesse ciò permesso e fosse stato di suo gradimento. Le ultime parole di Comollo e l’ultimo sguardo mi avevano assicurato dell’adempimento del nostro patto.
Alcuni compagni ne erano informati e stavano ansiosi di vederlo verificato. Io ne era ansiosissimo, perchè sperava un grande conforto alla mia desolazione. [472]” Era la notte del 3 al 4 aprite, notte che seguiva il giorno della sua sepoltura, ed io riposava con venti alunni del corso teologico in quel dormitorio, che dà nel cortile a mezzodì. Ero a letto, ma non dormiva e, stava pensando alla fatta promessa; e quasi presago di ciò che doveva accadere, era in preda ad una paurosa commozione. Quando, sullo scoccare della mezzanotte, odesi un cupo rumore fondo al corridoio, rumore che rendevasi più sensibile, più cupo, più acuto a misura che si avvicinava. Pareva quello di un carrettone tirato da molti cavalli, di un treno di ferrovia, quasi dello sparo di un cannone. Non saprei esprimermi, se non col dire che formava un complesso di fragori così vibrati e in certo modo così violenti, da recare spavento grandissimo e togliere le parole di bocca a chi l’ascoltava. Ma nell’atto che si avvicinava alla porta del dormitorio, lasciava dietro di sè rumoreggianti le pareti, la volta’ il pavimento del corridoio, come se fossero costrutti di lastre di ferro scosse da potentissimo braccio. Il suo avvicinarsi non era sensibile in da potersi misurare il diminuirsi delle distanze; ma lasciava una incertezza quale lascia una vaporiera, della quale talora non si può conoscere il punto ove si trova nella sua corsa, se si è costretti a giudicare dal solo fumo che si stende per l’aria.
I seminaristi di quel dormitorio si svegliano, ma niuno parla. Io era impietrito dal timore. Il rumore si avanza, ma sempre più spaventoso; è presso al dormitorio; si apre da sè violentemente la porta del medesimo; continua, più veemente il fragore senza che alcuna cosa si veda, eccetto una languida luce, ma di vario colore, che pareva regolatrice di quel suono. Ad un certo momento si fa improvviso silenzio, splende più viva quella luce, e si ode distintamente risuonare la voce del Comollo, ma più esile di quando era vivo, che, per tre volte consecutive, diceva: – Bosco! Bosco! Bosco! Io sono salvo! [473]” In quel momento il dormitorio venne ancora più luminoso, il cessato rumore di bel nuovo si fe’ udire di gran lunga più violento, quasi tuono che sprofondasse la casa, ma tosto cessò ed ogni luce disparve. I compagni, balzati di letto, fuggirono senza saper dove; si raccolsero alcuni in qualche angolo del dormitorio per darsi animo a vicenda, si strinsero altri intorno al prefetto di camerata, che era D. Giuseppe Fiorito da Rivoli; e così passarono la notte, aspettando ansiosamente il sollievo della luce del giorno. Tutti avevano udito il rumore. Parecchi intesero la voce, senza capirne il senso. S’interrogavano a vicenda che cosa significasse quel rumore e quella voce, ed io, stando seduto sul mio letticciuolo diceva loro che si tranquillizzassero, asserendo che aveva distintamente intese le parole: – Sono salvo. – Alcuni però l’avevano intesa, al pari di me, risuonare sul mio capo, a segno che per molto tempo si andava ripetendo nel seminario.
Io ho sofferto assai e fu tale il mio spavento, che in quell’istante avrei preferito di morire. Fu la prima volta che a mia ricordanza abbia avuto paura. Di qui incominciò una malattia, che mi portò all’orlo della tomba e mi lasciò così male andato di sanità, che non ho potuto più riacquistarla, se non molti anni dopo.
Dio è onnipotente, Dio è misericordioso, Per lo più non dà ascolto a questi patti; talvolta però nella sua infinita misericordia permette che abbiano il loro compimento, come nel caso esposto. Non sarei mai per dare ad altri consiglio di questo genere. Trattandosi di mettere in relazione le cose naturali colle soprannaturali, la povera umanità ne soffre gravemente, specialmente in cose non necessarie alla nostra eterna salvezza. Siamo abbastanza certi dell’esistenza dell’anima, senza cercare altre prove. Ci basti quello che ci ha rivelato N. S. Gesù Cristo”. [474] Quando D. Bosco ristampava nel 1884 la biografia del Comollo, alcuni testimoni di questa apparizione erano ancora viventi; anzi le bozze della prima edizione, nella quale se ne fa cenno, furono lette e rivedute dai superiori del seminario e dai compagni che ne furono testimoni oculari. D. Fiorito Giuseppe poi la raccontò soventi volte ai superiori dell’Oratorio. L’avvenimento destò rumore anche fuori dei seminario, e alcuni ne intesero parlare dal campanaro del duomo Domenico Pogliano che affermava la verità del fatto.
Non ostante le sofferenze patite per la perdita dell’amico e lo spavento provato per quell’apparizione, sofferenze che diedero il tracollo alla sua salute già indebolita dalle lunghe, veglie sui libri e lo trassero, com’egli stesso dice, sull’orlo della tomba, un giovanetto chierico, spiritello irrequieto e allora irriflessivo, che non apparteneva alla camerata del nostro Giovanni, stizzito di vederlo sempre contegnoso, gli andava sovente vicino ripetendogli – Bosco, Bosco, Bosco sono salvo! – Giovanni sentiva riaprirsi una dolorosa ferita; quelle parole ripetute per burla suonavano male al suo, orecchio, eppure ci sorrideva, minacciava scherzosamente col dito e taceva. Lo stesso chierico, che fu poi un santo e zelantissimo sacerdote, narrava queste sue bizzarrie, per darci un’idea della pazienza e del dominio che aveva il chierico Bosco sopra la sua indole naturalmente focosa.
Sul finire di giugno pertanto Giovanni, ancor malaticcio, ritornava a santificare col solito ardore le sue vacanze. Desiderando i signori Moglia che il loro figlio Giorgio si facesse prete, passando Giovanni alla loro cascina, gliel consegnarono, perchè lo conducesse a casa sua al Susambrino e seco lo tenesse in tutto il tempo delle ferie, trattandolo come fratello. Giovanni gli cedette per dormire il proprio materasso, e per tre mesi intieri gli fece scuola tutti i giorni. [475] Quivi con Giorgio s’incontrarono altri giovanetti, che venivano da Castelnuovo, per aver da Giovanni ripetizione di lingua latina; ed egli, colle cinque lire retribuite dai parenti di, due fra essi, si provvedeva,: qualche poco di vestito e di calzamenta pel nuovo anno scolastico. Francesco Bertagna, che poi fu professore e cavaliere, per due anni frequentò quelle lezioni autunnali. Giovanni di quando in quando conduceva i suoi otto o dieci alunni, come ci narrò lo stesso Giorgio, a fare passeggiate ora da una parte ed ora da un’altra. Un giorno presero tutti la via che conduceva alla Moglia, per passare un giorno di allegria col signor Luigi. Strada facendo incontrarono due ragazzi mal vestiti e il chierico Bosco loro domandò: – Dove andate? – Andiamo a cercar pane, gli risposero. Giovanni li fissò commosso, e – Se è così, soggiunse, venite; con me e troverete pane. – E seco li condusse. Quest’atto svelava l’animo suo generoso, che tanti poveri giovanetti abbandonati avrebbe raccolti sotto le ali dell’inesauribile provvidenza di Dio. Giorgio, alla scuola di un maestro così affettuoso, in questo e nell’anno seguente fece de’ grandi progressi, senonchè sul finire delle seconde vacanze disse schiettamente a Giovanni come non sentisse alcuna inclinazione per farsi prete.. – Ebbene, gli rispose Giovanni; fa come vuoi, in tutti gli stati uno può salvarsi, purchè viva da buon cristiano. Ricordati però di curare sempre il male che vedrai negli altri, osserva che il guasto non corrompa il sano, e cerca col buon esempio colla parola di salvar anime anche in quello stato che il Signore ti destina. Impedisci sempre i cattivi discorsi e le bestemmie ed avvisa gli sboccati, specialmente se vi fossero fanciulli presenti, acciocchè non ne piglino scandalo
Giovanni frattanto non dimenticava il prevosto D. Comollo, e recavasi più volte a Cinzano per dare e ricevere consolazione, ripetendo ambedue quanto sapevano delle amabili [476] virtù del nipote e dell’amico. E Giovanni incominciava a stendere le prime memorie, che meditava di dare alle stampe, per eternare i fatti di quel giovane angelico, mentre per accondiscendere all’invito di quel venerando sacerdote, che gli portava tenerissima affezione, teneva in qualche festa discorso alla sua popolazione.
In mezzo a tutte queste sue varie occupazioni, alle quali aggiungi il fedele servizio alle funzioni parrocchiali, eragli soave conforto il fare visite affettuose al caro D. Cafasso, che veniva allora nell’autunno per qualche settimana a riposarsi nella casa paterna in Castelnuovo dalle fatiche del sacro ministero e dalla scuola di morale al convitto di S. Francesco d’Assisi in Torino, che eragli stata affidata nel 1839. “Se tu vedi un uomo sensato, va di buon grado a trovarlo e il tuo pie’ consumi i gradini della sua porta”[106]. E la soglia di quella porta benedetta, sì a Castelnuovo come a Torino, fu logorata da’ pie’ del nostro Giovanni. Il buon chierico avidamente ascoltava le parole del santo prete sua benefattore, col quale aveva in perfetta armonia i sentimenti. E non dobbiamo noi credere che la gioia del Cafasso per la canonizzazione di S. Alfonso Maria de’ Liguori avvenuta in quest’anno non siasi trasfusa nel cuore di Giovanni? Questa apoteosi proponeva all’episcopato un modello di obbedienza alla Santa Sede e innalzava una fiaccola luminosissima di scienza morale cattolica, dissipatrice delle tenebre disperanti del giansenismo. Amore e fiducia in Dio, unione col suo Vicario in terra doveva preparare i fedeli alla lotta del bene contro del male, che incessantemente affilava le sue armi per rovesciare ogni ordine religioso, morale e sociale. [477]
Infatti nel 1839 incominciarono a Pisa i Congressi degli scienziati, e negli anni seguenti continuarono a Torino, a Genova ed in ultimo a Casale nel 1847, promossi dai capi dei rivolgimenti, per radunarsi senza dare nell’occhio ai zelanti dell’ordine. Mentre gli eruditi disputavano ingenuamente di scienze, arti, agricoltura; i settarii delle varie fazioni si intendevano occultamente fra di loro, e disponevano dei mezzi per potere in un avvenire non lontano proclamare la repubblica in Italia e pel primo abbattere il trono del Pontefice[107]. E i principi italiani ingannati, mentre ad ogni stormir di foglia pareva che temessero usurpazioni papali contro i loro cesarei diritti, proteggevano, lodavano, aiutavano questi Congressi Solo il Papa Gregorio XVI, che leggeva entro le segrete cose, si dimostrò contrario, e, quasi prevedendo il futuro, dava un monito ai principi, approvando il culto che da tempo immemorabile rendeva il popolo piemontese ai Reali Umberto e Bonifacio di Savoia. Essi eransi guadagnata l’aureola immortale della gloria, dando a Dio quel che è di Dio; il quale, Re dei Re, Signore dei Dominanti, per Gesù Cristo ha trasmesso in perpetuo alla Chiesa, cioè al regno suo sopra la terra, tutte le genti in retaggio ed in dominio[108], ordinando, di istruirle, battezzarle e insegnar loro di osservare tutto quello che Egli ha comandato[109]. Quindi il principe cristiano è nella Chiesa e non sopra la Chiesa, e a lei nelle cose spirituali e morali ed in tutto ciò che forma la sua compagine divina ed umana deve rispetto ed obbedienza. La Chiesa abbraccia tutti i regni, e gli Stati Cattolici sono nella Chiesa[478] presieduta dal Pontefice di Roma con pienezza d’autorità. Nel conflitto delle due autorità, bisogna obbedire a Dio piuttostochè agli uomini[110].
Questo fausto avvenimento ed il suo alto significato celebrossi per ordire di Mons. Fransoni, nel duomo di Torino, con un triduo di feste solennissime, il 28, 29, 30 giugno, a gloria di due Beati di Casa Savoia. Il magnanimo Re Carlo Alberto non era degenere da questi suoi avi; egli amava la Chiesa. Benchè aspirasse a cingere la corona d’Italia; benchè conoscesse, cercasse e rivolgesse a suo pro le arti dei liberali sparsi nei varii Stati e, preparasse i mezzi per la guerra dell’indipendenza; non era però nelle sue intenzioni recar sfregio al Pontificato Romano. Egli aveva introdotti e protetti nel suo Stato varii Ordini religiosi, voleva che l’educazione impartita alla gioventù fosse informata a principii cattolici in tutte le circostanze proclamavasi devoto al Pontefice e alla Santa Sede, e in quest’anno chiedeva e otteneva un Nunzio mandato Apostolico, per rendere più intime e dirette le sue comunicazioni colla Santa Sede, ed il primo Nunzio mandato dal Papa in Torino fu Vincenzo Massi, Arcivescovo di Tessalonica. Nel 1840, sollecitato dal Consiglio Supremo di Sardegna a sopprimere le decime ecclesiastiche in quell’isola, dotando quel clero in altra maniera, egli non volle che vi si ponesse mano senza il beneplacito del Sommo Pontefice. Nel 1841 ricorreva al Papa e stringeva una convenzione con lui per restringere il privilegio del foro e l’immunità personale degli ecclesiastici; convenzione per cui restava stabilito che i magistrati laici giudicassero, i crimini, gli ecclesiastici i delitti; nei casi di condanna a morte, il vescovo esaminasse [479] gli atti del giudizio e la sentenza; ove trovasse irregolarità e gravi cause in favore del condannato, rimettesse la sentenza ad una commissione di tre vescovi dello Stato: se questi trovassero provata la reità, entro un mese si passasse alla degradazione del colpevole ed all’esecuzione della sentenza. E questo suo ossequio alla Santa Sede lo aveva già chiaramente dimostrato promulgando il suo codice civile nel 1837; Dopo avere premesso: Essere stato suo studio procurare agli amati suoi sudditi il beneficio di una legislazione unica e conforme al principii della santa religione cattolica e ai fondamentali principii della monarchia, stabiliva: “La Religione Cattolica, Apostolica, Romana essere la sola Religione dello Stato. Gloriarsi il Re di essere protettore della Chiesa e di promuovere l’osservanza delle leggi di essa nella materia che alla potestà della medesima appartiene…. Che i magistrati supremi veglieranno a che si mantenga, il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato ….. Gli altri culti già esistenti nello Stato essere semplicemente tollerati”. Nel 1839, il 26 ottobre, pubblicando il codice penale, comminava la reclusione o il carcere contro chiunque turbasse, interrompesse o impedisse con violenza le sacre funzioni nelle chiese o fuori di esse: ovvero facesse oltraggio ai ministri della Religione nell’esercizio delle loro funzioni: contro chi avesse profferito bestemmie, profanando il nome di Dio, della Vergine e dei Santi: contro coloro che con pubblici insegnamenti, con arringhe, scritti, libri e stampe attaccasse la Religione dello Stato. Confermava eziandio i regolamenti riguardanti l’osservanza dei giorni festivi. La condanna ai lavori forzati a vita o a tempo per chi distruggesse o rompesse vasi sacri, reliquie o immagini, nelle chiese, vestiboli, sagrestie o anche fuori di questi luoghi, in occasione di pubbliche funzioni religiose. E alla reclusione, quando detti oltraggi si facessero in luoghi non sacri. [480] Coll’ultimo supplizio era punito chi avesse conculcato ostile consecrate o commesso altro atto di disprezzo su di esse. Questo zelo del Re per l’onore di Dio ci spiega la cordiale amicizia che univalo al Venerabile Cottolengo, col quale sovente compiacevasi intrattenersi in famigliari colloqui sull’opera della Piccola Casa della Divina Provvidenza; ed eziandio l’affezione profonda che, come vedremo, a lui portava D. Bosco, il quale dal seno della sua famiglia aveva, come ogni buon piemontese di quei tempi, imparato a riguardare la sacra sua persona come il rappresentante di Colui, pel quale regnano i principi. E pel suo sovrano e per la reale sua casa, come certamente a noi consta, pregava allora e continuò a pregare e a far pregare negli anni seguenti; e non avrebbe rifiutato di sottoporsi ai più gravi sacrificii, quando il dovere di suddito fedele glieli avesse imposti. Nell’avvicendarsi di dolorosi avvenimenti, che straziavano il suo cuore sacerdotale, mai non udimmo dal suo labbro una parola ostile od irriverente; e la sua condotta fu costantemente ispirata dalle parole di S. Pietro: “Siate riguardo a Dio soggetti ad ogni uomo creato: tanto al Re sopra di tutti quanto ai Presidi come spediti da lui per far vendetta dei malfattori e per onorare i buoni”[111].
CAPO LIII.
Infermità mortale e guarigione di Giovanni in seminario – È insignito degli Ordini Minori – Lettera del suo antico maestro D. Lacqua Predizione avverata – Una poesia per l’onomastico del prevosto – È colpito dal fulmine – Mons. Fransoni gli concede d’abbreviare di un anno il corso teologico – Giovanni predica in varie chiese – Sua lettera ad uno studente rimandato agli esami – Riceve il Suddiaconato.
QUANTUNQUE l’aria del paese natio poco avesse giovato alla malferma salute del nostro Giovanni, tuttavia all’incominciare dell’anno scolastico 1839 – 40 egli ripigliava i suoi studi ed il suo ufficio di sagrestano in seminario. Non è però a credere che il suo corpo fosse talmente disfatto, da più non conservare quella vigoria che eragli stata augurata nel primo sogno: “Fatti robusto e forte”. Una sera invero, in tempo di ricreazione, dopo aver narrato, secondo il suo costume, alcuni fatti edificanti per esilarare i compagni, prese a descrivere le prove di destrezza, nelle quali erasi esercitato da fanciullo, ed eziandio la sfida del saltimbanco. Molti chierici, che non avevano fatto gli studi a Chieri, stentavano credere alle sue parole. Fra questi vi era Giacomelli. Giovanni esclamò allora: – Non volete credere? A me! – E preso un seggiolone [482] pesantissimo di legno, lo sollevò da terra con un braccio solo, fece con esso varii giuochi, se lo pose sul mento, poggiandovelo sopra per una sola gamba e lasciandovelo isolato alcun tempo, e così passeggiava per la stanza. Il chierico Giacomelli, che ciò riferivaci, lo guardava stupito, ammirando la sua destrezza e forza muscolare, ed esclamò: Ora incomincio a credere! – Contuttociò la sanità di Giovanni andava sempre più deperendo. Era omai un anno intero che stava languente, ed in fine fu costretto a coricarsi. Gli ripugnava ogni sorta di cibo, era travagliato da un’ostinata insonnia, e i medici lo dichiararono spedito. Da un mese teneva il letto. La madre, che nulla sapeva della disperata condizione del figlio, venne un giorno a visitarlo, recandogli una bottiglia di vino generoso ed un pane di miglio. Introdotta nell’infermeria, conobbe subito la gravità del caso, e nel ritirarsi voleva riportarsi quel pane, cibo molto pesante per lo stomaco; ma Giovanni la pregò tanto di lasciarglielo, che essa dopo qualche difficoltà lo accontentò. Rimasto solo, fu preso da smania di mangiare quel pane e bere quel vino. Incominciò dallo staccare un piccolo boccone e masticarlo bene; gli parve gustosissimo. Poi ne tagliò una fetta, quindi una seconda, e senza badare ad altro, finì col trangugiarlo tutto ed accompagnarlo con quel generoso vino. Ciò fatto si addormentò in un sonno così profondo, che durò una notte e due giorni consecutivi. I superiori del seminario stimarono quel sonno un assopimento foriero di morte, ma finalmente svegliatosi egli era guarito. Di questa malattia gli rimasero tuttavia alcuni residui, che, dopo varie vicende ed una terribile ricaduta, si dissiparono perfettamente mentre era al Refugio in Torino.
In questo anno più volte dovette ritornare a casa sua per provare di riaversi; ma la sua costanza, o direi meglio, la sua ostinatezza nell’applicarsi allo studio della teologia gli [483] meritò di poter il giorno 25 del mese di marzo 1840, domenica Laetare, ricevere la Tonsura coi quattro Ordini Minori nella chiesa arcivescovile di Torino.
In questi anni il nostro Giovanni non aveva per nulla interrotte le relazioni col suo antico maestro di Capriglio, pel quale aveva una grande venerazione. Soleva scrivergli dandogli sue notizie e di quando in quando facevagli visita. Ecco, fra altre, una lettera, che il buon maestro, il quale erasi presa cura di infondere nell’allievo sodi principii di divozione, gli scriveva:
Carissimo mio commendabile amico,
Ponzano, li 5 Maggio 1840.
Se avete tardato a scrivermi più lungamente di quello che vi pareva, che si conveniva all’amicizia che passa fra noi, la vostra obbligante e lunga lettera, pochi giorni sono pervenutami, piena di spaventevoli racconti, che vi siete compiaciuto di scrivermi, ha ristorato a mille doppi ogni tardanza di tempo, quantunque niuna dilazione merita riprensione in quelle cose, nelle quali non vi è alcuna necessità, che elle si facciano o si tralascino. Quanto a me io mi scuso con questo, che lo scrivere, secondo mia massima, non è dovere d’amicizia, se non quando importa all’uno o all’altro che si scriva, e in questo caso io non mancherò mai. Il vostro benestare e le vostre consolazioni consolano me e la vostra amantissima zia. Il Signore Iddio vi conceda la grazia di riuscire ben tosto un degno ministro della sua Chiesa, come mi fa sperare la vostra saggia ed edificante condotta.
Questo paese, privo di tutti i comodi necessari alla vita umana, è simile a quello di Capriglio. Qui io vivo come se [484] fossi in una vera solitudine, la quale per altro è sempre stata, la mia Rachele. Non sono ancora nel mio centro, e se il Signore mi fa la grazia di prolungarmi la vita ancora un poco, voglio dare un calcio generoso al mondo e vivo vivo seppellirmi in un convento. Giunto che sarà il tempo di venire a ritrovarmi, ricordatevi di portarmi i tre volumetti della sacra Bibbia. Al sig. Giuseppe Scaglia e alla di lui dilettissima famiglia, da cui il caso, o per dir meglio la divina Provvidenza mi ha di troppo allontanato, sarete contento di renderle salutazioni, che per lui da voi mi sono venute. Marianna sta bene secondo il suo solito, sicut in quantum; ella vi saluta ed io ancora di tutto cuore. Attendete a star sano e credetemi sempre
Vostro buon amico
PRETE GIUSEPPE LACQUA.
Il buon sacerdote in questa lettera palesa a Giovanni il proprio desiderio di farsi religioso; ciò induce a sospettare che da lui abbia appreso Giovanni il disprezzo manifestato tante volte per le ricchezze mondane, e forse abbia anche ricevuto la prima idea di consacrarsi a Dio in una Congregazione fin da quando era fanciulletto. Da questa lettera apprendiamo ancora come Giovanni continuasse i suoi studi sulla sacra Bibbia, della quale raccoglieva nella sua memoria tesori immensi, che gli giovarono mirabilmente nella sua benefica missione.
Mancava ancora qualche mese alla fine dell’anno scolastico, quando venne in seminario, mandato dal padre, il giovane Giorgio Moglia, per invitar Giovanni a tener al Ponte Battesimale il neonato ultimo suo figlio. Madrina sarebbe stata la figlia medesima del Moglia, la quale però si rifiutava, [485] ripugnandole comparire in chiesa a fianco di un ecclesiastico: solo cedeva al comando imperioso del padre. Giovanni vi andò; mia giunto alla parrocchia e saputo dal Sig. Moglia che madrina sarebbe stata la propria figlia, Giovanni gli rispose: – Non fa di bisogno; la madrina l’ho condotta io da Chieri. – Allora posso congedare mia figlia? disse il Moglia. – Fate pure! – E la figlia che era venuta a malincuore si dileguò. E chi farà dunque da madrina? riprese il Moglia. – La Madonna e la Chiesa: e ciò basta, esclamò Giovanni. – E al neonato fu imposto il nome di Giovanni.
Dopo il battesimo ed una piccola refezione, il chierico Questa si lamentò di sentirsi stremata di forze ed espresse il suo timore Bosco, prima di allontanarsi dalla Moglia, salì a visitare la signora Dorotea per salutarla di non riaversi più in salute. Giovanni le disse: – Fatevi coraggio e state di buon umore; voi giungerete fino all’età di novant’anni. – L’inferma guarì difatti e pose tutta la sua fiducia in questa promessa di Giovanni Bosco; dimodochè alcune volte, quantunque colpita da malattie anche gravi, non volle mai prendere i rimedi prescritti dal medico, perchè diceva: – D. Bosco mi ha assicurata che vivrò fino ai novant’anni. Sopravvissuta a D. Bosco stesso, tutti i giorni si raccomandava a lui, sicurissima che l’avrebbe esaudita dal cielo, e col ritratto dell’uomo di Dio, da lei tanto beneficato, sul petto, spirava in età di 91 anno.
Era un gran conforto pei benefattori del nostro Giovanni il pensiero che aiutandolo, cooperavano ai disegni di Dio; ma era grandissima la consolazione nell’essere certi di una corrispondenza affettuosa ed imperitura. Fra questi il teologo Cinzano non era l’ultimo ad avvedersene; poichè Giovanni non lasciava passare occasione per testificare al suo prevosto, [486] che prediligevalo con paterne cure, il suo amore figliale. A lui sovente indirizzava da Chieri lettere affettuosissime e non dimenticavasi di esprimergli i suoi augurii nelle ricorrenze più care dell’anno. E D. Cinzano conservava gelosamente tutte queste lettere che Giovanni Bosco gli indirizzò quando era studente, chierico e prete. Alla morte del buon vicario, nel 1870, chi fece lo spoglio de’ suoi archivii, per la fretta e l’inavvertenza, gettò anche queste corrispondenze alle fiamme insieme con altre carte inutili: troppo tardi si rammentò che molti di quei fogli bruciati erano firmati Giovanni Bosco. Perciò ci rimane solo una poesia da lui scritta in quest’anno per l’onomastico del suo prevosto. Questa, come tutte le molte altre sue poetiche composizioni che fece in varie circostanze, non sono dispregevoli; se non che le rime, le tronche in fine di strofa e molti versi dimostrano l’uomo che ha premura di non perdere un tempo preziosissimo, ma nello stesso tempo che ha gran cuore e vuole dar segno di affetto e di stima a’ suoi benefattori ed amici.
Nel giorno Onomastico
dell’Ill.mo e Molto R.do Signore
il teologo Antonio Cinzano
Prevosto e Vicario Foraneo di Castelnuovo.
INNO.
Era l’ora che grato sopore
Al mortal raddolciva le cure,
Che pensando a più liete venture
Obliava gli affanni del dì.
Ed io pur era in letto e dormia,
Quando un suono improvviso mi desta.
Guardo… miro…. e il mio sguardo s’arresta
Sovra un tal che mai visto non ho. [487]
Bianco lin le sue membra vestìa;
Colla manca stringeva un aurato
Vago serto, di fior circondato,
Che mi accese d’immenso stupor.
Colla destra una spada di foco
Arruotando, a me volge le piante.
Al fulgor parea l’Alto – Tonante;
Apre il labbro e mi parla così.
– Io sono un di quei sette Cherubi,
Che al gran Dio fanno gloria e corona.
Da cui nulla alla terra si dona
Che al mortal non si annunci per me.
Sono io pur che del mesto gli affanni
Offro e porgo al Supremo Motore
E alleviando l’ambascia e il dolore
Porto pace ove guerra sol è.
Sono io pur che alla prole di Adamo,
Tutta immersa nell’ombra di morte,
Annunciai di salute la sorte
Tanto tempo cercata, ma invan.
Questa spada è quell’arma potente
Che a Satan frange e tronca gli artigli;
Sicchè l’uom franco scampa i perigli
E cammina sul retto sentier.
Questo serto è quel pegno beato
Che l’Eterno a chi vince tien pronto,
Se fedel fino all’ultimo punto
Meco pugna con santo valor.
E tra quelli che fidi, che forti
Sotto il mio vessillo pugnâro
Avvi pur quell’Antonio sì caro
Che dà segni d’invitto campion.
Quel pastor che pel gregge di Cristo
Ogni cura e pensier tiene intento:
Pugna e affronta ogni rischio e cimento,
Onde a Cristo alme ree dirizzar.
Vedi tu questo libro indorato?
Entro ad esso sue gesta son conte.
Già bastanti perchè quella fronte
Sia adorna di gigli e di fior. [488]
In ciò dir, o Cinzano, indicava
A me lieto il tuo caro sembiante,
E mostrava che all’opre tue sante
Avvi un premio nell’alto dei ciel.
Io allor rispettoso a lui volto:
Deh, gli dissi, tu pronto l’aita
Nel cammin della flebile vita,
Nel cimento coll’oste infedel.
Sicchè porti trionfo e vittoria
Fino al tempo di placida morte,
E sia poi la beatifica sorte
Che coroni immortali i suoi dì.
Molto ancor volea dire: Ei fe’ cenno
Che ogni prece già intese ed accolse:
E una candida nube l’involse,
Brillò ancora un istante: e sparì.
Segno d’ossequioso rispetto.
Il 13 giugno 1840.
- GIOVANNI Bosco.
Due avvenimenti, in diverso modo memorabili, segnavano per Giovanni il fine di quest’anno. Egli stesso ne lasciò memoria. “In sul finir di quell’anno poco mancò non finissi di vivere. Mi trovava ancora nel seminario di Chieri. Era l’ultimo giorno, in cui i chierici dovevano partire per le case loro. Pioveva e me ne stava alla finestra guardando il cielo minaccioso. Quand’ecco, con un fragore immenso, cade il fulmine sul parapetto della finestra, alla quale era appoggiato. I mattoni svelti da quello sono slanciati contro il mio stomaco e mi gettano a terra svenuto in mezzo alla camerata. I compagni accorsi mi credettero morto, mi portarono in letto, mi lavarono la faccia, ma io rinvenni, sorrisi e balzai fuori dal letto. [489]” Terminato quell’anno, mi nacque il pensiero di tentare cosa, che in quel tempo rarissimamente si otteneva: fare cioè un corso nelle vacanze. Un giorno, discorrendo col teologo Cinzano, gliene feci parola in confidenza e questi con gioia approvò il mio progetto. A tale uopo, senza farne motto ad alcuno, mi presentai solo dall’Arcivescovo Fransoni, chiedendogli di poter istudiare i trattati del 4° anno in quelle vacanze e così compiere il quinquennio nel successivo anno scolastico 1840 – 41. Adduceva per ragione la mia avanzata età di 24 anni compiuti. Quel santo Prelato mi accolse con molta bontà, e verificato l’esito de’ miei esami fino allora sostenuti in seminario, mi concedette il favore implorato, a condizione che io portassi tutti i trattati corrispondenti al corso che desiderava di guadagnare, cioè il De Poenitentia dell’Alasia e il De Eucharistia del Cazzaniga. Il Teol Cinzano, mio vicario foraneo, era incaricato di eseguire la volontà del superiore. In due mesi ho potuto collo studio esaurire i trattati prescritti”.
Frattanto egli continuava a far ripetizione o scuola di latino, e fra coloro che in quelle vacanze frequentavano le sue lezioni ebbe l’onore di annoverare pure il giovanetto Giovanni Battista Bertagna, che poi fu il prestantissimo teologo, maestro di morale al convitto di S. Francesco di Assisi, Vescovo Titolare di Cafarnao ed Ausiliare del Cardinale Alimonda, Arcivescovo di Torino.
Nè tralasciava la predicazione. Il 26 luglio recitava il discorso di S. Anna in Aramengo e noi conserviamo negli archivii il prezioso manoscritto. Il 24 di agosto poi dovette prendersi quasi all’improvviso il discorso di S. Bartolomeo in Castelnuovo medesimo. Nel pomeriggio del giorno antecedente si trovava nel giardino della casa parrocchiale, assistendo a D. Ropolo vicecurato e ad un altro sacerdote, [490] che giuocavano alle boccie. Egli però stava appoggiato al muro del cortile colle braccia conserte assorto in pensieri. A un tratto giunge D. Cinzano parroco a1 annunciare d’aver ricevuto lettera che il predicatore, che doveva giungere all’indomani per dire le glorie di S. Bartolomeo nella confraternita di Castelnuovo, era non so se da qualche affare o da malattia trattenuto a casa, e quindi sarebbe toccato a D. Ropolo fare il panegirico del Santo Apostolo. D. Ropolo si schermi dicendo: – Da oggi a domani non è possibile prepararmi: se si trattasse di fare una spiegazione di vangelo, la cosa potrebbe andare; ma un panegirico è altro paio di maniche. – Anche l’altro prete declinò l’invito. D. Cinzano rimase alquanto soprapensiero ed esitante, riflettendo forse all’esame che Giovanni presto doveva sostenere: ma poi rompendo il silenzio: – Allora fallo tu, disse a Giovanni. – Questi si scosse dalla sua meditazione e sorridendo: – Quando non c’è altri, sono paratus ad omnia: farò la prova Il suo panegirico destò in tutti ed in ispecie nel clero, grande ammirazione. I compagni chierici ripetevano: – Eh! ci bagna il naso a tutti! – E Giovanni Filippello, che ebbe la consolazione di udirlo, ripeteva dopo 48 anni che questo gli era restato sempre impresso. Così attestava eziandio a noi lo stesso D. Ropolo.
Benchè intanto continuasse a radunare ogni domenica i fanciulli dei contadini e ponesse ogni sua compiacenza nella loro compagnia, sembra che, oltre le amicizie strette coi notabili di Castelnuovo e di Chieri, avesse eziandio famigliare relazione con alcune nobili famiglie, che abitavano nei castelli dei paesi all’intorno. Dico pare, perchè nelle sue memorie non vi è traccia alcuna di questo. Tuttavia in fronte al prima manoscritto che preparava per la biografia di Comollo sta la seguente frase: “Cenni storici sul chierico Luigi Comollo, [491] seminarista di Chieri, dedicati al giovane Luigi Larissé, conte ereditario”. Ce ne persuade pure la seguente traccia di lettera, indirizzata ad un giovane che tiene in casa il maestro. Questa circostanza indica la posizione sociale di colui, a cui scrive Giovanni. Egli lo rimprovera del tempo perduto e lo ammonisce a rimediare con una condotta più seria e più diligente per l’avvenire.
Castelnuovo, 28 Agosto 1840.
Mi rincresce sommamente, o sempre mio caro, che voi non abbiate potuto appagare i vostri voti e secondare le speranze de’ vostri genitori. Ma se voi ne cercherete il motivo radicalmente, vedrete che il torto è vostro. Imperocchè se da voi si fossero studiate quelle cose, che in iscuola ed in casa quotidianamente dal maestro vostro diligentissimo vi erano insegnate, non dovreste ora mirare i vostri compagni promossi alla scuola superiore e udirvi per voi una vergognosa negativa. Io non so se sia meglio far vacanza in tutto il decorso dell’anno e non esser promosso cogli altri compagni, oppure studiare quanto è possibile e così essere onorevolmente promosso alla classe superiore. Però se io dovessi consigliare qualcuno ad una di queste due determinazioni, io vorrei esortarlo a non sperare che i superiori siano elementi, ma considerarli come rigorosi e rigorosissimi, e così fare in modo che alla fine dell’anno si conseguisca la promozione per li propri meriti e non per la bontà de’ professori. Ma siccome molti la pensano altrimenti, così avviene che molti, ancorchè non vogliano, dovranno pentirsi del tempo perduto, quando appunto incominceranno vergognosi ad essere costretti a ritornare a casa colle trombe nel sacco. Dunque datevi pace e procurate dì rimediare al vostro male, coll’attendere l’anno [492] venturo con tutta serietà agli insegnamenti che vi verranno dal vostro precettore proposti ed allora mi troverete vostro affettuosissimo, quale sin d’ora mi protesto d’esservi
Intimo amico.
Bosco GIOVANNI.
La cerchia adunque dell’influenza benefica, che esercita Giovanni nella società, andava sempre più estendendosi, mentre si avvicinava al compimento de’ suoi voti e ad occupare quel posto nella Chiesa che la divina Provvidenza gli aveva destinato. Con tanta sollecitudine pertanto continuava il suo studio sotto la direzione del teologo Cinzano, sì da stancare il suo buon maestro nel fargli recitare le lezioni. Leggeva ogni giorno venti facciate degli autori assegnati, e talmente gli rimanevano impresse nella memoria, da non più dimenticarle. Così infatti ci scriveva e poi a voce ci narrava D. Febbraro, prevosto di Orbassano, nativo di Castelnuovo e chierico in quell’anno: “Il chierico Giovanni Bosco fece solo quattro anni di teologia non solo per l’età già un po’ avanzata, ma più per la sua abilità nelle teologiche discipline. Io fui testimonio auricolare dell’esame che subì per essere promosso al quinto corso. Il vicario, che faceva da esaminatore delegato dall’Arcivescovo, vedendo che Giovanni rispondeva letteralmente alle sue molteplici interrogazioni ed obbiezioni, stupito ed entusiasmato, benchè già conoscesse quanto valeva, chiamò noi giovani chierici ad essere testimoni di tale portento e in nostra presenza continuò quell’esame meraviglioso”.
Avvicinandosi il settembre, Giovanni ricevette avviso dal superiori del seminario di prepararsi a ricevere il sacro Ordine maggiore del Suddiaconato. Ecco come egli nelle sue memorie ci descrive questo importantissimo e decisivo avvenimento della [493] sua vita: “Non bastando la mia parte di beni ereditati dal padre per formarmi il patrimonio ecclesiastico voluto, mio fratello Giuseppe mi assegnò tutto quel poco che possedeva. Per le Ordinazioni delle quattro tempora d’autunno sono stato ammesso al Suddiaconato. Ora che conosco le virtù che si richiedono per quell’importantissimo passo, resto convinto che io non era abbastanza preparato; ma non avendo chi si prendesse cura diretta della mia vocazione, mi sono consigliato con D. Cafasso, che mi disse di andare avanti e riposare sulla sua parola. Nei dieci giorni di spirituali esercizi tenuti nella Casa della Missione in Torino ho fatta la confessione generale, affinchè il confessore potesse avere una idea chiara di mia coscienza e darmi l’opportuno consiglio. Desiderava di compiere i miei studi, ma tremava al pensiero di legarmi per tutta la vita; perciò non volli prendere definitiva risoluzione, se non dopo aver avuto il pieno consentimento del confessore. D’allora in poi mi sono dato il massimo impegno di mettere in pratica il consiglio del teologo Borel – Colla ritiratezza, e colla frequente Comunione si conserva e si perfeziona la vocazione”.
CAPO LIV.
Giovanni va ad Avigliana e predica sul S. Rosario – Visita la Sagra di S. Michele – Romantica passeggiata a Coazze – Festa a Bardella ed una sepolta viva – Riconoscenza di Giovanni verso la famiglia Moglia.
IN QUESTE vacanze il novello suddiacono Giovanni Bosco aveva preso l’impegno di tenere il discorso sul Santo Rosario ad Avigliana, patria dell’amico Giacomelli, il quale perciò ai primi di ottobre venne a Castelnuovo a pigliarlo, coll’intento pure di fargli fare una lunga passeggiata degna di memoria. In sul partire da Castelnuovo pertanto Giovanni si recò a salutare D. Cinzano, il quale congedollo con una frase, che ripeteva sovente al sentirlo predicare, nel vedere la sua attitudine al sacro ministero e la sua instancabile operosità: In omnem terram exivit sonus eorum et in fines orbis terrae verba eorum![112]
Siccome Giovanni soffriva terribilmente il moto della carrozza, cosi quel viaggio si fece tutto a piedi. Recaronsi dapprima a Chivasso ed ivi pernottarono. Venuti a Torino e comprate poche castagne e pane per rifocillarsi, dopo aver [495] eseguite varie commissioni, dello stesso giorno giunsero ad Avigliana.
In tutto il mattino della festa del Rosario Giovanni per nulla preoccupandosi di quello che avrebbe potuto dire sul pulpito, s’intratteneva cogli uni e cogli altri dei sacerdoti invitati. Giacomelli però tremava per l’amico, e di quando in quando avvicinandosi a lui, dicevagli sotto voce: – E la predica? – C’è tempo – rispondevagli Giovanni; il quale anche dopo pranzo continuò i suoi ragionari, specialmente col parroco D. Pautasso, che, incantato della sua erudizione, gli disse: – Mi pare che lei dovrà fare ancora mirabilia! Quando Giovanni salì in pulpito Giacomelli si ritirò trepidante in sagrestia, non volendo essere testimonio di un insuccesso oratorio dell’amico. Ma ben presto respirò, udendo la franchezza di esposizione e l’ordine e la forza degli argomenti dell’oratore. Quando Giovanni scese dal pulpito, D. Pautasso si avvicinò a lui e gli disse: – Mirabilia fecit.! Passata la festa del Rosario, i due amici si avviarono alla Sagra di S. Michele, che si eleva sul monte Pirchiriano, alto 877 metri, e dalla cui vetta si scopre in un sol colpo d’occhio l’intera vallea delle Alpi Cozie e quasi tutto il Piemonte. Quivi nel 1836, per invito di re Carlo, Alberto e coll’approvazione di Papa Gregorio XVI, in buon numero si erano stabiliti i Padri dell’Istituto della Carità, fondato nel 1831 a Domodossola dal celebre Antonio Rosmini e poi approvato dalla S. Sede nel 1839. Questi buoni religiosi, mentre uffiziavano l’antica chiesa, evangelizzavano con zelo apostolico le parrocchie della valle, di Susa e del confine di Torino. Il chierico Giacomelli pertanto condusse il suo amico a visitare gli avanzi colossali della magnifica Badia de’ Benedettini, il maestoso tempio gotico e le tombe di alcuni antichi principi di Savoia. Accolti con ogni cortesia da quei buoni Padri, tra essi e [496] Giovanni incominciò una relazione, che mai più doveva troncarsi. Il Padre Flecchia, allora giovane, che visse oltre i novant’anni, e gli altri suoi confratelli furono sempre caldi amici di D. Bosco e delle sue opere. Lassù avevalo condotto la divina Provvidenza, perchè, come vedremo, avesse agio di studiare una nuova forma di voto di povertà, colla quale nei tempi avvenire la Congregazione Salesiana, che avrebbe fondata, potesse andare esente dalle leggi di incameramento. Sembra che una simile idea gli fosse già brillata nella mente, come esso stesso più volte ci affermò. Ebbe forse la stessa intuizione di S. Paolo della Croce, che parve prevedere il saccheggio di tutti i beni ecclesiastici preparato dalla rivoluzione.
Bosco e Giacomelli, discesi da quell’altezza, presero la via che conduceva alla volta di Coazze in mezzo alle Alpi, dove era parroco D. Peretti, cugino di Giacomelli. I due chierici erano tanto contraffatti dal sudore, dalla polvere e dalla stanchezza, che i ragazzetti delle borgate, per le quali passavano, fuggivano spaventati. Giunsero a Coazze alle ore dieci di sera, che non ne potevano più. Nel paese regnava il più profondo silenzio, e le porte e le finestre della casa parrocchiale erano chiuse. Si tirò il campanello. Nessuno rispose. Si replicò il suono, e dopo un lungo indugio, si aperse una finestra che, in seguito a brevi parole pronunciate da una persona invisibile, si rinchiuse. L’aria dei monti, frattanto incominciava ad asciugare loro indosso, il sudore ed essi per i brividi battevano i denti. Un’ora intiera stettero fermi innanzi a quella porta, continuando di quando in quando a chiamare. Finalmente si aperse una seconda volta la finestra, e Giacomelli al comparire dì una testa, che si affacciava con precauzione: – Io son Giacomelli, si affrettò a dire; il cugino del parroco! [497]
– È proprio lei? rispose la serva con voce di persona mezzo addormentata.
– Ma sì; sono io! Non mi conoscete più?
– E quell’altro?
– Un mio amico!
– E perchè sono arrivati a quest’ora? – Il cugino un po’ impazientito: Perchè non abbiamo potuto venire più presto…. ma per carità veniteci ad aprire… siamo sudati…. corriam pericolo di una malattia.
– Scendo…. ma perchè venire così tardi?…. continuava a brontolare la serva ritirandosi.
Stettero ancora qualche minuto in quella poco gradita posizione; e quindi s’udì il rumore delle pianelle del parroco, che solo allora era stato svegliato ed il quale, affacciatosi col bianco berretto da notte, dopo un: – Oh sei tu? disse alla serva non ancor persuasa: – Va ad aprire.
I due chierici salirono. Il parroco, acceso il lume, li fece sedere ed incominciò la conversazione, che non volea finir così presto. Giacomelli rispose a varie interrogazioni; ma, essendo fradicio dal sudore, chiese al cugino se non fosse possibile avere un po’ di fuoco per asciugarsi? – Sì, volentieri…. rispose il parroco, e diede ordine alla serva di portare due fascine. La fantesca obbedì, fu accesa una bella fiammata e i due viaggiatori si avvicinarono al camino. Essi attendevano di essere invitati a cena, ma il parroco continuava a parlare sbadigliando, e la fantesca seduta in un angolo della sala altalenando il capo si era tranquillamente addormentata. Giovanni allora con un sorriso die’ un’occhiata all’amico: era da mezzogiorno che non aveano più preso cibo. L’altro intese, ed interrompendo la conversazione: – Cugino, disse, avreste mica un po’ di pane per isfamarci?
– Come? Avete ancor da cenare a quest’ora? [498]
– Intendi bene che per istrada non abbiamo incontrato che pietre.
– Potevate dirlo prima;…. io non ci aveva pensato…. scusate. Eih, Maddalena; preparate un po’ di cena.
La serva si svegliò e lentamente andò al fornello. Come Dio volle, la mensa fu preparata, si cenò e quindi si andò a dormire. Vi erano due letti in una stessa stanza, ma con soli lenzuoli e copertina. I due compagni si coricarono; l’aria della montagna in quella stagione non era certamente tiepida. Presi dal freddo, non potevano dormire, sicchè dopo breve ora uno incominciò a dire all’altro: – Non dormi? E l’altro a rispondere: – Sei sveglio? – Hai caldo? – Hai freddo? – Dormi, se puoi! – Riposa, se ci riesci! E qui una risata. Il parroco udì, levossi, prese alcune coperte e le gettò sui loro letti. Solo all’avvicinarsi dell’alba poterono riscaldarsi e prendere sonno.
- Bosco spesse volte raccontò a’ suoi giovanetti questa famosa passeggiata, infiorandone la narrazione, ma tacque una circostanza che ci fu svelata dal suo amico D. Giacomelli: che cioè i due parroci, presso i quali prese alloggio, uditolo a parlare con tanta precisione, assennatezza e vastità dì scienza, dissero: – Questo chierico deve riuscire qualche cosa di grande, di straordinario.
E qui non ci pare fuor di caso aggiungere come D. Bosco allora e poi sempre nelle tante case, ove ricevette ospitalità, non dimostrasse mai ripugnanze, pretensioni, disgusti. Tutto per lui andava bene. Scortesie, dimenticanze, imprevidenze, trascuratezze, incomodità, stanze soffocanti all’estate o prive di fuoco nei più crudi inverni, ritardi nell’apprestar la mensa, cibi non confacenti al suo stomaco, conversazioni fino ad ora tardissima, mentre era oppresso dal sonno, ogni cosa era a lui bene accetta, senza che mai palesasse noia od impazienza [499] o lasciasse sfuggire parola di lamento. Sempre eguale a se stesso, non estinguevasi mai sopra il suo labbro il sorriso affettuoso, che dimostrava in tutto la sua piena soddisfazione, allo stesso modo come usava diportarsi quando con squisite gentilezze e lautezze veniva accolto da’ suoi benefattori ed amici. Riconosceva ognora dalla carità cristiana quanto facevasi per lui, e il suo parlare sempre ameno e con fine spirituale, i suoi cordiali ringraziamenti e le promesse preghiere tenevano vivo negli ospiti suoi il desiderio di ospitarlo più altre volte.
Ritornato da questa escursione, Giovanni dovette andare a Bardella col suo parroco, pel servizio di quella chiesa me suddiacono nel giorno della festa. In quell’anno vi era per soprappiù un pranzo di nozze, cui intervenne il parroco ed il priore della festa; ma Giovanni, fedele al proponimento fatto, ritornò a sua casa. Al fine del pranzo, al solito incomposto e tumultuoso, il parroco, invitato dal priore, si recò alla casa di questo. Quand’ecco una sincope colpisce la sposa e muta in lutto la gioia universale. Le si prestano tutti i soccorsi possibili, ma finalmente si dice: – E morta! – Tale giudicandosi, dopo le quarant’otto ore è posta nella cassa e portata alla chiesa parrocchiale. Cantata messa, il convoglio funebre si avvia al cimitero. Vicini al cancello, uno dei portatori dice al parroco: – Sembra che la morta batta le pareti della cassa! – Quando voi sarete morto, non potrete prendervi simile divertimento – rispose il parroco. Tutti risero, perchè credettero essere un’illusione. La cassa fu messa in mezzo, alla cappella di S. Rocco e si intuonarono le ultime esequie. Sgombrato il cimitero dalla gente, portando il becchino la cassa sull’orlo della fossa, ode anch’egli nell’interno alcuni colpi distinti. Esterrefatto, prende un ferro per farne saltare il coperchio; ma ad un tratto si rimane per un’idea [500] malaugurata, che gli viene in mente: essere cioè proibito aprir un feretro, senza licenza delle autorità. Quindi corre in paese, avvisa il sindaco il quale, chiamato il medico, si affretta al cimitero. Scoperchiata la cassa, il medico trovò che la donna era calda ancora. Le tastò il polso e lo trovò che batteva; le fece un’incisione nella vena e il sangue usci in copia. Allora la fece trasportare subito al paese; ma la poveretta più non rinvenne e mori dopo poche ore. Giovanni accorso era stato testimone del fatto, e narrandolo concludeva essere proprio vero che ognora in questo mondo “al riso è mescolato il dolore e il lutto occupa gli estremi dell’allegrezza”[113].
Anche in queste vacanze Giovanni passò alla Moglia. Vi andò in compagnia di Giacomelli ed ivi cenarono, dormirono e furono trattati con molta cordialità. D. Bosco si mantenne sempre in ottime relazioni con questa cara famiglia, al cui capo professava stima ed affezione confidente. Venendo poi questi talvolta a Torino a visitarlo, era da lui ricevuto con grande festa. La signora Dorotea era così persuasa che il cuore riconoscente di D. Bosco avrebbe pregato efficacemente per lei, che in ogni necessità anche gravissima si faceva raccomandare a lui.
Ci narrava Giorgio Moglia: “D. Bosco dimostrò sempre una grande riconoscenza alla mia famiglia per quel poco, che avevamo fatto per lui. Moltissime volte mi fece sedere a mensa nell’Oratorio accanto a sè, eziandio quando era attorniato da’ suoi preti più rispettabili. Un giorno, rivolto a me, alla presenza di tutti i suoi religiosi e di altre persone estranee che sedevano con lui a pranzo, disse: – Questi è il mio antico [501] padrone! – E nei primitivi tempi dell’Oratorio, quando soli venticinque erano i giovanetti ricoverati, ogni anno li conduceva a Moncucco a fare una scampagnata, e voleva che noi considerassimo il suo Oratorio come casa nostra, allorchè per affari ci conducevamo a Torino. E ogni volta che ci incontravamo, mi raccomandava sempre di amare la preghiera, di accostarmi ai Sacramenti, di professare molta divozione verso Maria SS., di amar Dio e il prossimo e di essere fedele nel praticare tutti i doveri del buon cristiano”. Il suo figlioccio, Giovanni Moglia, ebbe eziandio prove della sua gratitudine. Fatto grandicello, venne a studiare nell’Oratorio, ove stette tre anni e D. Bosco lo volle sempre alla sua mensa. Nella divisione dell’eredità paterna toccò poi a Giovanni quella vigna, ove stava la vite legata dal venerando suo padrino, quando era fanciullo, la quale dopo 61 anno era pur sempre vegeta e fruttifera, mentre tutte le altre viti erano già state sostituite; e benchè un anno il servo avesse trascurato di bagnare questa sola colla soluzione di rame, essa continuò a rendere più frutto delle altre. Nel 1886, avendo D. Bosco dimostrato desiderio di quell’uva, Giovanni gliene portò in un canestrino alcuni grappoli. Così ci assicurava lo stesso Giovanni Moglia.
In questo autunno Giovanni fece pur conoscenza collo studente Gioachino Rho di Pecetto, che fu poi distinto professore di belle lettere e provveditore agli studii nella Provincia di Torino. Questi nel 1889 così scriveva a D. Piccollo, che dalla Sicilia avevagli mandato una sua orazione funebre su D. Bosco: “Avrei desiderato leggere nel suo lavoro un cenno di un nostro egregio compaesano il Teol. D. Antonio Cinzano, vicario di Castelnuovo d’Asti. Io mi ricordo che il buon prevosto si gloriava di aver avuto a suo discepolo D. Bosco e qualche altro suo parrocchiano, a cui prodigava le sue cure nelle vacanze autunnali, anche quando erano [502] chierici. E fu appunto nella casa parrocchiale di Castelnuovo che io conobbi D. Bosco verso il 1840, insieme con D. Febraro, poi parroco a d Orbassano, D. Allora ed altri, coi quali mantenni poi sempre relazioni di sincera amicizia”. Sia benedetta la memoria, di questo buon parroco, che passa i suoi giorni felici in mezzo alla cara famigliuola di chierici da lui formati.
CAPO LV.
Giovanni Bosco prefetto di seminario. – Splendido elogio del chierico Giuseppe Burzio. – Relazione fra questi due amici. – Avvicinamento di Giovanni all’Istituto degli Oblati di Maria Vergine.
RITORNATO Giovanni in seminario, fu annoverato fra gli studenti del quinto ed ultimo corso teologico, e per la esemplare sua condotta ed il profitto negli studii fu costituito prefetto, carica la più alta cui possa essere sollevato un seminarista, la quale lo costituisce superiore agli altri chierici e responsabile del loro diportamento.
Quale diligenza e quali sentimenti Giovanni avesse nell’esercizio di quest’onorevole ufficio ci è dato di poterlo raccôrre da uno splendido elogio, ch’egli fece di un pio giovanetto da lui assistito, il chierico Giuseppe Burzio, il quale nativo di Cocconato nel 1822, dopo varie vicende, nell’ottobre del 1840 indossava l’abito chiericale ed entrava nel seminario di Chieri, dove ebbe il nostro Giovanni a prefetto per circa un anno. Il 19 settembre del 1841, questo santo chierico, bramoso di darsi a vita più perfetta, entrava negli Oblati di Maria Vergine a Pinerolo, Congregazione canonicamente approvata con Breve di Leone XII nel 1826, ed ivi cessava di vivere il 20 maggio 1842, facendo una morte, veramente [504] preziosa al cospetto del Signore. Giovanni pertanto fu richiesto di sua testimonianza dal celebre oblato P. Felice Giordano, il quale in un suo libro stampato nel 1846 già dava a D. Bosco l’elogio di sacerdote degnissimo, e dopo la sua morte, con molte altre pagine di grande lode del nostro Fondatore, che a suo tempo esporremo, a testimonianza della sua santità scrisse le seguenti linee: “Nel mio libro intitolato: Cenni istruttivi di perfezione proposti ai giovani nella vita edificante di Giuseppe Burzio, a pag. 137 e seguenti trovasi una lunga lettera, che il sacerdote Giovanni Bosco mi indirizzava sotto la data 16 aprile 1843. Questa lettera sparge molta luce sul giovane sacerdote D. Bosco, dappoichè, anche scrivendo di un altro, ciò di un bravo chierico, di cui nel seminario di Chieri era stato prefetto, rivela abbastanza da quali sentimenti di pietà, di studio, di disciplina e di spirito ecclesiastico fin d’allora fosse egli medesimo penetrato. A rileggere quella lettera si direbbe che, dissertando egli sulla vita edificante di un giovane servo di Dio, senza avvedersene ritraesse se stesso”.
Ecco la lettera in discorso
“Richiesto dalla R. V. carissima di manifestare il mio sentimento riguardo la condotta tenuta nel seminario di Chieri dalla felice e sempre cara memoria del chierico Giuseppe Burzio, tanto più volentieri m’induco a farlo, in quanto che la mia posizione di prefetto, siccome diedemi l’opportunità d’osservarlo bene, così al presente mi mette in caso di poter esprimere con tutta esattezza la felice impressione che ne ho ricevuta.
A dire tutto in breve, io non saprei come meglio dipingere questo impareggiabile chierico per tutto quell’anno che passò a Chieri nel seminario, fuorchè dicendolo (e questa è voce unanime di tutti i suoi colleghi) un perfetto modello [505] cbiericale, giacchè egli aveva quanto ne’ libri e nelle istruzioni s’inculca relativamente alle doti convenevoli a un chierico, di modo che, da quanto io vidi e potei più volte osservare, sembrami che nel suo stato niente lasciasse a desiderare di più.
Ad ogni modo, ciò che eccitava spesso in me un sentimento di particolar meraviglia era il notare come egli fosse impegnatissimo, non solo ad iscansare nelle sue azioni ogni cosa menomamente disdicevole ad un chierico, ma ben più nel compierle con certa prontezza, grazia e ilarità, che innamorava.
Fin dal suo primo entrare in seminario, dimostrò chiaramente l’alta idea della vocazione da lui abbracciata, ed il suo fermo proposito di volersi in quella santificare, tanto s’appigliava egli con ardore ed accudiva con diligenza ogni mezzo, che ad un tal fine lo potesse condurre.
Dal mattino alla sera non si trovava indicazione nell’orario, a cui non fosse puntualissimo. Ad ogni articolo del regolamento dava la più grande importanza, e tutto con eguale esattezza e fedeltà osservava; ed in ciò procedeva libero e sciolto, operando per coscienza, senza mai esimersi o rallentare per qualche umano riguardo.
Con bella maniera, o piuttosto con prudente avvedutezza, si scansava da quei chierici, i quali nei loro andamenti mostrassero poco spirito ecclesiastico, e, sceltisi due o tre colleghi del medesimo corso e del medesimo genio, con questi procurava di trattenersi e di animarsi a vicenda nello stato intrapreso.
Sollecito quanto altri mai ne’ doveri di studio, grandemente li amava e faceva ogni suo possibile per profittarvi; impiegava tutto gelosamente il tempo dedicato ai medesimi, non vagando mai sopra altri libri, che non fossero quelli di scuola; volentieri partecipava ai circoli, ossia esercizi [506] scientifici della sua classe, e li animava del suo concorso; dove nelle dispute, se era commendevole per l’amore ed ansia che manifestava della verità, lo era anche più per quella discreta e rispettosa moderazione che osservava nel sostenerla.
Nelle ricreazioni amava pure di avere con chi illuminarsi ed esercitarsi in materie scolastiche. Qualora poi qualcheduno proposta avesse materia indifferente, egli si contentava di udire gli altri a discorrere; chè se la materia concerneva cose di studio o di pietà, tosto si vedeva, allegro a prenderne parte.
Nello studio comune non si vedeva mai neghittoso (giacchè l’ozio gli era affatto sconosciuto). Quivi postosi in un raccolto atteggiamento e fissata la mente ad una applicazione la più intensa, attendeva solo a se stesso, di modo che, avvenendo chi disturbasse con chiacchiere o altre leggerezze, egli pareva che nemmeno se ne avvedesse, alzando neppure gli occhi ad osservar ciò che si fosse; la sua avversione poi al diffondersi fuori in cose inutili, l’abito di stare in raccoglimento e l’osservanza del silenzio ne’ tempi debiti credo che non poco giovassero a facilitargli, come si vede, i notabili suoi progressi.
Ma ancor più grande fu il suo impegno nella pietà, in cui si rese veramente singolare. Io non posso riferire fuorchè ciò che cadde sotto gli occhi di tutti; ma chi conobbe la sincerità di questo chierico e la costanza nel bene, potrà facilmente congetturarne il più ed il meglio degli atti nascosti di sue interiori virtù.
Adunque non fu mai che alle pratiche religiose egli si portasse o vi attendesse con aria di indifferenza o per ispirito di costumanza; al contrario era mirabile per la contentezza e desiderio che ne mostrava nel volto; anzi appena cominciava qualche sacra funzione od esercizio consueto, per [507] esempio, della preghiera o della meditazione, o pur solamente metteva piede in cappella, componeva subito ad una santa apprensione tutti i suoi sensi, pel qual suo divoto contegno ognuno bene vedeva quanto vi partecipasse il suo cuore e quanto fosse lo spirito di fede che lo animava. Fossero poi o non fossero presenti i superiori, il pio procedere del Burzio era invariabilmente lo stesso, perchè ben si può dire di lui che ambulabat coram Deo.
Quanto ai Sacramenti, non solo osservava la frequenza che a tutti è prescritta in quel seminario, ma con premura in se stesso la promoveva, giovandosi di tutte le occasioni che venissero confessori, ciò che accadeva in tutti i sabati e nelle vigilie delle maggiori feste.
Oltre le pratiche religiose comuni a tutti, e da lui con gran fervore eseguite, potei accorgermi e dalle parole e dai fatti ch’egli era divotissimo di Gesù Sacramentato e della Madonna, a’ quali, se alcun tempo di sopravanzo gli rimaneva, consacrava tosto in affetti di amore e di gratitudine. Laonde, più volte il vidi, in tempo di ricreazione, e soprattutto ne’ giorni di vacanza, allontanarsi con bel modo da’ suoi compagni, recarsi in chiesa e trattenersi in dolci colloqui con Gesù Sacramentato e colla pietosissima sua Madre.
Il suo studio di perfezione lo portò a concertare con un suo confidente e pio compagno, che minutamente l’osservasse in tutti gli adempimenti de’ suoi doveri e d’ogni difetto lo correggesse senza risparmio.
Ma riguardo alla pietà, basti il dire che, venuto il fine dell’anno, ottenne per l’esemplarità della sua condotta un egregie da’ superiori, onore singolare e che raramente si concede in detto seminario.
Una virtù poi, che segnatamente lo distingueva, era la sua modestia, così rara e compita, che io non la saprei [508] esprimere, fuorchè chiamandola una modestia più celeste che umana. Nè per ciò si vedeva in lui ombra di caricatura, anzi grande cordialità e schiettezza, per cui, mentre formava la gioia de’ superiori, rapiva l’ammirazione degli stessi seminaristi; e per me confesso, che per l’attrattiva del suo modesto trattare, per la candidezza del suo parlare, che mostrava la sincerità e purezza dell’anima sua, mi sentiva più volte portato ad avvicinarlo e trattenermi con lui, tuttochè un notabile intervallo di studio e di età ci separasse, giacchè io era allora sul finire del corso di teologia.
Notevole sopra modo era la sua modestia negli occhi in qualunque circostanza, massime uscendo fuori dal seminario per la passeggiata e altro; ma in chiesa poi e nelle processioni l’avresti detto un angelo per quel suo semplice e divoto contegno degli occhi. In somma non sembrami alcuna esagerazione il dire che nel Burzio si vedeva effigiata quella modestia con tutti i suoi atti descritta e caldamente ai chierici raccomandata dal Tridentino in quel noto decreto: Sic decet, omnino clericos ecc.
Era nel tratto, cortese ed amorevole con tutti; ma succedendo che qualcheduno, per quelle sue graziose fattezze volesse fargli de’ vezzi sopra le spalle od in volto, egli tutto adontato: – Lasciami, diceva, lasciami stare; – e intanto subito spiccavasi di colà.
Nelle ricreazioni usava la più grande cautela nel parlare e trattare coi compagni. Coi superiori poi, siccome usava con sommo rispetto, così di essi parlava sempre con grande stima; nè fu udito mai lamentarsi degli apprestamenti di tavola, come avviene talora, o di altro; non sapeva darsi pace, che ad un alunno del santuario potessero uscire di bocca parole men che oneste, o contro la carità del prossimo, o di critica verso i superiori. [509]
Spiccò altresì in lui una singolare umiltà e mansuetudine, mentre quella sua irreprensibile condotta gli tirò addosso per qualche tempo il malanimo di alcuni, i quali, come a pretesa spia, fabbricarongli delle imputazioni presso i superiori; ma egli coll’umiltà, pazienza, mansuetudine tutto tollerò e seppe vincere col bene il male, sicchè ben tosto cessò, a lui la tempesta, ed a’ malevoli il sentimento di livore dovette cangiarsi in quello di venerazione e della più affettuosa, amicizia.
Sceltisi, così ci viene attestato, due o tre colleghi del medesimo corso e del medesimo genio, con questi procurava di trattenersi ed animarsi a vicenda nello stato intrapreso, ed il loro parlare, se già non era in materie scolastiche, era subito in cose spirituali appartenenti al fine sublime della vocazione ecclesiastica, e massime circa la fuga del mondo e lo zelo delle anime.
Piacemi quivi riferire alcuni detti, usciti più volte dalla sua bocca, il che servirà sempre più a mostrare la bellezza di quel cuore.
Una volta mi domandò con tutta confidenza qual mezzo io giudicassi più sicuro per avanzarsi nell’amore di Maria; al che risposto come meglio ho potuto, feci a lui questa interrogazione – Giudica ella che Maria possa molto in nostro favore? – Egli guardandomi con aria di ammirazione: – Oh sì che sarei un bel chierico, mi rispose, quando ne dubitassi! – Soggiunse poi: – Se non fosse un far torto a Dio, direi che Maria è a lui uguale, perchè quod Deus imperio, tu prece, Virgo, potes; ed il ripetè più volte, e voleva dire, secondo il sentimento dei SS. Padri, essere divenuta Maria onnipotente per grazia, come Gesù di Lei figlio lo è per natura.
Un’altra volta gli dimandai se stesse volentieri in seminario. Volentierissimo, mi rispose: perchè quivi posso, [510] veramente imparare a riuscire buon prete. – Desidera molto, io ripigliai, di farsi prete? – Lo desidero, mi disse, moltissimo.; ma l’imbroglio sta che, prima di diventar prete, bisogna che io diventi santo che diventi santo…… santo….. – Nè si stupisca la R. V. di tal parlare, poichè con chicchessia parlava da persona la più assennata e di virtù la più sperimentata; ed io bene posso dire d’aver più volte avuto occasione di restarne grandemente edificato.
Finalmente voglio notarle alcuni epiteti, che diedero al nostro chierico alcuni miei colleghi, da me a tal riguardo interrogati. Uno il chiamò modello di virtù; un altro, esemplare di modestia chiericale; un terzo, degno di sempre vivere per dare buon esempio; chi ancora, giovane singolare ed incomparabile per virtù. Molti mi domandarono, se non era ancora stampata la storia di sua vita, pregandomi di fare che ciò presto avvenisse. Un seminarista di Chieri, con lettera del 24 febbraio ora scorso, mi scrive: – La prego caldamente di significarmi, se la storia del Burzio già sia o no data alle stampe, e quando ciò fosse di mandarmene delle copie. E di questo la prego ben di cuore, non solo per me, come per molti altri.
Ecco quanto mi sono ricordato circa la condotta di lui in seminario, sebbene sia anche poco alla realtà e pienezza di quella bell’anima, cara a Dio ed agli uomini, di cui la memoria è in benedizione e lo sarà ognor più, se, come è grandemente desiderabile, ne uscirà in luce l’edificante sua vita.
Gradisca ecc.
Dal Convitto di S. Francesco, Torino, addì 16 Aprile 1843.
Sac. GIOVANNI BOSCO. [511]
Poscritta. “Mi parve anche bene di far leggere questa mia notificazione al suo prefetto di studio e di dormitorio, il quale volle sottoscriversi come segue:
“Io lessi la presente lettera del sacerdote Giovanni Bosco intorno alla condotta irreprensibile del defunto chierico Burzio, e dico contenere la verità, anzi credo aver detto, a mio parere, molto meno di quel che realmente era.
Posso aggiungere ancora, che, essendo io stato di lui prefetto e nello studio e nel dormitorio, giammai un ette ebbi a rimarcare di difetto in lui; ond’è che in sul cadere dell’anno scolastico, richiesto dal superiore del voto di pietà e di studio de’ giovani, giunto al Burzio, risposi al superiore scrivendo egregie, lagnandomi tra me e me che più in là di questo voto non si potesse andare.
Mi rallegro poi e mi consolo grandemente, che la S. V. M. R. si occupi a scrivere una vita sì degna d’essere mandata alla memoria de’ posteri.
Gradisca ecc.
Sac. D. ANTONIO GIACOMELLI.
Gli elogi che D. Bosco fa di Giuseppe Burzio ridondano a sua gloria, non solo perchè ci rispecchiano la sua stessa vita, ma ancora perchè ci richiamano alla mente la intimità che Burzio ebbe col nostro Giovanni e la venerazione che gli portava, tanto che di buon grado avrebbe voluto vederlo entrare esso pure nell’Istituto degli Oblati di Maria. Infatti D. Bosco cercava sempre a quale Ordine religioso avrebbe potuto ascriversi. Gli sembrava che il Signore lo chiamasse a questo stato. Bramava di essere religioso per obbedire: l’idea di essere libero e molto più quella di comandare lo spaventava. Parlando quindi sovente di vocazione religiosa [512] con Burzio, col quale era in molta confidenza, questi gli mise in cuore una certa velleità di farsi esso pure Oblato. Ed essendo qualche volta venuto in Torino a visitare l’amico al convento della Consolata, dato agli Oblati da Mons. Fransoni nel 1833, ed a pregare in quella chiesa così famosa per la divozione dei Torinesi, Burzio lo mise in relazione co’ suoi superiori, i quali cercarono di trarlo a sè e gli scrissero in proposito: ma egli non risolse di aderire al loro invito.
Tuttavia amichevoli continuarono le relazioni col Padre Felice Giordano, il quale in una sua lettera a D. Michele Rua in data del 1888 manifestava il suo amore, attaccamento e venerazione per l’antichissimo suo amico D. Bosco, nonchè coi Padri Balma e Barchialla, che poi furono Arcivescovi di Cagliari, e col Padre Dadesso ed altri Oblati. Egli quindi potè conoscere a fondo la storia, lo spirito, le regole di questo Istituto. Il suo fondatore Pio Brunone Lanteri, morto nel 1830, infaticabile zelatore della salute delle anime; istitutore di pie associazioni fiorentissime, tutte dirette a metter argine al male che serpeggiava dovunque, ad educare a’ sani principii della fede e della morale ed alla devozione della causa monarchica la gioventù piemontese, a diffondere in gran copia libri di sana dottrina e cristiana pietà; era stato un santo ministro del Signore, pel quale l’amore al Papa fu vita della sua vita. In tutto il tempo che Pio VII stette prigioniero in Savona, egli con grande suo pericolo aveva trasmessi clandestinamente al Pontefice documenti importantissimi pel governo della Chiesa e generose oblazioni che per lui raccoglieva in Torino; e venuto in sospetto alla polizia napoleonica, aveva sofferte due minute perquisizioni domiciliari, benchè senza risultato, e la relegazione per quattro anni nella sua villa di Bardassano. Scrittore dotto e popolare, diffuse fra i cittadini molti opuscoli, ora stampati ed ora [513] tracopiati, quando non era prudenza darli alle stampe, per tener vivo ne’ fedeli l’amore, la venerazione, l’obbedienza al Papa, dimostrandone la dignità, le prerogative e l’infallibilità de’ suoi giudizii dati ex cathedra. E tutto questo suo spirito il Padre Lanteri avealo trasfuso nella Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, prefiggendole per iscopo il dettare esercizii spirituali al popolo, studiare e combattere gli errori correnti, consecrarsi al perfezionamento del giovane clero, farsi scudo e sostegno, quanto più si poteva saldissimo, del Romano Pontefice. E la sua regola nulla aveva d’austero o d’esteriorità monacale, mentre inculcava la perfezione e il fervore degli Ordini più stimati e più utili della Chiesa di Dio.
La divina Provvidenza adunque, avvicinando D. Bosco agli Oblati di Maria Vergine, pare che compisse quel misterioso lavorio di preparazione incominciato a Morialdo e gli facesse brillare innanzi agli occhi della mente l’idea di quella Pia Società, la quale con un disegno più vasto e con maggior varietà di fini doveva in sè comprendere i varii stati, nei quali avealo esercitato da fanciullo e da giovane adulto. Nel Padre Lanteri presentavagli il modello di un fondatore di Congregazione religiosa, alieno però da ogni passione politica, quale lo richiedeva il bene de’ tempi che si andavano maturando; e così pure nell’Istituto degli Oblati la forma che più conveniva al sodalizio che voleva da lui fondato e sparso su tutta la faccia della terra, spogliò di ogni carattere o costumanza esterna che desse pretesti di animosità agli avversarii degli Ordini religiosi.
CAPO LVI.
Giovanni subisce gli ultimi esami di teologia – Magnifiche lodi a lui tributate dai condiscepoli – Gli esercizi spirituali in preparazione all’ordinazione sacerdotale – La prima Messa di D. Bosco – L’efficacia della parola – Sublimi ammonimenti di mamma Margherita.
ORMAI siamo giunti al termine della prima parte del nostro racconto. Giovanni Bosco a grandi passi si avanza verso il compimento de’ suoi ardenti voti, verso il giorno sospiratissimo della sacerdotale sua ordinazione, che gli schiuderà dinnanzi un immenso orizzonte per la salute delle anime. Egli era languido, bisognoso d’aiuto, privo di forze e ricco di miseria; ma l’occhio di Dio lo mirò benignamente, lo sollevò dal suo abbattimento e gli fe’ alzare la testa; motivo per cui noi vedremo molti restare ammirati e rendere gloria al Signore[114].
Rientrato in seminario, Giovanni, si presentò all’esame che si suol dare sul principiar dell’anno ed ottenne, secondo il solito, un optime, come risulta dalle memorie dei voti meritati da ogni seminarista scritte dal Prof. Appendini e che noi conserviamo. [515]
Una piccola umiliazione però preparavagli il Signore, prima di lasciar il seminario. Nel secondo esame, che diede il 17 febbraio 1841, non conseguì che fere optime. Essendo esaminato dal Teol. Dott. Lorenzo Gastaldi, interrogato sopra un punto che o non aveva avuto tempo a studiare o che forse non credeva materia d’esame, senza scomporsi improvvisò e abborracciò un canone del Concilio di Trento con quelle frasi che gli vennero in mente. – E proprio così che dice il Concilio? chiese Gastaldi maravigliato di tanta franchezza. D. Bosco si mise a ridere sicchè fe’ ridere pure l’esaminatore. Al Sabato Sitientes del 1841, avanti la Domenica di Passione venne promosso al Diaconato. Il 15 maggio subiva l’esame per l’ultima ordinazione e riportava un plus quam optime. Era antica consuetudine nel seminario di Chieri, che i superiori nello scadere di ogni anno scolastico si radunavano a concilio e addivenivano ad un diligente scrutinio sulla condotta di tutti e singoli i seminaristi, di cui prendevasi nota da conservarsi negli archivi. Or bene nei registri della Curia di Torino ove si legge l’elenco dei chierici dell’anno 1841, all’articolo osservazioni, a fianco del nome Giovanni Bosco sta notato: “Zelante e di buona riuscita”.
L’anno scolastico era finito e per Giovanni si trattava di uscire definitivamente dal seminario. Quello fu per lui un giorno di vera costernazione. “I superiori mi amavano, così scrive egli stesso, e mi diedero continui segni di benevolenza. I compagni mi erano affezionatissimi. Si può dire che io viveva per loro, essi vivevano per me. Perciò mi tornò dolorosissima quella separazione, separazione da un luogo dove era vissuto per sei anni, dove ebbi educazione scienza, spirito ecclesiastico e tutti i segni bontà e di affetto che si possano desiderare”. [516] E qui, prima di passar oltre, ci sia concesso di raccogliere, come fiori stretti in un mazzo, le attestazioni che fecero a noi in lode di D. Bosco i compagni di seminario. È un vero plebiscito di affetto, di stima, di venerazione pel nostro Giovanni. D. Antonio Giacomelli: – Fin dai primi giorni che io lo conobbi in seminario, lo considerai come se fosse già prete per la sua assennatezza e morigeratezza. – Il Teol. Carlo Allora: – In seminario diede esempi preclari di pietà e di obbedienza. Tanta era la stima che di lui avevano i chierici, che lo consideravano più che compagno, superiore. Noi fin da quei tempi lo tenevamo come santo. – D. Francesco Oddenino: – Il chierico Bosco occupava minutamente il suo tempo; era dato ad una assidua lettura, i compagni soleano andargli intorno per interrogarlo su disparate materie, essendo sorprendente la sua erudizione; godeva presso tutti grande stima di virtù e di pietà. – Il teologo Albino Massa, parroco di Corio: – In seminario fu il modello dei chierici. – D. Vincenzo Sosso, canonico onorario della collegiata di Moncalieri: – In seminario lo chiamavamo il Padre, tanta era la sodezza, compostezza e regolarità della sua vita. – D. Grassini, prevosto di Scalenghe: – D. Bosco era paciere tra compagni e compagni. – Il Teol. D. Giovanni Ferrero, parroco di Pontedarano e poi canonico arciprete del duomo di Biella: – Molti chierici compagni di D. Bosco mi assicurarono che egli in seminario tenne una condotta lodevolissima e che era in Chieri un Bosco già fin d’allora molto prezioso. – Molti altri ci ripeterono: Questo nostro amabile compagno in seminario era tenuto in gran conto per santità di vita. – D. Bosio, parroco di Levone Canavese: – Fui suo compagno per cinque anni in seminario e altri cinque tra Convitto e Rifugio; e non scopersi mai in lui il minimo difetto: anzi ogni virtù la vidi da lui praticata con perfezione. – Mons. Giov. Battista Appendini, suo [517] professore di teologia: – Il chierico Bosco per pietà e per studio fece molti progressi in seminario, senza averne le apparenze, a cagione di quella sua bonarietà che fu poi il carattere di tutta la sua vita. – Un chierico salesiano, che, ascritto nella milizia, faceva il campo a Giaveno, avendo udito che il teologo Arduino, canonico prevosto, vicario foraneo in quella collegiata, era stato maestro di D. Bosco in teologia nel seminario di Chieri, si fece un dovere di andarlo a visitare, dichiarandogli la sua condizione e presentandogli i suoi ossequi. – D. Giovanni! esclamò quel venerando sacerdote colle lagrime agli occhi; io lo ricordo, rammento ancora quando era mio scolaro; era pio, diligente, esemplarissimo. Certo nessuno a quel tempo avrebbe pronosticato di lui quel che è adesso. Ma debbo dire che il suo dignitoso contegno, l’esattezza, con cui adempiva i doveri suoi di scuola e di religione, erano cosa esemplare. Come sta ora? Oh mi ricordi a lui quando ritorni a Torino e le sue preghiere mi ottengano la grazia di ben morire!
Il giorno 26 maggio, festa di S. Filippo Neri, D. Bosco veniva a Torino e incominciava gli esercizi spirituali nella Casa dei Signori della Missione. “Li fece in modo edificante, afferma D. Giacomelli; era compreso in modo straordinario delle parole del Signore, che udiva nelle prediche, e specialmente da quelle espressioni che indicavano la grande dignità che avrebbe fra poco conseguita: – Chi salirà al monte del Signore? o chi starà nel suo santuario? Chi potrà dirsi degno di essere ministro di Dio e trattare i suoi sacrosanti e tremendi misteri? – E il chierico Bosco, parlando co’ suoi confidenti, si mostrava tutto compreso di ciò che risponde il Salmista alla suddetta interrogazione: – Colui che ha pure le mani e mondo il cuore e non ha ricevuta invano l’anima sua, facendola servire a Dio e non alle passioni. Questi avrà [518] benedizione dal Signore e misericordia da Dio suo Salvatore[115].
In un suo quadernetto troviamo scritto quanto segue “Conclusione degli esercii fatti in preparazione alla celebrazione della prima mia santa Messa: Il prete non va solo al cielo, nè va solo all’inferno. Se fa bene, andrà al cielo colle anime da lui salvate col suo buon esempio; se fa male, se dà scandalo, andrà alla perdizione colle anime dannate pel suo scandalo. Quindi metterò ogni impegno per osservare le seguenti risoluzioni:
- Non mai far passeggiate, se non per grave necessità, visite a malati, ecc.
- Occupar rigorosamente bene il tempo.
- Patire, fare, umiliarsi in tutto e sempre, quando trattasi di salvar anime.
- La carità e la dolcezza di S. Francesco di Sales mi guidino in ogni cosa.
- Mi mostrerò sempre contento del cibo, che sarà apprestato, purchè non sia cosa nocevole alla sanità.
- Beverò vino adacquato e soltanto come rimedio: vale a dire solamente quando e quanto sarà richiesto dalla sanità.
- Il lavoro è un’arma potente contro ai nemici dell’anima; perciò non darò al corpo più di cinque ore di sonno ogni notte. Lungo il giorno, specialmente dopo il pranzo, non prenderò alcun riposo. Farò qualche eccezione in caso di malattia.
- Ogni giorno darò qualche tempo alla meditazione ed alla lettura spirituale. Nel corso della giornata farò breve visita, o almeno una preghiera al SS. Sacramento. Farò almeno [519] un quarto d’ora di preparazione ed altro quarto d’ora di ringraziamento alla santa Messa.
- Non farò mai conversazioni con donne, fuori del caso di ascoltarle in confessione o di qualche altra necessità spirituale.
Queste memorie furono scritte nel 1841. Nel noto suo manoscritto D. Bosco scrive ancora quanto segue:
“Il giorno della mia ordinazione era la vigilia della SS. Trinità, 5 di giugno, e fu tenuta da Mons. Arcivescovo Luigi Fransoni nell’episcopio. La mia prima Messa l’ho celebrata nella chiesa di S. Francesco d’Assisi, dove era capo di conferenza D. Giuseppe Cafasso, mio insigne benefattore e direttore. Era ansiosamente aspettato in mia patria, ove da varii anni non si era più celebrata Messa nuova; ma ho preferito celebrarla in Torino senza rumore, all’altare del S. Angelo Custode, posto in questa chiesa dal lato del Vangelo. In questo giorno la Chiesa universale celebrava la festa della SS. Trinità, l’archidiocesi di Torino quella del Miracolo del SS. Sacramento, la chiesa di S. Francesco di Assisi la festa della Madonna delle Grazie, quivi onorata da tempo antichissimo, e quello posso chiamarlo il più bel giorno della mia vita. Nel memento di quella memoranda Messa ho procurato di fare devota menzione di tutti i miei professori, benefattori spirituali e temporali, e segnatamente del compianto D. Calosso, che ho sempre ricordato come grande ed insigne benefattore. È pia credenza che il Signore conceda infallibilmente quella grazia, che il nuovo sacerdote gli domanda celebrando la prima Messa: io chiesi ardentemente l’efficacia della parola, per poter fare del bene alle anime. Mi pare che il Signore abbia ascoltato la mia umile preghiera”,
- Bosco nella sua umiltà dice semplicemente mi pare; ma quanti lo conobbero, poteron vedere come abbia ottenuta con meravigliosa abbondanza la grazia dimandata. Nel corso del [520] suo ministero, sia in privato sia in pubblico, parlando, predicando, confessando, talmente s’impadroniva dei cuori, da trarli a Dio e spingerli a virtuose e generose risoluzioni, mettendo in molti i germi di una soda santità, feconda di grandi opere. Colla sua parola ammaliava, diremmo, i giovanetti: li faceva buoni se erano cattivi, e i buoni li portava nella via della perfezione, specialmente proponendo loro l’imitazione di S. Luigi Gonzaga, che loro aveva dato per protettore. Un numero infinito di volte un semplice suo motto operava portenti, mutando istantaneamente le volontà e suscitando meravigliose vocazioni religiose.
E come poteva essere altrimenti, se, oltre l’intrinseco infinito valore dell’incruento sacrificio, oltre la convenienza indubbia di una grazia necessaria per la sublime missione intimatagli dallo stesso Divin Redentore, D. Bosco aveva celebrati i santi misteri con quell’ardore di fede, speranza, carità, che solo alberga ne’ cuori de’ più intimi amici di Dio? Ne è prova luminosa l’amore di serafino, col quale egli continuò a celebrare la santa Messa fino all’estremo di sua vita. Moltissimi ci affermano ciò che noi d’altronde provavamo ogni giorno. – Abbiamo assistito tante e tante volte alla sua Messa, ma in quel frattempo sempre s’impossessava di noi un soave sentimento di fede, nell’osservare la divozione che traspariva da tutto il suo contegno, la esattezza nell’eseguire le sacre cerimonie, il modo di pronunciare le parole e l’unzione onde accompagnava le sue preghiere. – E l’edificante impressione ricevuta non cancellavasi mai più. Ovunque andasse, eziandio fuori d’Italia, il sapersi l’ora e il luogo dove D. Bosco celebrava, bastava per radunare gente intorno al suo altare. Per soddisfare l’ardente desiderio di gustare anche una volta questa grande consolazione, molti fecero, con questo solo scopo, lunghi viaggi per venire a Torino; ove, allorchè D. Bosco [521] usciva parato dalla sagrestia per avviarsi alla cappella di S. Pietro, centinaia di persone divote, sparse per la chiesa, lasciavano i loro posti per aggrupparsi intorno a lui. – È un santo! è un santo! – ripetevansi poi a vicenda sottovoce, quando la Messa era finita.
Il lunedì dopo la Trinità D. Bosco andò a celebrare la sua seconda Messa alla chiesa della Consolata, per “ringraziare, com’egli scrisse, la Gran Vergine Maria degli innumerabili favori, che mi aveva ottenuto dal suo Divin Figliuolo Gesù.
Martedì, continua egli, mi recai a Chieri e celebrai Messa nella chiesa di S. Domenico, dove tuttora viveva l’antico mio professore P. Giusiana, che con paterno affetto mi attendeva. Durante quella Messa egli pianse sempre per commozione. Ho passato con lui tutto quel giorno, che posso chiamare di paradiso.
Mercoledì offersi il santo Sacrifizio nel duomo di quella città.
Il giovedì, solennità del Corpus Domini, appagai i miei patriotti e mi recai a Castelnuovo, ove cantai Messa e feci la processione di quella solennità. Il prevosto volle invitare a pranzo i miei parenti, il clero, ed i principali del paese. Tutti presero parte a quella allegrezza; perciocchè io era molto amato da’ miei cittadini ed ognuno godeva di tutto quello che avesse potuto tornare a mio bene. La sera di quel giorno mi restituii in famiglia. Ma, quando fui vicino a casa e mirai il luogo del sogno fatto all’età di circa nove anni, non potei frenare le lagrime e dire: – Quanto mai sono meravigliosi i disegni della divina Provvidenza! Dio ha veramente tolto dalla terra un povero fanciullo per collocarlo coi primarii del suo popolo
Mia madre in quel giorno, avutomi da solo a solo, mi disse queste memorabili parole: – Sei prete: dici la Messa: [522] da qui avanti sei adunque più vicino a Gesù Cristo. Ricordati però che incominciare a dir Messa vuol dire cominciare a patire. Non te ne accorgerai subito, ma a poco a poco vedrai che tua madre ti ha detto la verità. Sono sicura che tutti i giorni pregherai per me, sia ancora io viva o sia già morta; ciò mi basta. Tu da qui innanzi pensa solamente alla salute delle anime e non prenderti nessun pensiero di me”
Oh! santa e generosa madre, che aveva fatto miracoli come narrava D. Cinzano, di sacrìfizi, di privazioni, di pazienza, di umiliazioni per aiutare il figlio a farsi prete. E il Signore l’aveva conservata, perchè potesse baciare la mano consacrata del suo Giovanni. Alcun tempo prima infatti dessa era salita sopra di un gelso a grande altezza per fare foglie e provvederne i bachi da seta; ma ad un tratto si ruppe il ramo, sul quale stava, e cadde battendo sul suolo e restando fuori dei sensi. Rinvenendo, si accorse con meraviglia di non essersi fatto alcun male; se non che, mentre ancor seduta per terra ringraziavane il Signore, le cadde sopra il ramo spezzato, causa di quell’infortunio, e battendole sulla fronte lasciolle un segno che portò finchè visse.
Quanto è buono adunque il Signore per coloro che lo temono! In quanti modi ricompensò Margherita per avergli gelosamente custodito il sacro deposito, che le aveva consegnato nella persona del figlio Giovanni. Sta scritto: “Chi istruisce il proprio figlio, ne ritrarrà onore e di lui si glorierà colla gente di sua famiglia”[116]. E immortale sarà il suo nome eziandio sovra la terra.
Ma il premio più sentito e più caro a Margherita sarà nel veder giganteggiare nel cuore del figlio le virtù, delle quali [523] ella pose il seme; nel leggere ne’ suoi sguardi la pace esuberante della coscienza; nel gustare la sua inalterabile felicità per aver corrisposto alla divina vocazione, nel saperlo unicamente intento a promuovere la gloria di Dio; nell’osservare il visibile e continuo aiuto prestato dalla divina Provvidenza alle sue intraprese; nello scorgerlo sempre anelante alla salvezza delle anime, alla distruzione del peccato; nel sentirlo pieno di quella gioia, che accende il pensiero della presenza di Dio, così descritta dal Reale Profeta: “Io canterò il Signore, finchè vivrò; inneggerò al mio Dio, finchè io sarò. Sia accetto a lui il mio carme: quanto a me la mia gioia sarà nel Signore. Spariscano dalla terra i peccatori e gli empi più non esistano. Benedici anima mia il Signore”[117].
[1] Ristretto del processo sino in fine ecc., sentenza nella causa Maceratese. ANELLI, I, 85
[2] GUALTERIO, Rivolg., V. I, doc. 4, pag. 167 e seguenti
[3] RICCIARDI, Storia d’Italia dal 1850 al 1900, c. 19, pag. 33. Parigi 1842
[4] FARINI, Stato Romano, I, 101..
[5] XXIV, 5 – 6
[6] XXXVII, 17 – 19
[7] Ecclesiastico XL, 18
[8] Ecclesiastico XXVI, 3 – 4, 2
[9] I Tim. VI, 6 – Prov. XV, 16
[10] Efes. V, 33
[11] Prov. XV, 15
[12] Ecclesiastico XXVI, 18, 24
[13] Ecclesiastico III, 13
[14] Salmo XXXVI, 25
[15] Ecclesiastico VII, 25
[16] Ecclesiastico XXX, 8
[17] Ecclesiastico XXX, 9, II
[18] Prov. XXII, 6
[19] Ecclesiastico III, 5
[20] Sapienza VI, 14, 15, 17- 21
[21] XX, 11, XXIX, 17, XX, 12
[22] Efes. VI, 4
[23] Prov. XXIII, 26
[24] Prov. XIII, 24, XXII, IS, XXIX, 15
[25] XIX, 18
[26] Prov. XXIII, 13- 14
[27] Ecclesiaste IX, 7 – 8
[28] Proverbi XV, 5
[29] Ecclesiaste IX,10
[30] XXX, 4 – 6
[31] Ecclesiastico XXXIV, 16. – Salmo XC, 5 – 6
[32] Ecclesiastico XXXIII, 29
[33] CXVIII, 100
[34] LI, 18 – 25
[35] XXI, 23
[36] Ecclesiastico VI, 37
[37] Rom. VIII, 28
[38] LI, 26 – 28
[39] Prov. XXVII, 2
[40] II, 28
[41] Geremia I, 7 – 8, 19
[42] Ecclesiastico, XXX, 14- 16
[43] Prov. XXVII, 19
[44] IV, 1 – 2
[45] Iª Corint. I, 27 – 29, 31
[46] XXXI, 18
[47] Giobbe XXXI, 32
[48] CXXVIII, 7
[49] XXVI, 19 – 22
[50] Salmo IX, 34
[51] Prov. XV, 33
[52] Ecclesiastico XI, I
[53] Ecclesiastico IV, 18
[54] Ecclesiastico XXXVIII, 25
[55] XXVII, 18
[56] Sap. X, 10
[57] Prov. XVII, 6
[58] Ecclesiastico XLI, 15
[59] Prov. XXIII, 24- 25
[60] Ecclesiastico XXXI, 8
[61] Ecclesiastico VI, 5
[62] Psal. LXX, 23
[63] Ecclesiastico XXXII, 15
[64] Ecclesiastico III, 20
[65] Ecclesiastico XXXIV, 9
[66] XXXIV, 1- 2, 5 – 8
[67] Ecclesiastico VI, 6, 13
[68] Ecclesiastico III, 19
[69] Prov. XXVII, 5
[70] XXII, I
[71] Psal. XV, S.
[72] Psal. LXXII, 25
[73] Levit, XXVI, 2
[74] Ecclesiaste III, 1
[75] Prov. XII, 21
[76] I Rev.mi Padri Francescani conservano il seguente documento, del quale cortesemente ci diedero copia: – Anno 1834 receptus fuit in conventu S. Mariae Angelorum Ord. Reformat. S. Francisci juvenis Joannes Bosco a Castronovo nàtus, die 17 augusti 1815 baptizatus, et confirmatus. Habet requisita et vota omnia. – Die 18 aprilis.
Ex libro II, in quo describuntur juvenes postulantes ad Ordinem acceptati et approbati ab anno 1638 ad annum 1838.
PADRE COSTANTINO da VALCAMONICA
Brescia per Rezzato
[77] Prov. XIV, 33
[78] Prov. XVIII, 24
[79] Prov. XXV, 10
[80] V, 19 – 20
[81] Ecclesiastico VI, 16 – 17
[82] Ecclesiastico XXV, 12; VI, 14 – 15
[83] Ecclesiastico VI, 12
[84] Ecclesiastico IV, 9
[85] Prov. XVIII, 17
[86] Prov. XXVII, 9
[87] Prov. XVII, 17
[88] XXXI 12 e seg. XLI, 24
[89] XXXII, 10
[90] Salmo, XV, 6
[91] Ecclesiastico XXX, 27
[92] Rom. XII, 15
[93] Sapienza XVII, 11
[94] Salmo LXXXVII, 16
[95] Ecclesiastico IX, 23
[96] Prov. XXVII, 17
[97] Ecclesiastico XXXIX, I
[98] Ecclesiastico, XXXI, 38
[99] Prov. XXIII, 20
[100] XLIII,20
[101] VI, II
[102] Proverbi X, 32; Ecclesiastico XL, 21
[103] XXX, 22
[104] Filipp. IV, 4
[105] I Corint. VII, 7
[106] Ecclesiastico VI, 36
[107] PREDARI, I primi vagiti della Libertà in Piemonte, pag. 126, Milano, 1861
[108] Salmo II, 8
[109] Matt. XXVIII, 18
[110] Atti Ap. V, 29
[111] I Petr. II, 13, 14
[112] Salmo XVIII, 4
[113] Prov. XIV, 13
[114] Ecclesiastico XI, 12
[115] Salmo XXIII, 3
[116] Ecclesiastico XXX, 2
[117] Salmo CIII, 33
Copyright © 2010 Salesiani Don Bosco – INE
Periodo di riferimento: 2024